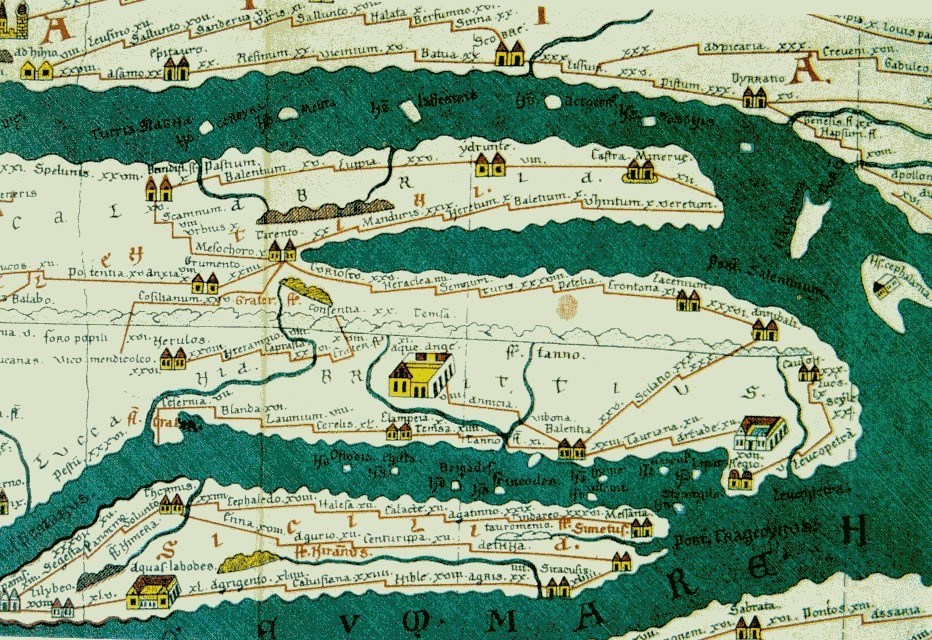La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV)

Le estremità della penisola italiana nella carta medievale (sec. XIII) nota come “Tabula Peutingeriana”, ritenuta copia di un originale romano andato perduto (300 d.C. ca.).
In tempi in cui a vario titolo e ragione, ci sentiamo Italiani o stranieri, autoctoni o forestieri, cittadini del nostro Paese o Europei, può essere utile recuperare localmente, la storicità dei nomi che utilizziamo per esprimere tali concetti. Ciò che essi racchiudono, in relazione ad una supposta appartenenza, confrontato con le reali ricadute ed i numerosi risvolti nella nostra vita di tutti i giorni, dovrebbe indurci ad una riflessione.
Italo e gli Italiani
“Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, terra antiqua, potens armis, atque ubere glaebae; Oenotrii coluere viri; nunc fama minores Italiam dixisse ducis de nomine gentem …”.[i]
All’epoca di Augusto l’Italia (Ἰταλíας) iniziava alle “falde delle Alpi”,[ii] terminando “con due punte”, la prima che finiva allo “stretto di Sicilia”, la seconda “al capo Iapigio”, l’odierno promontorio di Santa Maria di Leuca.[iii] Più tardi anche Servio (fine IV – inizi sec. V d.C.), citando Sallustio (sec. I a.C.), affermava che la penisola italiana si scindeva “in duo promunctoria, Brittium et Sallentinum”.[iv]
Strabone (sec. I a.C.-I d.C.), attingendo all’antica opera “Sull’Italia” di Antioco di Siracusa (seconda metà del sec. V a.C.), contrariamente a quanto riporta molto più tardi Stefano Bizantino (sec. VI d.C.) riferendo circa lo stesso autore,[v] affermava che, con questo nome, gli “antichi” chiamavano solo la regione precedentemente detta “Enotria” (Οἰνωτρίαν) che, dallo “Stretto di Sicilia”, giungeva fino al golfo di Taranto ed a quello di Posidonia, ovvero quella limitata tra il fiume Laos, dalla parte del Mar Tirreno, e Metaponto “dalla parte del mar di Sicilia”.
Sempre secondo Strabone, in questo estremo lembo della penisola, i nomi di Enotria e di Italia relativi, rispettivamente, alle mitiche popolazioni degli “Enotrî” e degli “Itali”, avrebbero però originariamente contraddistinto, solo i luoghi che gravitavano più direttamente sullo “Stretto di Sicilia”, all’interno dell’istmo posto tra il golfo di Hipponion e quello di Squillace, per poi estendersi, sino al territorio di Metaponto ed alla Siritide. Con il tempo, il nome di Italia era giunto fino alle falde delle Alpi grazie ai Romani, che avendo già concesso agli “Italici” il diritto di cittadinanza, estesero tale “onore” anche ai “Galli cisalpini ed ai Veneti”, in maniera che tutti questi furono chiamati “Italici e Romani”.[vi]
In merito ai nomi usati durante questo periodo, per indicare le diverse parti del territorio che Strabone identifica oltre questi confini dell’Italia “antica”, la sua testimonianza traccia una netta differenziazione tra quelli usati dai Greci e quelli, invece, usati dalla “popolazione del posto”.
Relativamente alla “penisola” compresa tra Taranto e Brindisi, i primi, come era anche di uso più generale, chiamavano “Iapigia” o “Messapia”, la regione peninsulare che seguiva a quella di Metaponto, mentre chiamavano “Peucezî” e “Dauni” i popoli stanziati a settentrione di questa penisola. I secondi distinguevano, invece, tra la “terra dei Salentini”, posta alla sua estremità, intorno al “Capo Iapigio”, e la restante parte che denominavano “Calabria”, cui seguiva verso nord il territorio chiamato “Apulia”.[vii]
Lucani e Brettii
Descrivendo i limiti tirrenici della Lucania (Λευκανία), Strabone spiega che quest’ultima iniziava “Dopo la foce del fiume Silaris”, affermando che la città di Laos era “l’ultima della Lucania” e che si trovava presso il fiume omonimo, “un poco all’interno rispetto al mare”[viii]. Sempre in riferimento a quanto poteva essere constatato ai suoi tempi, nel proseguo della sua descrizione, lo stesso Strabone ribadisce poi, che “La Lucania, dunque, è situata fra la costa del mar Tirreno e quella del mar di Sicilia: sulla prima si estende dal Silaris al Laos, sulla seconda da Metaponto a Turi; sul continente essa si estende dalla terra dei Sanniti fino all’istmo che va da Turi a Cerilli, vicino a Laos: l’istmo misura 300 stadî.”[ix].
Egli, però, tenendo sempre presente che “chi si propone di trattare la geografia della terra deve esporre sia le cose come sono attualmente, sia, in qualche misura, anche come furono prima, soprattutto quando si tratta di cose illustri”, dopo aver descritto le località dei Lucani sulla costa tirrenica, passa a descrivere quelle che si trovavano sull’altro mare.
Sappiamo così che la loro presenza qui non era così antica come sulla costa tirrenica e che prima che i Greci assumessero il controllo del golfo di Taranto, questi luoghi erano appartenuti a “Conî ed Enotrî”. I Sanniti, scacciati questi ultimi, avevano poi insediato in questi territori alcuni Lucani[x]. Strabone, infatti, nella sua ricostruzione relativa alle vicende di queste popolazioni, faceva discendere dai Sanniti i Lucani e da questi i Brettii (Bρέττιοι) [xi].
Al tempo in questione però, in conseguenza della loro romanizzazione, di tali antiche realtà rimaneva ben poco. Escludendo infatti le poche città in cui Strabone poteva constatare ancora una identità greca (Taranto, Reggio e Napoli), il resto dei luoghi risultava abitato parte dai Lucani e dai Brettii, parte dai Campani, “per quanto costoro li occupino solo a parole, perché in realtà li controllano i Romani: e infatti questi popoli sono divenuti Romani.”.
Soffermandosi sulla presenza dei Lucani che abitavano l’entroterra nella zona posta all’interno del golfo di Taranto, Strabone evidenzia la scomparsa dei loro caratteri distintivi e la scarsa importanza dei loro insediamenti, sottolineando che “costoro come i Brettî ei Sanniti loro progenitori, soggiacquero a tante sventure che è oggi difficile persino distinguere i loro insediamenti. Infatti di ciasuno di questi popoli non sopravvive più nessuna organizzazione politica comune e i loro usi particolari, per quel che concerne la lingua, il modo di armarsi, e di vestirsi e altre cose di questo genere, sono completamente scomparsi; d’altra parte considerati separatamente e in dettaglio, i loro insediamenti sono privi di ogni importanza.”[xii].
Nella sue esposizione relativa a “questi popoli che abitano nell’interno, vale a dire i Lucani e i loro vicini Sanniti”, Strabone individua in primo luogo “Petelia” (Πετηλία), l’odierna Strongoli, ma a differenza di Tito Livio che evidenzia più volte l’appartenenza di questa città al territorio dei Brettii,[xiii] e di Appiano (sec. II d.C.) che, riferendo dei fatti avvenuti al tempo della seconda guerra punica, dice che “Petelia”, non era ormai più occupata dai “Petilini”, espulsi da Annibale, ma dai Brettii,[xiv] afferma invece che la città era “considerata metropoli dei Lucani” e che era posta nelle vicinanze dell’antica “Crimisa” (Κρίμισσα), “in una posizione ben salda, cosicchè anche i Sanniti una volta la fortificarono”. In continuità con la sue affermazioni precedenti, che cercano di ricostruire un orizzonte originario, citando Apollodoro, egli efferma poi che, anticamente, “in questi stessi luoghi”, ma “un po’ all’interno” rispetto al promontorio di Crimisa, Filottete aveva fondato anche “la città di Chone, dalla quale, quelli che abitano li, presero il nome di Coni.”.
Proseguendo, Strabone menziona “nell’entroterra”, altri centri tra cui “Grumentum, Vertinae, Calasarna ed altre piccole città fino a Venusia, che è una città importante. Ritengo che sia questa sia le altre città che vengono di seguito per chi procede verso la Campania siano sannite.”[xv]. L’appartenenza di Grumento alla realtà lucana di questo periodo, è confermata da Tito Livio in riferimento a fatti relativi agli anni 207-206 a.C., quando, dai quartieri invernali e dai presidii del territorio dei Brettii (“agri Bruttii”), Annibale si spostò a Grumento “in Lucanos”.[xvi]
I Brettii
Passato a descrivere il territorio dei Brettii, Strabone afferma che essi abitavano “una penisola nella quale è inclusa un’altra penisola, quella, cioè, il cui istmo va da Scylletium fino al golfo di Hipponion” e che il loro territorio raggiungeva lo Stretto.
In merito al significato di questo etnico, che troviamo nel greco BPETTIΩN sulle antiche monete coniate da questo popolo[xvii], è stata rimarcata l’affinità con Bρεντέσιον (Brindisi)[xviii] e con Bρεττανία (Bretagna) o Bριττία, l’isola dell’Oceano boreale abitata da Angli, Frisoni e Brettoni (Bρίττωνες),[xix] in ragione di una comune matrice linguistica che alcuni riconducono a “corno”[xx] e che, in questo caso, potrebbe trovare ragione nella conformazione simile di questi luoghi peninsulari.[xxi]
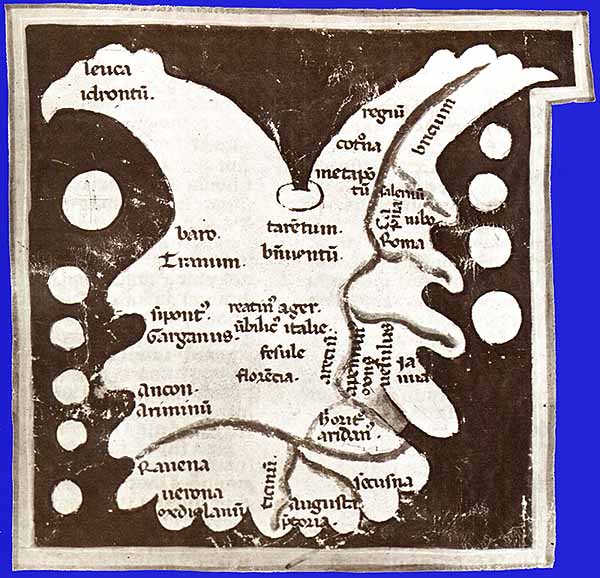
Miniatura medievale esistente in un codice conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, che rappresenta l’Italia romana in senso sud-nord (da www.cairomontenotte.com/abramo/). Oltre alle città di “tarentum”, “metapontum”, “cot.ona”, “regium” e “vibo”, risulta evidenzato il “bricium”.
Secondo Strabone, che rimproverava ad Antioco di non fare “nessuna distinzione fra Lucani e Brettî”, questi ultimi avevano ricevuto il proprio nome dai Lucani, dai quali si erano affrancati al tempo in cui Dione aveva mosso guerra a Dionisio di Siracusa (357 a.C.): “infatti questi ultimi chiamano «Brettî» i ribelli. Questi Brettî dunque, che prima erano dediti alla pastorizia al servizio dei Lucani, essendo poi divenuti liberi per l’indulgenza dei loro padroni, si ribellarono, a quanto dicono, quando Dione fece guerra a Dionisio e sollevò tutti questi popoli gli uni contro gli altri.”[xxii]
In riferimento a tale episodio, anche Diodoro Siculo (sec. I a.C.) che, al pari di Strabone, utilizza Timeo quale sua fonte, ci fonisce una ricostruzione simile circa i fatti che avrebbero condotto alla formazione della nuova entità politica dei Brettii (Bρέττιοι).
Egli spiega infatti, che essi costituivano una moltitudine promiscua di uomini composta da servi fuggiaschi dediti alla rapina, confluiti da vari luoghi della Lucania che, in seguito, dopo aver cinto d’assedio Terina ed averla espugnata, ed aver conquistato Ipponio, Thurii e molti altri luoghi, avevano formato una confederazione (ϰοινὴν πολιτείαν). Poiché la maggioranza di loro era appunto costituita da servi fuggiaschi, avevano assunto così il nome di Brettii (Bρέττιοι), che nella lingua locale identificava i fuggitivi.[xxiii] Lingua definita “oscura” ed “orribile”, come si rinviene in un frammento di Aristofane (sec. V-IV a.C.) citato da Stefano Bizantino.[xxiv]
La regina eponima
Una spiegazione diversa e soprattutto, non infamante, troviamo invece, più tardi, nel racconto di Pompeo Trogo riassunto da Giustino (sec. II d.C), dove l’origine dell’etnico dei “Bruttii”, definiti di animo bellicoso (“Tanta feritas animorum erat”), “fortissimi” ed “opulentissimi”, nonché sempre pronti a portare rovine ai loro vicini, è fatto risalire al tempo in cui i pastori del luogo, attraverso l’aiuto di una donna di nome Bruttia (“Bruttiam mulierem”), erano riusciti ad espugnare una fortezza presidiata da seicento africani alleati del tiranno Dionisio II, fondando una nuova città e dandosi così il nome di “Bruttios”, derivandolo da quello di questa donna.[xxv]
L’atto fondativo realizzato attraverso la conquista, da parte di uomini passati dalla vita pastorale a quella agricola e cittadina, compiuto attraverso l’intervento determinante di un personaggio eponimo, ci rimanda ad uno schema mitico classico che, rispetto alle testimonianze denigratorie raccolte da Strabone e da Diodoro Siculo, riassume meglio fatti e significati che possiamo concretamente ricondurre alla nascita dell’organizzazione politica dei Brettii.
In questo senso, l’intervento fondante legato al mito della “Bruttiam mulierem”, troverà seguito nei fatti subito conseguenti alla costituzione della confederazione dei Brettii, e relativi al consolidamento del loro dominio, successivamente alla sconfitta ed alla morte di Alessandro il Molosso re d’Epiro (331 a.C.).
Ce ne rimane testimonianza nell’epilogo di questi fatti raccontati da Tito Livio, secondo cui il corpo del re, tagliato in due, fu parte mandato a Cosenza, mentre l’altra fu lasciata sul campo di battaglia in balia del dileggio e dello scherno dei soldati. Uno scempio che avrebbe trovato fine per l’intervento di una donna sola (“mulier una”) che, avendo richiesto i resti del cadavere, in maniera da poter riscattare il proprio marito ed i propri figli prigionieri presso i nemici, ottenne così che i soldati cessassero di infierire sulle spoglie del re. Sempre secondo questo racconto pietoso, sarebbe stata ancora quella donna sola che avrebbe provveduto a seppellire i resti del re mandati a Cosenza (“fuit cura mulieris unius”).[xxvi]
Alcuni elementi di questo racconto trovano un riscontro più antico in Licofrone, poeta vissuto nel sec. III a.C., ma la cui composizione erudita contiene numerosi riferimenti remoti, che sono esposti da questo autore, attraverso le predizioni di Cassandra.
Secondo una di queste predizioni, alludendo ai fatti successivi che avrebbero opposto i Crotoniati alla popolazione del luogo in epoca storica, il vaticinio di Cassandra riassume le vicende relative alla conquista del territorio da parte degli Achei che, reduci dalla guerra di Troia, sarebbero infine giunti erranti nella “regione” posseduta da “una Amazone”, costituita dalle “inaccessibili alture della Sila” ed estesa fino al “promontorio di Lino” (Λίνου, Laino?). Qui, dopo essere sottostati al “giogo” di questa “donna di condizione servile” e dopo molti sforzi, i Crotoniati sarebbero infine riusciti a distruggere “la città dell’Amazone”, uccidendo “la regina che porta il nome del suo paese”.[xxvii]
La scelta da parte di Licofrone, di rappresentare questi fatti ricorrendo a personaggi che alludono a quelli protagonisti degli antichi miti propri del patrimonio leggendario di entrambe le parti coinvolte, dimostra di non essere casuale, anzi risulta ben scelta e circostanziata.
Per altro verso,[xxviii] sappiamo infatti che Cleta, nutrice dell’amazzone Pentesilea, avendo appreso della morte della sua signora a Troia per mano di Achille, l’eroe tessalo tanto caro alla più antica tradizione degli Achei, era stata la sola a partire alla sua ricerca, ma imbattutasi in una tempesta, era giunta in Italia. Qui aveva fondato la città di Cleta ed era divenuta la regina del luogo. In seguito, tutte le regine succedutele nel regno, erano state chiamate con quello stesso nome e, dopo molte generazioni, infine, l’ultima era stata uccisa dai Crotoniati.
In ragione dell’importanza riconosciutagli da tali racconti, questa divinità appare ricorrentemente raffigurata sulle monete dei Brettii,[xxix] e risulta menzionata da Stefano Bizantino (sec. V-VI d.C.), che citando Arriano (sec. II d.C.), riferisce che “Abrettenia”, territorio di Misia, era così chiamato dalla “ninfa Brettia” (Ἀβρεττηνή, χώρα Mυσίας, ἀπὸ Bρεττίας νύμφης).[xxx]
Essa sarà ricordata ancora in epoca medievale quando, nel corso del secolo VI d.C., ripercorrendo i fatti accaduti in Italia al tempo di Alarico, Iordanes evidenzierà che i “Brittios”, ovvero la regione dei “Bryttiorum”, aveva tratto questo nome da quello della regina “Bryttia”[xxxi] come, del resto, riferirà successivamente, anche Paolo Diacono (sec. VIII d.C.), facendone risalire l’origine a quello della “reginae quondam suae nomine appellata”.[xxxii]
Le terre dei Brettii
In merito alle implicazioni che fanno riferimento allo spazio territoriale riconducibile a questa figura sovrana/divina, possiamo dire che gli elementi del suo mito, risultano localizzati in un ambito sostanzialmente selvaggio che ben rispecchiano le caratteristiche della “Sila” (Σίλαν),[xxxiii] ovvero della “Sila Bruttiorum”,[xxxiv] dove i racconti ambientano i fatti legati alla nascita della confederazione dei Brettii e dove la possibilità di esercitare la pastorizia, necessitava e presupponeva, imprescendibilmente, accordi con coloro che detenevano il dominio dei luoghi costieri.
Nell’ambito della secolare transumanza che si realizzava stagionalmente tra l’altipiano silano e le marine adiacenti, in cui obligatoriamente avrebbero dovuto poter svernare le mandrie, si segnala infatti la presenza di “Pandina”, divinità femminile raffigurata su alcune monete di Terina e di Ipponio che sono messe in relazione alla presenza brettia in questi luoghi durante questo periodo,[xxxv] ed il cui nome trova corrispondenza con l’etnico “Pandosino” o “Pandosiano”, derivato da “Pandosia” (Πανδοσία),[xxxvi] realtà del versante ionico della Sila.
Un culto legato alla figura di questa divinità femminile brettia, che dimostra di succedere, almeno da un punto di vista politico, a quello che aveva precedentemente visto il predominio greco manifesto attraverso la figura di Hera, la cui tutela territoriale, attraverso la garanzia del diritto d’Asilo (Asylia) nell’ambito del suo “bosco” sacro, risulta evidenziato già per l’età arcaica, come indica il riferimento al culto di Achille sul promontorio Lacinio,[xxxvii] e come rimarca più esplicitamente, il racconto di Tito Livio: “lucus ibi frequenti silva et proceris abietis arboribus saeptus laeta in medio pascua habuit, ubi omnis generis sacrum deae pecus pascebatur sine ullo pastore, separatimque greges sui cuiusque generis nocte remeabant ad stabula, nunquam insidiis ferarum, non fraude violati hominum.”.[xxxviii]
In relazione a ciò, pur volendo tenere in considerazione l’antica presenza dei Lucani a Petelia riferita da Strabone, i limiti del territorio soggetto ai Brettii verso il Crotonese, in tempi più recenti e vicini a quelli della loro costituzione federale, vanno ricercati lungo la Valle del Neto ed il confine silano stabilito dalla natura dei luoghi, seguendo quelli di “Consentia, metropoli dei Brettî”[xxxix] e quelli di Pandosia che, nell’Orbis Descriptio dello Pseudo Scimno, risulta indicata tra Crotone e Thurii, nell’ambito del versante ionico (“Post Crotonem Pandosia et Thurii; finitimum his est Metapontium …”)[xl], ma che Tito Livio individua in prossimità del confine bruzio-lucano: “… Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Bruttis finibus …”.[xli]
Un’apparente contraddizione, che risulta spiegabile in ragione del particolare assetto pre-urbano del territorio dei Brettii, strutturato attraverso insediamenti diffusi nel territorio interno, ancora prevalentemente legati ad una economia pastorale dove, in questa fase più antica, l’esistenza di “città” deve essere intesa solo come una forma narrativa adottata dalle fonti.
Alla luce delle informazioni viste forniteci da Strabone che, ancora ai suoi tempi, giudicava indistinguibili i loro insediamenti, sia nel caso di Pandosia, come delle altre realtà politiche formatesi nell’ambito del territorio dei Brettii, dobbiamo quindi intendendere tali realtà, come forme delocalizzate ormai limitrofe alle antiche polis greche e nei loro confronti, concorrenti, in ragione della loro evoluzione verso la dimensione urbana.
Tali adiacenze giustificano i fatti che seguirono alla sconfitta ed alla morte di Alessandro il Molosso, quando Crotone fu subito assalita dai Brettii, ai quali scampò per il soccorso dei Siracusani,[xlii] e sono poste in particolare evidenza da un episodio accaduto attorno agli anni venti del sec. IV a.C.
In questa occasione, la fazione democratica della città, in lotta con quella oligarchica che era fuggita e si era riorganizzata a Thurii, giunse ad un accordo con i Brettii (Bρεττίους), e quando gli oligarchici tentarono di fare ritorno spalleggiati da un contingente di mercenari, furono tutti sterminati dalle truppe cittadine sui confini del territorio dei Brettii (Bρεττίων χώρας), dove avevano posto il loro campo.[xliii] Alla presenza antagonista dei Brettii verso le polis greche sul versante ionico tra Thurii e Crotone, può essere ricondotto anche l’episodio relativo alla definitiva scomparsa dell’insediamento precedentemente realizzato dagli esuli Sibariti sul fiume Traente.[xliv]
Una situazione a cui le polis cercarono di porre riparo. Prima, assoldando mercenari e costituendo organismi federali e, successivamente, ricorrendo all’aiuto di Roma, come sottolineano, tra l’altro, i trionfi dei consoli romani relativi alle campagne condotte contro le popolazioni dell’Italia meridionale, registrati durante il decennio 282-272 a.C. dai Fasti Triumphales.[xlv]
La minaccia incombente dei Brettii nei confronti delle realtà greche, perdurerà sino al loro completo assoggettamento al potere romano, dopo la partenza di Annibale dall’Italia (203 a.C.), a conclusione della seconda guerra punica. Essendo stati gli alleati più fedeli del condottiero cartaginese, schieratisi dalla sua parte dopo la disastrosa sconfitta romana a Canne (216 a.C.),[xlvi] i Brettii che erano riusciti a conquistare Crotone nel 214 a.C.,[xlvii] furono costretti a subire la ritorsione dei Romani verso i vinti. Fu così che, assoggettati attraverso la forza, come nel caso di “Clampetia”, o sottomessi “spontaneamente” ai Romani, secondo quanto riferiscono Tito Livio, nei casi di “Consentia et Pandosia”,[xlviii] e Dionigi di Alicarnasso, cedettero loro la metà della selva chiamata Sila (Σίλα), da cui i nuovi padroni trassero cospicue rendite.[xlix]
I Brettii furono così privati di gran parte del territorio (χώραν) e delle armi, come riferisce Appiano, mentre in avvenire, fu proibito loro di prestare servizio militare perché non godevano più la condizione di uomini liberi, ma gli fu imposto di assistere in qualità di servi, i consoli ed i pretori che partivano per governare i popoli.[l]
Anche Aulo Gellio (sec. II d.C.), riferisce che, in ragione della loro infamia, perpetrata al tempo in cui erano passati dalla parte dei Cartaginesi, dopo la loro sconfitta, i Brettii non furono più considerati alleati dei Romani, né furono più arruolati come soldati, ma furono assegnati al posto dei servi, ai magistrati che si recavano nelle provincie.[li] Una misura che doveva avere lo scopo di tenere sotto stretto controllo questo territorio dato che, sulla scorta dei fatti recenti, lo si considerava sempre pronto ad una sollevazione.[lii]
Nella provincia romana
Ricondotti i Brettii sotto il giogo del potere romano, quello che era stato il loro territorio, al di là di quelle che furono le reali decurtazioni stabilite dai vincitori, andò a costituire una “provincia” romana, ovvero una ripartizione del territorio di Roma costituita su base etnica, affidata ad un pretore con poteri amministrativi e militari, anche se, a volte, nella loro narrazione, le fonti usano il termine provincia in luogo di “regione”, volendo così indicare solo una certa area geografica, come rileviamo in Tito Livio, in occasione della descrizione di alcuni fatti relativi allo svolgimento della seconda guerra punica.
Secondo il suo resoconto, quando Q. Fabio Massimo e Q. Fulvio Flacco assunsero la carica di consoli (209-208 a.C.), essi ebbero entrambi la “provincia” d’Italia, ma il potere conferitogli fu suddiviso loro per “regionibus”. Nella prospettiva creata da tali assegnazioni, Fabio avrebbe così condotto la guerra “ad Tarentum”, Fulvio, invece, “in Lucanis ac Bruttis”.[liii]
La strategia mutò nell’anno seguente (207-206 a.C.) quando, nella distribuzione delle “provinciae” ai due consoli C. Claudio Nerone e M. Livio Salinatore, queste non furono assegnate senza fare distinzione per “regionibus” come negli anni precedenti, ma furono ripartite loro separatamente agli estremi confini dell’Italia (“extremis Italiae finibus”). In questo quadro tattico, ad uno sarebbe andata così la regione “Bruttii et Lucani” contro Annibale, mentre all’altro, sarebbe toccata la “Gallia”, regione posta all’altro estremo dell’Italia, contro Asdrubale. In questa occasione si specificava, inoltre, che il console a cui sarebbe toccata la “provincia dei Brettii” (“Bruttii provincia”), avrebbe ottenuto uno dei due eserciti consolari dell’anno precedente.[liv]
Rispetto a questo racconto di Tito Livio circa il teatro operativo assegnato a ciascun console, in cui i termini di provincia e regione a volte coesistono con lo stesso significato, possiamo cogliere una differenza significativa, attraverso i termini usati dallo stesso autore per informarci circa l’assegnazione delle provincie ai singoli pretori. In questo caso, infatti, facendo riferimento esplicito alla giurisdizione territoriale relativa ad una specifica magistratura, il termine usato risulta sempre quello di “provincia” mentre, nel nostro caso, il nome che la identifica risulta sempre quello del popolo che l’abitava: i Brettii (“Bruttii”). In relazione alla ripartizione delle 23 legioni “per provincias” in tale frangente, sappiamo infatti che due di queste risultarono assegnate a Q. Fulvius “in Bruttis”.[lv]
Nomi e termini che, da questo punto in avanti, ricorrono nel linguaggio usato da Tito Livio, anche nei passi in cui l’autore ricorda l’attività dei consoli.
Nel 206 a.C. ad entrambi i consoli di quell’anno fu assegnata la “provincia” dei Brettii, affinchè conducessero la guerra contro Annibale,[lvi] mentre, in occasione dell’assegnazione delle “provinciae” nell’anno seguente, Crasso ebbe i “Bruttii”.[lvii] Per quanto riguardò, invece, i due consoli di quell’anno, fu stabilito che tirando a sorte o mettendosi d’accordo, fosse scelto quello che avrebbe dovuto combattere “in Bruttiis”, prorogandogli il comando per un anno in quella “provincia”.[lviii]
Nel 204 a.C., al console P. Sempronio fu assegnato il comando militare del territorio dei Brettii (“Bruttii”), mentre il comando militare di P. Licinio fu prorogato di un anno, con l’ordine di occupare con due legioni i “Bruttios”, trattenendosi “in provincia” per il tempo che gli fosse sembrato opportuno.[lix] Testimonianze di questo tipo, risultano ancora documentate negli anni seguenti.[lx]
Città e territori
Cercando elementi che possano aiutarci a comprendere la strutturazione del territorio all’indomani della partenza di Annibale, possiamo individuare due importanti realtà distinte: una rappresentata dalle polis greche concentrate essenzialmente lungo la costa, l’altra rappresentata dal “territorio” dei Brettii, caratterizzato da un insediamento sparso nell’interno che però, nel tempo, era giunto a lambire e penetrare in quello delle città costiere. Un territorio che a seguito delle vicende della seconda guerra punica, oltre che dai Romani, sarà ormai riconosciuto unitariamente come “Brettia” anche dagli stessi Elleni della Grecia, come evidenzia ad esempio, un passo relativo all’ambasceria dei Rodii agli Etoli, in cui si evidenzia che Annibale, ormai vicino all’epilogo della sua campagna in Italia (Ἰταλíᾳ), si trovava chiuso in una piccola parte della “Brettia” (Bρεττίας).[lxi]
In riferimento al carattere interno/montano dell’insediamento brettio e relativamente alle ultime fasi della seconda guerra punica, Appiano riferisce che Annibale avrebbe trasferito in pianura molte forti città dei Brettii, con il pretesto che stessero organizzando una rivolta contro di lui.[lxii] Una testimonianza denigratoria. Di queste città, attraverso la dettagliata testimonianza di Strabone, sappiamo invece che, ancora all’epoca di Augusto, non esisteva alcuna evidenza urbana meritevole d’attenzione.
Pur facendo menzione di “città” in maniera narrativa, secondo una certa tendenza storiografica, diffusa e duratura, le fonti letterarie di questo periodo, sforzandosi comunque di rappresentare più compiutamente la realtà, fanno riferimento alle forme d’insediamento dei Brettii in maniera più pertinente, parlando di “oppida”,[lxiii] di “castella” e “populi”.
Attraverso il paragone di una grande città qual’era Cartagine, la realtà preurbana degli insediamenti brettii è posta in risalto, ad esempio, nel discorso in senato di P. Cornelio Scipione, occasione in cui questi avrebbe affermato che Cartagine sarebbe stato il giusto premio alla sua vittoria e non i “semiruta Bruttiorum castella”.[lxiv]
In riferimento alla struttura politica della federazione dei Brettii verso la fine del sec. III a.C., Tito Livio, relativamente agli anni 213-12 a.C., afferma che, “in Bruttiis”, dei “dodici popoli” che durante l’anno precedente erano passati dalla parte dei Cartaginesi, i “Consentini et Tauriani” erano ritornati sotto la tutela del “popolo Romano”[lxv] mentre, successivamente, al tempo della partenza di Annibale (203 a.C.), afferma che “Consentia Aufugum Bergae Baesidiae Ocriculum Lymphaeum Argentanum Clampetia multique alii ignobiles populi”, passarono dalla parte del console Gn. Servilio che “in Bruttis erat”.[lxvi]
Fatta eccezione per i casi di Cosenza e Thurii, risulta difficile stabilire un collegamento tra i nomi di questi popoli e realtà urbane evidenziabili nelle fasi successive, anche quando le fonti testimoniano esplicitamente della presenza di “città”, come nel caso di Stefano Bizantino che, citando Polibio (sec. II a.C.), riferisce di “Badiza” città della Brettia (Bάδιζα πόλις τῆς Bρεττίας),[lxvii] analogamente a “Lampeteia” (Λαμπέτεια πόλις τῆς Bρεττίας),[lxviii] o come riscontriamo nel caso della “città di nome Ethe”,[lxix] o della “possente città di Isie”[lxx] o “Tisia”[lxxi] che Erodiano qualifica città dell’Italia (Tισία πόλις Ἰταλíας).[lxxii]
Per quanto riguarda invece, la dimensione urbana di Cosenza, oltre alle testimonianze già viste relative alla costituzione della confederazione, tra cui spicca quella di Strabone che la qualifica al rango di metropoli, il suo differente assetto rispetto a quello di altri insediamenti dei Brettii, emerge attraversi i termini usati da Appiano, che la definisce “una grande città dei Brettii” (μεγάλην πόλιν Bρυττίων), al tempo in cui Crasso la separò da Annibale con “altre sei”[lxxiii] mentre, in riferimento al suo territorio (“In Consentinum agrum”),[lxxiv] le fonti si esprimono in maniera analoga a quella usata per il territorio di una polis (“in agro Crotoniensi”).[lxxv]
Una realtà quindi differente e comunque riconosciuta differentemente dal potere romano, che sembra aver contraddistinto in questo periodo, anche il territorio di Thurii, luogo anch’esso menzionato in occasione degli episodi relativi alla costituzione della federazione, che risulta legato a quello cosentino dalle corrispondenze del Crati, fiume posto nel territorio dei Brettii.[lxxvi]
In quest’area, dove i Romani decisero di dedurre distintamente due diverse colonie latine, una “in Bruttios”, l’altra nel territorio di Thurii (“in Thurinum agrum”),[lxxvii] Strabone individua, “un po’ all’interno rispetto a Turi”, “anche” quello che chiama il territorio Tauriano (Ταυριανὴ χώρα).[lxxviii] Uno scolio di Elenio Acrone (sec. II d.C.) menziona Thurii quale città dei Brettii (“Thyrii enim Bruttiorum oppidum”)[lxxix] mentre, di un episodio avvenuto “in Thuriano Bruttioque agro”, riferisce Girolamo nella Cronaca di Eusebio.[lxxx]
Una situazione simile a quella di Crotone, che pur riconosciuta “in Bruttios” ovvero nella provincia dei Brettii (“Bruttii provincia”), risultava comunque dotata di un proprio territorio (“ager”) distinto da quello brettio,[lxxxi] come riferisce esplicitamente Tito Livio che, ricordando le colonie di cittadini romani dedotte a Tempsa ed a Crotone (194 a.C.), afferma che il territorio della prima era “ager de Bruttis” ed era stato tolto dai Romani a questi ultimi che, a loro volta, ne avevano precedentemente scacciato i Greci, mentre Crotone era detenuta dai Greci.[lxxxii]
Segno di questo limite tra il territorio cittadino di Crotone (“ager”) adibito alle coltivazioni, e quello interno boschivo, dove erano localizzati gli insediamenti dei Brettii ed in cui predominava la pastorizia (“saltus”), rimane nella sopravvivenza di quest’ultimo toponimo durante il periodo medievale,[lxxxiii] che risulta documentato in corrispondenza dell’importante attraversamento del fiume Neto in località “Timpa del salto”, dove consistenti e diffusi sono stati i ritrovamenti archeologici del periodo romano. Una situazione che trova riscontro anche a nord della città, nell’attuale territorio comunale di Cariati (CS) dove, in località “salto”, in un’area compresa tra l’abitato di quest’ultima e quello di Terravecchia (CS), è stata rinvenuta una importante necropoli brettia.
Lo sfruttamento delle aree interne silane da parte dell’autorità romana, è ricordato da Cicerone (sec. I a.C.), il quale evidenzia che i censori P. Conelio e L. Mummio, avevano dato l’appalto della pece ad una società e che, nell’occasione, “in silva Sila”, alcuni schiavi, ma anche alcuni uomini liberi di quella società, erano stati accusati di aver compiuto un massacro, in cui erano stati uccisi degli uomini noti.[lxxxiv]
Trasformazioni determinate dall’avvento del potere romano che, invece, ci appaiono in un contesto diverso, rispetto a quanto ci risulta segnalato sulla costa tirrenica. Qui, oltre a quella di Tempsa, la presenza radicata dei Brettii nelle polis precedentemente appartenute ai Greci, risulta documentata anche ad Ipponio, mentre risulta esclusa, sull’altro versante, a Locri e Caulonia.
In occasione della deduzione della colonia di “Vibonem” (192 a.C.), si riferisce, infatti, che quel territorio era appartenuto ultimamente ai Brettii (“Bruttiorum proxime fuerat ager”), i quali l’avevano precedentemente tolto ai Greci.[lxxxv] Erodiano (sec. II d.C.) qualifica Ipponio città dei Brettii (πόλις Bρεττίων),[lxxxvi] come ribadisce, successivamente, Stefano Bizantino (Ἰππώνιoν, πόλις Bρεττίων).[lxxxvii]
Per quanto riguarda, invece, la situazione di Locri e Caulonia, analogamente a quella delle altre polis della costa ionica, il permanere della loro antica identità cittadina, pur romanizzata, è documentata in questo periodo, nell’ambito dell’appartenenza alla “provincia” dei Brettii.
In relazione a ciò, registriamo l’intervento a Locri del pretore cui nel 200 a.C., era stata assegnata questa provincia.[lxxxviii] In questa occasione, il senato romano, avendo appreso da una lettera di Quinto Minucio Rufo “cui Bruttii provincia erat”, dove si riferiva circa un furto di denaro dal tesoro di Proserpina a Locri, affidò al console Caio Aurelio il compito di scrivere “ad praetorem in Bruttios”, affinché fosse realizzata la relativa inchiesta.[lxxxix] In relazione a questi fatti, l’incarico al detto pretore fu prorogato anche per l’anno seguente.[xc]
In merito alla presenza dei Brettii nel territorio interno, limitante con quello dell’antica polis già nelle fasi precedenti a questa, Polibio riferisce dei saccheggi e delle devastazioni condotte nella Locride e nel territorio Brettiano (Bρεττιανὴν χώραν), dai Cartaginesi durante la prima guerra punica,[xci] mentre, successivamente, Strabone afferma che, nell’entroterra della città di Locri occupato dai Brettii, si trovava “la città di Mamertium”.[xcii] Tito Livio identifica Caulonia nella provincia dei Brettii (“in Bruttiis”).[xciii]
Il diverso assetto dei territori appartenenti alle antiche polis greche poste lungo il versante ionico, rispetto a quello del versante opposto, emerge anche attraverso le fonti che ci offrono una descrizione geografica dei luoghi nel corso dei sec. I-II d.C, in particolare, in quelle in cui comincia a trovare spazio il concetto di “Magna Graecia”.
La “Magna Graecia”
La più antica documentazione dell’espressione “Magna Graecia” risale a Polibio (sec. II a.C.),[xciv] mentre i tentativi di alcuni storici moderni di ricondurla ad epoche precedenti a quella di questa fonte, sono rimasti delle congetture.
Anche se Polibio afferma che tale espressione fosse già usata al tempo in cui erano state incendiate le sedi dei Pitagorici,[xcv] possiamo evidenziare, invece, che essa fa riferimento ad un concetto chiaramente estraneo alla cultura greca, per la quale non esistevano realtà statali che superassero le dimensioni di quelle cittadine, e nella quale non è neanche immaginabile la comparazione tra una sorta di grecità maggiore a confronto di una di proporzioni minori. Senza contare che il concetto di Elleni (o di Greci), aveva una dimensione etnica e culturale ma non certamente politica.[xcvi] In riferimento all’esigenza di usare una espressione per indicare, complessivamente, i Greci delle città dell’Italia meridionale, già in antico, Erodoto (sec. V a.C.), come fecero anche altri, usa infatti quella generica di “Italioti”.[xcvii]
A conferma di ciò, l’espressione Magna Grecia (μεγάλην Ἑλλάδα), che si ritiene frutto di “una interpolazione tarda”,[xcviii] ricorre in un unico passo di Strabone, nella sua “Geografia” scritta agli inizi del sec. I d.C.,[xcix] sulla base del quale, è stato supposto da alcuni, che la sua ampiezza geografica fosse da indentedere estesa anche alla Sicilia.
Essa non compare neanche nella descrizione della costa ionica contenuta nella “Chorographia” di Pomponio Mela, vissuto nella prima metà del sec. I d.C.[c] che, ripercorrendo i confini già segnalatici da Strabone, dopo aver riferito che la “Calabria” cominciava da Brindisi e comprendeva Otranto e Gallipoli, descrive geograficamente i diversi golfi presenti lungo questo litorale, incorrendo comunque in errore, nella menzione del promontorio “Zephyrium” in luogo di quello di Stilo.
Risultano così elencate le città poste nel golfo di Taranto, tra i promontori Sallentino e Lacinio, da Taranto fino a Crotone, quelle poste nel golfo di Squillace, tra i promontori Lacinio e Zefirio (sic), e quelle poste nel golfo tra i promontori Zefirio e “Bruttium”, in cui andavano comprese Cosenza, Caulonia e Locri. “In Bruttio”, erano Reggio, Scilla, Tauriano e Metauro.[ci] Sul versante tirrenico, ancora, l’elenco dei luoghi menzionati da Pomponio Mela, cominciando da Medma, continua poi senza soluzione di continuità, con l’elenco dei luoghi della Lucania.[cii]
Differiscono da queste, le descrizioni geografiche forniteci da Plinio il Vecchio (sec. I d.C.) e Tolomeo (sec. II d.C.), nelle quali compare l’espressione “Magna Graecia”.
Rifacendosi al divo Augusto quale sua fonte, Plinio ci descrive l’Italia ripartita in undici “regiones”.[ciii] Pur mancando chiare testimonianze circa le ragioni che condussero i Romani a tale suddivisione, è possibile che queste siano state dettate dalla necessità di ripartire gli approvvigionamenti alimentari di Roma (l’Annona), tra le diverse popolazioni soggette alla capitale imperiale, come sembra evidenziare una epigrafe datata al 273-275 d.C. che, in relazione all’incarico di “conrectorem” ricevuto da C. Pius Esuvius Tetricus, evidenzia: “… conrectorem totius Italiae fecit, id est Campaniae Samni Lucaniae Brittiorum Apuliae Calabriae Etruriae atque Umbriae Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis”.[civ]
Secondo Plinio, che costituisce la sola fonte che ci descrive complessivamente tale ripartizione, la “regio tertia” iniziava dal “Silaro” sul versante tirrenico, dove erano i limiti del territorio Lucano e Brettio[cv] mentre, su quello opposto, i suoi confini erano rappresentati da Metaponto “quo tertia Italiae regio finitur”.[cvi] Superato questo limite, iniziava la “secunda regio” che, oltre gli “Hirpinos”, includeva la “Calabriam”, la “Apuliam” ed i “Salentinos”.[cvii] Nell’ambito di questa descrizione, egli riferisce anche della “Magna Graecia”, identificandola con il tratto della costa ionica, comprendente i tre golfi esistenti tra Locri e Taranto.[cviii]
Questa descrizione di Plinio trova riscontro, successivamente, nella Geografia di Tolomeo che, al pari del precedente, stabilisce una ripartizione del territorio oggetto della nostra indagine, tra quello posto lungo il versante tirrenico: parte dei Lucani e parte dei Brettii (Bρουττίων), e la “Magna Grecia” (Mεγάλης Ἑλλάδος) posta sul versante opposto.
Secondo quanto è riportato da questa fonte, lungo il mare Tirreno, appartenevano ai Lucani: Pesto, Velia e Buxento. Lungo questo stesso litorale appartenevano invece ai Brettii: la foce del fiume Lao, la città di Tempsa, lo scoglio Tauriano, il golfo di Ipponio, il promontorio di Scilla, Reggio Iulia ed il promontorio di Leucopetra.[cix] Erano città interne dei Brettii (Bρουττίων μεσόγειοι): Numistro (Nουμίστρων), Consentia e Vibo Valentia.[cx]
Dopo il promontorio di Leucopetra, Tolomeo descrive la Magna Grecia, a cui appartenevano: il promontorio Zefiro, Locri e la foce del fiume Locano (Λoυϰανoῦ). Seguivano nel successivo golfo di Squillace, la città di Squillace e le parti interne di questo golfo, fino al promontorio Lacinio. Appartenevano ancora alla Magna Grecia le città del golfo tarantino: Crotone, Turio, Metaponto e Taranto.
Superato il territorio tarantino che stabiliva il termine della Magna Grecia, seguiva poi a questo quello dei Salentini, con il promontorio Iapigio o Salentino, quindi le città di Calabria (Kαλαβρίας) poste lungo il mare Ionio: Otranto, Luppia e Brindisi.[cxi] Città interne della Magna Grecia (Mεγάλης Ἑλλάδος μεσόγειοι) erano Petilia (Πετηλία) e Abustro o Abrusto (Ἄβυστρον ἢ Ἄβρυστον), mentre città interne della Calabria (Kαλαβρίας μεσόγειοι) erano Sturno e Vreto.[cxii]

Rappresentazione cartografica medievale della Geografia di Tolomeo (dalla pagina Facebook Monumenta Cartographica Calabriae).
In merito alle descrizioni forniteci da Plinio e Tolomeo, possiamo osservare come il confine settentrionale della regione geografica detta “Magna Grecia”, costituito dalla città di Taranto, risulti definito in maniera contraddittoria rispetto ad altre fonti, che collocano questa città in “Messapia” o “Iapigia”, ovvero in “Calabria”,[cxiii] mentre appare confermato il suo limite meridionale con i Brettii (Bρουττίων) dove, nella parte più meridionale della penisola, si apriva quello che Pomponio Mela definisce il golfo “Brutium”,[cxiv] luogo in cui si univano i due mari. Martiano Capella, vissuto intorno alla prima metà del V secolo d.C., evidenzia: “… in Brutium sinum, qui est primus Europae, emissa maria conquiescunt.”[cxv]
Da questa parte infatti, Tolomeo pone nei Brettii il promontorio di Leucopetra ma, oltre al promontorio Zefiro, Locri e Caulonia, assegna alla Magna Grecia anche la foce del fiume Locano (Λoυϰανoῦ), luogo d’incerta identificazione, forse ancora riferibile al promontorio di Leucopetra.[cxvi]
Plinio, infatti, identifica Cano (“Caenus”) quale promontorio che definiva lo Stretto, ponendolo a 15 miglia da Reggio ed a 51 da Locri: “Siculum fretum ac duo adversa promunturia, ex Italia Caenus, e Sicilia Pelorum, XII stadiorum intervallo, unde Regium XCIV. Inde Appennini silva Sila, promunturium Leucopetra XV p., ab ea LI Locri, cognominati a promunturio Zephyrio. Absunt a Silero CCCIII.”[cxvii]
A riguardo dell’identificazione di questi luoghi che, nella descrizione di Tolomeo, costituivano i termini che distinguevano il territorio brettio da quello delle polis magno-greche, secondo quanto riferisce Strabone, il promontorio chiamato “Leucopetra” dal suo colore, identificabile con l’odierno Capo dell’Armi, era posto nel territorio di Reggio ad una distanza di cinquanta stadi a Levante di quest’ultima, nel luogo dove terminavano i “monti Appennini”. A questo seguiva il promontorio “di Eracle, che è l’ultimo ad essere rivolto verso mezzogiorno”, (oggi identificabile con il Capo Spartivento) ed ancora a seguire, “quello di Locri, detto Zefiro, che ha il porto protetto dai venti occidentali e da ciò deriva anche il nome.”.[cxviii]
Il promontorio di Leucopetra, quale limite meridionale del territorio abitato dai Brettii, è ricordato anche successivamente da altre fonti.
Dionisio il Periegeta (prima metà del sec. II d.C.), afferma che i Lucani ed i Brettii (Bρέντιοι), abitavano il territorio dal fiume Silaro sino a Leucopetra (Λευκὴν ἐπὶ πέτρην),[cxix] come ripetono più tardi Prisciano (sec. V-VI d.C.), il quale afferma che i Lucani ed i loro coloni Brettii (“Brettique coloni”), abitavano dal Silaro fino a Leucopetra (“ad Leucem petram”)[cxx] e Niceforo Blémmide (sec. XIII d.C.) che pone sempre a Leucopetra (Λευκῆς πέτρας) il limite tra la Sicilia ed il territorio abitato dai Lucani e dai Brettii (Bρέντιοι).[cxxi]
Nella provincia di Calabria
Cercando di trovare ragioni al concetto di “Magna Graecia”, possiamo rilevare che, per stabilire una partizione tra il territorio abitato dai Brettii e quello delle antiche polis poste lungo la costa ionica, Plinio e Tolomeo non menzionano alcun confine relativo ad una diversa provincia o regione, ma ricorrono entrambi al concetto filosofico di “Magna Grecia”, che non poggia su basi amministrative ma, alludendo ad un’antica comunanza etnica, ormai comuque, quasi del tutto scomparsa – come riferisce Strabone precedentemente a loro – si rifà a correnti erudite del pensiero romano che perdureranno, come dimostrano, ad esempio, i neo-platonici Giamblico e Porfirio verso la fine del sec. III d.C..[cxxii]
Concetto che, in quanto privo di una precisa territorialità, pur essendo spesso usato dagli antichi scrittori, rimarrà soggetto a diverse interpretazioni nella sua concreta delimitazione geografica, come si evidenzia nello Pseudo Scimno, secondo il quale la Magna Grecia andava da Terina a Taranto,[cxxiii] o come rileviamo in Servio, il quale sostiene, invece, che da Taranto, giungeva fino a Cuma.[cxxiv] Qualcosa di simile all’attuale concetto di “Padania”, che pur privo di una effettiva concretezza amministrativa, rimane d’uso comune, riflettendo precise e concrete posizioni politiche.
Volendo poi cercare d’interpretare i motivi di questa anomala presa di posizione, possiamo rilevare la particolare importanza marittima che Taranto ebbe in questo periodo, assieme a quella delle altre antiche città greche poste lungo questo versante costiero, come pongono in evidenza le fonti e come sottolineano le azioni dei Romani subito conseguenti alla conquista quando, a differenza di quanto fecero lungo la costa tirrenica, intervennero estromettendo i Brettii dalle polis della costa ionica, che erano cadute il loro possesso durante la seconda guerra punica. Città cui continuò ad essere riconosciuta una formale identità greca che, per parte romana, dimostra di apparire tesa a salvaguardarne la particolare importanza.
Precedentemente a quella di Tolomeo, comunque, in questa direzione troviamo già la testimonianza di Strabone, che pur non facendone menzione quando descrive il popolamento di questi luoghi, allude agli antichi legami che avrebbero unito le parti più prossime delle due estreme propaggini della penisola italiana, quando, nell’ambito della descrizione del “golfo di Taranto”, che iniziava dal “promontorio Lacinio” e giungeva al “promontorio Iapigio”, riconosciuto come “la così detta bocca” di questo golfo, identificava come “i tre promontori degli Iapigi”, quelli esistenti presso Crotone, tra “Scylletium” ed “il Lacinio”.[cxxv] Un riferimento che, secondo la testimonianza dello stesso Strabone, non potendo poggiare su alcuna base etnica, dimostra di trovare riferimento nella particolare importanza di Taranto, Otranto e Crotone nell’ambito dei collegamenti marittimi con l’Oriente, come risulta documentato, sia durante questo periodo sia in seguito.[cxxvi]
Una importanza strategica posta in luce già in antico, come evidenziano le vicende che avevano visto i Romani, violare gli accordi con i Tarantini, che precludevano loro di superare il capo Lacinio, al tempo dei fatti che determinarono la venuta di Pirro in Italia,[cxxvii] e come rileviamo, ad esempio, nel 192 a. C., quando, nella imminenza dello scoppio del conflitto contro Antioco III, il senato romano ordinò a Marco Bebio, di far avanzare le legioni dal territorio Brettio (“ex Bruttis”) verso Taranto e Brindisi, in relazione ad un possibile loro transito in Macedonia,[cxxviii] mentre sappiamo che, nel sorteggio delle “provincias” del 190 a.C., al pretore M. Tuccio toccarono la Puglia ed i Brettii (“Apuliam et Bruttios”). Un’assegnazione che nasceva dalla necessità di ordine militare di tenere sotto controllo quei territori[cxxix] e che, nel particolare quadro strategico di quel frangente, fu prorogata al detto pretore nei due anni seguenti.[cxxx]
Tali considerazioni ci permettono di evidenziare con sicurezza che, ancora al tempo di Tolomeo, ovvero nel sec. II d.C., i confini della provincia dei Brettii, secondo l’antico stanziamento di questa popolazione, continuavano ad essere quelli stabiliti al tempo della conquista romana, dopo la partenza di Annibale. Una situazione che trova ancora un riscontro successivo, come evidenzia la maniera con la quale i toponimi “LUCCANIA”, “BRITTIUS”, “APULIA”, “SALENTINI” e “CALABRIA”, sono riportati nella carta medievale (sec. XIII) nota come “Tabula Peutingeriana”, ritenuta copia di un originale romano andato perduto (300 d.C. ca.).
In seguito però, risultano documentati dei cambiamenti che, alla luce delle considerazioni espresse, appaiono funzionali agli interessi strategici e/o commerciali dei Romani, nell’ambito dei collegamenti marittimi lungo le rotte orientali, come evidenzia l’“Itinerarium Maritimum Imp. Antonini Augusti” (III-IV secolo d.C), che identifica tanto Otranto (“Hydrunto”), quanto Crotone (“Crotona”) come, del resto, tutte le altre tappe di questo itinerario poste lungo la costa ionica fino a Reggio, nell’ambito della “provinciae Calabriae”.[cxxxi]
È forse per tale ragione, come evidenzia il Romanelli, che Servio (fine IV – inizi sec. V d.C.), commentando il verso di Virgilio dove il poeta parla dell’arx di Caulonia e del promontorio di Stilo,[cxxxii] evidenzia che il luogo “est Calabriae”,[cxxxiii] citando erroneamente i versi di Orazio[cxxxiv] che, invece, si riferiscono al monte Aulon nel territorio tarantino.[cxxxv]
Antichi confini
Dopo la divisione dell’impero alla morte di Teodosio (395 d.C.), Polemio Silvio (IV-V sec. d.C.), sulla base dell’antico ordinamento, distingueva ancora l’Italia in 17 provincie: “In Italia provinciae XVII: (…) Apulia cum Calabria, in qua est Tarentum Brutia cum Lucania, in qua est Regium (…)”.[cxxxvi] Ripartizione che, in età giustinianea, trova riscontro nel Synecdemus di Ierocle, dove, al termine del “catalogo” che elenca tutte le città e le provincie sottoposte al dominio dell’imperatore romano di Costantinopoli, si menzionano le 60 “provincie” (ἐπαρχίαι) sottoposte a Roma, tra cui sono ricordate, complessivamente, le 17 appartenenti all’Italia (Ἰταλίας), oltre alle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica che costituivano ciascuna una provincia unica.[cxxxvii]
Una situazione posta in evidenza anche dalle testimonianze epigrafiche che, a cominciare dalla metà del sec. II d.C. e fino agli inizi del sec. VI d.C., ricordano i diversi magistrati romani (“Procuratores”, “Iuridici”, “Correctores”, ecc.), distinti per: “Apuliam”, “Calabriam”, “Lucaniam” e “Bruttios”/“Bruttiorum”/“Brittios”.[cxxxviii]
Distinzione che evidenzia differenze tra una giurisdizione per provincie ed una per regioni. Come possiamo osservare circa la magistratura dei “Correctores”, in riferimento alla quale, risulta spesso documentato in questo periodo, e fino agli inizi del sec. VI d.C., il nome del magistrato che assumeva tali funzioni nell’ambito di tutta la III regio, in qualità di “corrector Lucaniae et Brittiorum” o di “Lucaniae et Bruttiorum”[cxxxix] ma che, a volte, risulta aver posseduto, invece, una giurisdizione estesa solo al territorio di una singola provincia.
Come testimoniano, ad esempio, i casi di una epigrafe datata tra la fine del III e gli inizi del sec. IV d.C., che ricorda: “[…]vio Basso, v(iro) p(erfectissimo), corr(ectori) / [re]gionum Lucaniae / [et] Brittiorum …”,[cxl] e quella che, nello stesso periodo e riguardo alla stessa magistratura, ma nell’ambito di giurisdizione estesa alla sola provincia di Lucania, trova: “… Fl(avio) Delma / tio, v(iro) p(erfectissimo), cor(r)e(ctori) p(rovinciae) Lucaniae”.[cxli]
Sulla composizione di queste circoscrizioni durante questo periodo, anche se in maniera incerta e parziale, c’informano i c.d. Libri Coloniari, un insieme di scritti eterogenei, ricostruiti in epoca moderna attraverso un codice databile al sec. VI d.C., con l’integrazione di passi appartenenti ad altri codici più recenti.[cxlii] Questa fonte menziona la prefectura “Veliensisis” tra quelle appartenenti alla provincia “Lucania”, ed annovera i seguenti territori appartenenti alla “Provincia Brittiorum”: “Ager Buxentinus”, “Ager Consentinus”, “Ager Vivonensis”, Ager Clampetinus” e “Ager Benebentanus”, mentre, tra i “territoria” che appartenevano alla “Provincia Calabria”, menziona quello “Tarentinum”,[cxliii] oltre a quelli di Brindisi, Otranto e Metaponto, tutte “Civitates Provinciae Calabriae”.[cxliv]
Riferimenti all’antica organizzazione imperiale si ritrovano ancora in Cassiodoro (sec. VI d.C.),[cxlv] mentre, successivamente, pur continuando l’uso degli antichi nomi dei luoghi appartenuti alle antiche popolazioni italiche, che avevano costituito i riferimenti per comporre la geografia dell’amministrazione romana, si coglie, inevitabilmente, il loro distacco dalla realtà precedente, a seguito del rapido decadimento dell’impero che si avviava a divenire una realtà medievale.
Come riscontriamo in Iordanes che, nel sec. VI d.C., in occasione del suo racconto dei fatti riguardanti l’invasione dell’Italia da parte dei Visigoti agli inizi del secolo precedente, descrive la regione (“regio”) detta dei “Bryttiorum”, ovvero i Brettii (“Brittios”),[cxlvi] ed ancora, attorno alla metà di questo secolo, in Procopio di Cesarea che, in occasione della c.d. guerra greco-gotica (535-553 d.C.), nel descrivere gli episodi del conflitto che si svolsero in questi luoghi dell’Italia (Ἰταλίαν),[cxlvii] menziona l’attraversamento del Bruzio (Bρουτίων) e della Lucania, durante la marcia dell’esercito di Bellisario da Reggio verso la Campania.[cxlviii]
In questo periodo, gli antichi limiti che definivano il confine tra la Lucania e le terre dei Brettii in età augustea, costituiti dalla città di Laos sul versante tirrenico e dal limite tra le città di Metaponto e Thurii su quello ionico, continuavano ad essere mantenuti, come evidenziano le fonti, che li identificano con i limiti del Bruzio (Bρυτίους).
Essi risultavano, infatti, in relazione alle due sole vie terrestri che consentivano l’ingresso nella “regione”, come mette in luce Procopio di Cesarea il quale, ancora nel suo racconto degli avvenimenti riguardanti la guerra greco-gotica, riferisce che i monti della Lucania, estendendosi fino al Bruzio (Bρυτίους), consentivano “due soli assai angusti ingressi per quella regione”: uno che “i Latini” chiamavano “Pietra del Sangue” (Πέτρα αἵματος), l’altro che “quei del paese” denominavano “Labula” (Λαβούλαν).[cxlix]
Per quanto riguarda le origini del primo, identificabile sulla costa ionica in corrispondenza della foce del fiume Sinni, la sua antichità, attestata dalla testimonianza di Procopio di Cesarea, e la sua origine latina, consentono di ricondurne l’apparire e l’uso al periodo romano, escludendo riferimenti a fatti molto più antichi legati al noto episodio sacrilego dello spargimento del sangue dei Siriti da parte degli Achei. Anche se la menzione del “tumulo” di Calcante, contenuta nell’Alessandra di Licofrone, evidenzia che il luogo costituiva un’importante area di confine in epoca antica.[cl]
Nel nostro caso, infatti, possiamo mettere in relazione questo toponimo latino, all’esistenza di un confine tra due diverse etnie (il “Sangue”), diverso da quello che distingueva la divisione amministrativa tra le “regiones” II e III posto più a nord, sul confine del territorio di Metaponto, e che quindi, alla luce delle testimonianze passate in rassegna, possiamo individuare in quello che, in epoca romana, divideva la provincia dei Lucani da quella dei Brettii.
Le delimitazioni territoriali che distinguevano lo stanziamento delle antiche popolazioni italiche, sono ripercorse in questo periodo ancora da Procopio di Cesarea che, alla destra della città di Otranto, distingueva i “Calabri” (Kαλαβρoί), i Pugliesi ed i Sanniti, mentre, a sinistra della stessa città, l’altra porzione dei Calabri (Kαλαβρῶν) i Brettii (Bρέττιoί) ed i Lucani. Egli affermava inoltre, che qui si trovava la regione detta nel passato “Magna Grecia”, poichè “nei Brettii” (ἐν Bρεττίοις), si trovavano i Locresi Epizephirii, i Crotoniati ed i Thurini.[cli]
I “nefandissimi Longobardi”
Rispetto a questa antica situazione sopravvissuta per tutto il periodo romano, che affiora in questi primi tempi dell’età medievale, una importante trasformazione si realizzò nella seconda metà del sec. VI d.C., quando, a seguito del consolidarsi della presenza dei Longobardi nella Campania e della loro espansione verso i territori vicini, il territorio dei Brettii, interessato da tale espansione ed occupato in parte da questi nuovi venuti di diversa etnia, subì una mutazione profonda della sua struttura precedente, che produsse un riassetto e determinò il ridisegno dei suoi confini.
In seguito a ciò, al dominio longobardo della Lucania e dell’Apulia, fu sottoposto anche quello della porzione nord-occidentale delle terre dei “Brittiorum”, mentre, la porzione sud-orientale di questo territorio, rimase in potere dell’impero bizantino. Il De administrando imperio (metà circa del sec. X), ricorda infatti che, al tempo della loro espansione, il dominio dei Longobardi aveva interessato tutto il territorio che sarebbe poi divenuto il thema di Longobardia, e parte di quella che sarebbe stata la Calabria (Kαλαβρίας,), eccetto Otranto, Gallipoli, Rossano, Napoli, Gaeta, Sorrento e Amalfi.[clii]
In questo quadro, il Crotonese assieme ad altri territori della parte centrale della regione, oltre a costituire un’importante frontiera marittima, andò così acquisendo anche un ruolo di confine terrestre tra le aree sottoposte al dominio longobardo e quelle mantenute dai Bizantini, come comincia ad essere evidenziato verso la fine del sec. VI.
Nel luglio-agosto del 596, i Longobardi del ducato di Benevento riuscirono infatti a predare la città di Crotone facendo schiavi i suoi cittadini, in cui soccorso intervenne papa Gregorio Magno che, per pagare il loro riscatto, destinò 15 libre d’oro “ad redimendos Crotonienses”[cliii] mentre, qualche anno dopo, a conferma di una presenza longobarda ormai sufficientemente radicata, troviamo lo stesso papa ricorrere ad Arechi, duca di Benevento, affinchè potessero essere trasportate a Roma, via mare, le travi tagliate “de partibus Brittiorum”, necessarie alle “ecclesias beatorum Petri ac Pauli”. Trasporto in cui furono coinvolti il vescovo di Tempsa e quello di Vibona, essendo questi, evidentemente, i luoghi previsti per l’imbarco.[cliv]
Questa nuova situazione è evidenziata sia attraverso le fonti bizantine, sia attraverso quelle longobarde, che ci descrivono il territorio conseguentemente a questi fatti, risentendo, comunque, della loro diversa appartenenza.
Secondo quanto riporta Georgius Ciprio, che menziona il Bριττίων o Bρεττανία tra i possedimenti bizantini dell’Italia (Ἰταλíας),[clv] agli inizi del sec. VII, appartenevano alla provincia o eparchia di Calabria (Ἐπαρχία Kαλαβρίας): Reggio (ʽΡήγιον), Locri (Λούϰρις), Squillace (Σϰυλαϰίας), Crotone (Kοτρώνων), Cosenza (Kωνσταντία), Tropea (Τροπαίων) e Tauriana (Ταυρίανα).[clvi] Vescovati che risultano menzionati in questo periodo, anche nell’epistolario di S. Gregorio Magno, quando erano ancora tutti immediatamente dipendenti dalla Santa Sede romana.[clvii]
La distinzione tra una “provincia” detta “Calabria Brindicensis” ed una detta “Pritas (sic) Rigiensis” è riferita, invece, dall’Anonimo di Ravenna (sec. VII).[clviii] La descrizione delle “Italiae provincias” esposta da Paolo Diacono (sec. VIII), identifica la “octava” con i nomi di “Lucania”, “cum Brittia” che, iniziando dal fiume “Silerio”, giungeva allo Stretto di Sicilia, comprendendo, dei “duae superiores”, il “cornu” destro dell’Italia da “Pestus et Lainus” fino a Reggio.[clix]
Tra Oriente ed Occidente
Rispetto a questa partizione del territorio che andava consolidandosi tra il dominio bizantino e quello longobardo, l’esistenza di una provincia di “Calabriae” e di una dei “Brutiorum” (Bρυτίων), in relazione ad una diversa dipendenza dei vescovati, rispettivamente, dal patriarca di Costantinopoli e dal papa di Roma, si evidenzia in occasione del sinodo romano del 680, quando volendo rimarcare la loro differente appartenenza, i vescovi di Tempsa, Squillace e Crotone si dichiararono della “provinciae” o eparchia (ἐπαρχίας) dei “Brutiorum” (Bρυτίων), mentre i vescovi di Tauriana, Tropea, e Turio si dichiararono appartenenti a quella di “Calabriae” (Kαλαβρίας), come del resto fece anche il vescovo di Taranto.
In altri casi, tale appartenenza risulta invece omessa in alcune versioni dei diversi testi pervenutici, come riscontriamo nel caso dei vescovi di Locri e Vibo della provincia di Calabria e per quello di Cosenza della provincia dei Brettii, altre volte risulta contradditoria, come nel caso del vescovo di Otranto, che risulta appartenente alla provincia di Calabria nel testo greco, mentre le versioni latine riportano una l’appartenenza ai Brettii l’altra alla Calabria.[clx]
Questa ed altre apparenti incongruenze, come quella evidenziata dal caso di Abundantio vescovo di Tempsa, che a volte figura quale vescovo di Paterno, accanto alla evidente impossibilità di ricondurre nell’ambito di un unico circuito territoriale tutti i vescovati menzionati nell’ambito della stessa provincia, evidenziano come, a quel tempo, oltre ad essere ancora indipendenti l’uno dall’altro, questi fossero ancora privi di una struttura diocesana definita in un ambito territoriale unico.
Gli aspetti che emergono in questa occasione, evidenziano comunque la volontà dei vescovi, in qualità di principali autorità locali cittadine, di porre in essere i primi adeguamenti alle trasformazioni intervenute, attraverso scelte di campo che evidentemente, dovevano tenere conto delle prospettive create attraverso la partizione del territorio ed in relazione alla contrapposizione in essere tra il mondo orientale e quello occidentale. Un solco che andrà approfondendosi nel tempo con l’inasprirsi di tale contrapposizione, in particolare dopo l’ulteriore espansione longobarda dei sec. VII-VIII quando, delle “due punte” o corna che costituivano le estreme propaggini della penisola italiana, rimase in potere dei Bizantini solo quella più meridionale.
In questo quadro instabile e conflittuale, dopo la promulgazione dell’editto che vietava il culto delle immagini nelle chiese (730) e per ritorsione all’opposizione del papa Gregorio III, l’imperatore bizantino Leone III l’Isaurico (717-741), comandò la confisca del patrimonio appartenenente alla Chiesa romana esistente nell’ambito del dominio bizantino, sottoponendo tutti i vescovati al patriarca di Costantinopoli.[clxi]
A seguito di ciò, in occasione di alcuni concili successivi tenuti dalla Chiesa orientale, troviamo che la partecipazione dei vescovi della regione, fu limitata a quelli appartenenti alla sua porzione più meridionale. Come riscontriamo in occasione della partecipazione dei vescovi di Reggio, Santa Cyriaca, Vibona, Crotone, Tropea, Nicotera e Tauriana al secondo concilio di Nicea del 787,[clxii] e come rileviamo ancora, in occasione del quarto concilio di Costantinopoli (869-870), quando furono presenti quelli di Crotone, Tempsa, Santa Cyriaca, Squillace, Reggio e Tauriana,[clxiii] occasioni in cui, tra l’altro, non risulta menzionata la loro appartenenza ad una particolare provincia.
Per quanto riguarda invece i vescovi della parte settentrionale della regione durante questo periodo, sappiamo che il vescovo di Cosenza e quello di Bisignano, parteciparono al concilio romano del 743 assieme ai vescovi del ducato di Benevento,[clxiv] mentre, non risultano tra i partecipanti del concilio di Nicea del 787 e di quello Costantinopolitano del 869-870. Sappiamo ancora che nell’849, Cosenza e Cassano, in qualità di gastaldati dipendenti da Salerno, compaiono nell’atto di spartizione del ducato di Benevento.[clxv]
In una prospettiva occidentale, il consolidamento del toponimo “Calabria”, è evidenziato in questo periodo, dall’apparire dei termini di Calabria “superioris” ed “inferioris” utilizzati per indicare le due estremità della penisola italiana. Termini che ritroviamo già in Einhardo, che vi ricorre per evidenziare il confine tra Longobardi e Bizantini al tempo di Carlo Magno (768-814), scrivendo circa due decenni dopo la morte dell’imperatore: “… deinde Italiam totam, quae ab Augusta Praetoria usque in Calabriam inferiorem, in qua Grecorum ac Beneventanorum constat esse confinia, …”.[clxvi]
I termini di Calabria superiore ed inferiore, ricorrono in questo periodo anche nell’ambito della documentazione vaticana, attraverso la menzione di un “patrimonium Calabriae inferioris et superioris”, come troviamo nel privilegio fatto il 10 luglio 818 dall’imperatore Ludovico Pio al papa Pasquale I (817-824),[clxvii] e come continuiamo a trovare anche nei privilegi e nelle conferme prodotti dalla cancelleria imperiale successivamente, secondo l’uso che prevedeva di riprendere la stesura del testo originario. Ne abbiamo riscontro nel privilegio fatto il 13 febbraio 962 dall’imperatore Ottone I al papa Giovanni XII (955-964)[clxviii] ed ancora, nel diploma di conferma delle donazioni e dei privilegi già concessi alla chiesa di Roma, fatta nell’aprile 1020, dall’imperatore Enrico III al papa Benedetto VIII (1012-1024).[clxix]
I Saraceni
A seguito della conquista musulmana della Sicilia avviata nel 827,[clxx] la Calabria, già interessata dalle scorrerie dei Saraceni, fu esposta più direttamente alla loro minaccia che, in particolare, si concretizzò attorno alla metà del secolo, attraverso l’occupazione di Amantea e Santa Severina.[clxxi] Due capisaldi strategici per il controllo dei collegamenti tra la parte meridionale e quella settentrionale della regione, che furono riportati successivamente in potere dei Bizantini, per opera dello “stratego di Calabria” Niceforo Foca il Vecchio (885-886),[clxxii] nell’ambito di una vasta campagna di riconquista dell’Italia meridionale, che consentì di arginare l’espansione dei Saraceni e d’imporre il dominio di Bisanzio alle terre dei Longobardi.
Anche continuando a rimanere soggetto alle scorrerie dei musulmani, alle ambizioni degli imperatori occidentali ed a quelle dei papi della Chiesa romana, a seguito di ciò, nell’ambito di quella che era al tempo l’organizzazione dei possedimenti dell’impero di Bisanzio, il territorio riconquistato fu suddiviso in due “themata” (ϑέματα): il thema di Longobardia ed il thema di Sicilia, da cui dipendeva militarmente la Calabria (Kαλαβρίας) che, verosimilmente, rimase in questa situazione fino al tempo delle ultime conquiste musulmane nell’isola, relative alla presa di Catania (900) ed a quella di Taormina (902).
Nel De thematibus (databile agli anni Trenta del sec. X), a proposito del decimo thema di Sicilia, si riferisce, infatti, che Reggio, S. Cyriaca, Santa Severina (ἁγίας Σεβηρίνης), Crotone (Kρότων) ed altre in Calabria (Kαλαβρία), erano sottoposte allo stratego di Calabria (στρατηγòς Kαλαβρίας)[clxxiii] mentre, nel De administrando imperio (databile al periodo 948-952 secondo la stima di G. Moravcsik), si riferisce che la “strategia” di Calabria (Kαλαβρίας στρατηγὶς), era stata in passato “ducato” (δουϰάτον) della strategia di Sicilia.[clxxiv]
Una nuova “tattica”
Risentono del nuovo assetto prodotto dalle conquiste militari di Niceforo Foca, i provvediemti che la Chiesa orientale mise in campo in questo periodo, con l’intento di stabilizzare e rafforzare il proprio potere, nei luoghi di confine maggiormente sensibili e particolarmente esposti da un punto di vista strategico, gratificando i principali centri urbani del nuovo scacchiere ricostituito.
Prima fra tutte la città di Reggio che, per la sua tradizionale posizione di dominio sullo stretto, era divenuta, all’attualità, il confine con il mondo musulmano, in seconda battuta i centri che garantivano i principali accessi all’istmo posto tra i golfi di Vibo e di Squillace, dando altresì particolare rilevanza a tutta l’area interna posta tra il Crotonese, il Rossanese e la Sila, dove l’antica identità greca dei centri della costa ionica, doveva poter interfacciare un’ormai consolidata presenza longobarda nell’interno.
Risale infatti a questo periodo la “Néa tacticà” o “Diatyposis”, compilata al tempo di Leone VI il Filosofo (886-911), che elenca le metropoli e le diocesi soggette al patriarcato di Costantinopoli, dove risulta che alla metropoli di “Reggio di Calabria” (ʽΡηγίῳ Kαλαβρίας), “che esisteva nei primi del secolo IX”,[clxxv] erano sottoposti tutti gli antichi vescovati della regione, assieme ad altri di più recente erezione.
In questo elenco, oltre agli antichi vescovati di Vibona (ὁ Βιβώνης), Tauriana (ὁ Ταυριάνης), Locri (ὁ Λοϰρίδος), Squillace (ὁ Σϰυλαϰίου), Tropea (ὁ Τροπαίου), Crotone (ὁ Kρωτώνης), Cosenza (ὁ Kωνσταντίας) e Nicotera (ὁ Nιϰοτέρων), troviamo infatti, quelli più recenti di Bisignano (ὁ Bισουνιάνου) e di Rossano (ὁ ʽΡoυσιανοῦ), eretti nell’area che aveva precedentemente visto la presenza di Thurii, mentre quelli recenti di Amantea (ὁ ’Aμαντίας) e di Nicastro (ὁ Nεοϰάστρου), andarono a prendere il posto di quello di Tempsa, ereditandone e rafforzandone il ruolo.[clxxvi]
Un rafforzamento che interessò particolarmente i luoghi precedentemente oggetto dell’occupazione musulmana e della successiva riconquista bizantina, come nel caso di Amantea, Tropea e Santa Severina (Ἁγίας Σευηρίνης).[clxxvii] Riconquista attuata attraverso le armi, secondo il monaco benedettino Erchemperto,[clxxviii] facendo invece ricorso ad un accordo, secondo le fonti musulmane.[clxxix]
In tale frangente, la particolare importanza di “Santa Severina di Calabria” (Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας), è posta in risalto attraverso la sua erezione a nuovo vescovato, istituito come nuova metropolia di un vasto territorio ai confini della Sila, cui furono sottoposti i quattro nuovi vescovati di Umbriatico (ὁ Eὐρυάτων), Cerenzia (ὁ ’Aϰερεντίας), Belcastro (ὁ Kαλλιπόλεως) e Isola ([ὁ] τῶν ’Aησύλων).[clxxx]
Vescovati greci posti in maggioranza lungo il limite dove, da alcuni secoli, gravitava la presenza delle popolazioni longobarde del Cosentino, la cui antica origine di centri sorti su questo confine naturale, divenuto etnico e religioso e quindi, politico e militare, è posta in evidenza dal titolo delle loro nuove cattedrali che, fatta eccezione per quella di Isola, che sappiamo dedicata alla Vergine al tempo dei Normanni, furono tutte consacrate ad una theoria di santi guerrieri: San Michele Arcangelo a Belcastro, San Teodoro a Cerenzia e San Donato ad Umbriatico.
L’importanza della linea di confine tra la parte settentrionale e quella meridionale della regione, lungo le valli dei fiumi Crati e Savuto, sottolineata dall’emergere di nuove realtà vescovili, risulta confermata anche in seguito.
In un rimaneggiamento della Diatiposi che si ritiene anteriore al Mille, ma la cui redazione è del tempo dell’imperatore Alessio Comneno (posteriore al 1084),[clxxxi] ai vescovati sottoposti alla metropolia di “Calabria ossia di Reggio” (Τῷ Kαλαβρίας ἤτοι τοῦ ʽΡηγίου) già menzionati precedentemente, risulta aggiunto quello di Cassano (ὁ Kασάνου),[clxxxii] mentre quello di Policastro (ὁ τοῦ Пαλαιοϰάστρου) risulta aggiunto alla metropolia di Santa Severina.[clxxxiii]
A conferma dell’esistenza di una situazione delicata in queste aree di confine, dove gli interessi del patriarca di Costantinopoli dovevano fronteggiare quelli del papa romano, la documentazione vaticana trova i vescovati di Bisignano, Malvito e Cosenza, tra quelli soggetti alla nuova metropolia latina di Salerno (983).[clxxxiv]
Italia o Calabria
Dopo la campagna di riconquista dell’Italia meridionale condotta da Niceforo Foca, le differenze etniche e religiose, esistenti tra le aree greche e quelle latine ricadenti nell’ambito dei possedimenti bizantini, produssero anche un diverso uso rispetto al passato, degli antichi nomi di Italia e Calabria, che discendeva dal linguaggio adottato dalla struttura amministrativa romana.
Il primo che, fin da quei tempi, aveva sempre indicato tutta la penisola italiana distinta dalla Sicilia, pur continuando a mantenere questo significato generale, nell’ambito dei possedimenti bizantini, andò invece ad identificare, assieme a quello più recente di Longobardia, solo i territori dove si era insediata la popolazione latina, mentre il secondo rimase ad identificare quelli dove tradizionalmente, era stanziata la popolazione greca.
Una situazione evidenziata dalle informazioni che ci provengono circa le magistrature bizantine del periodo compreso tra la fine del sec. IX e la metà del sec. XI, che distinguono una diversa giurisdizione, tra l’ambito del territorio di Longobardia, ovvero d’Italia, e quello del territorio di Calabria, a volte riuniti entrambi sotto l’autorità di un solo ufficiale.
Ne abbiamo notizia con riferimento all’organizzazione militare, in merito all’ufficio di stratego che distingueva tra quello di Longobardia e quello di Calabria (στρατηγòς Kαλαϐρίας),[clxxxv] ma anche nell’ambito giudiziario, come si evidenzia nel caso di Euprassio, giudice d’Italia e di Calabria (ϰριτοῦ γεγονότος Ἰταλίας χαὶ Καλαϐρίας),[clxxxvi] o quando si menziona “Leo (Potus) Spatharocandidatus a secretis et iudex Longobardiae et Calabriae”,[clxxxvii] oltre che nell’ambito amministrativo, come rileviamo attraverso le diverse testimonianze relative all’ufficio di catapano d’Italia (ϰατεπάνω ἰταλίας)[clxxxviii] che, a volte, riuniva a questo lo stesso incarico relativo al territorio di Calabria (“protospatharii et catepani Italiae et Calabriae”).[clxxxix]
Tale distinzione ricorre anche nei geografi musulmani, durante il sec. X: il persiano Ibn Rustah e al-Mas‘ūdī, ricordano la Calabria (Qalūriya) abitata da “franchi e longobardi (Lu‘bardiyyūn)” mentre, verso la fine del secolo, Ibn Ḥawqal riferisce che, ad est della Sicilia, sul litorale del “grande continente dove si trova Costantinopoli, sorge la città di Rīw (Reggio), poi vi sono le provincie di Qalūriya (Calabria)”.[cxc]
Dalla parte tirrenica, il confine tra Calabria e Longobardia era rappresentato dal limite del principato longobardo di Salerno, come descrive ancora Ibn Ḥawqal: “Indi il territorio della Qillavrîah (Calabria) confina con quello di Άnkubardah (Longobardia, i Principati Longobardi), il primo de’ quali è S.tûr.y (leggasi Salerno). Indi [si viene a’] contorni di Malf (Amalfi): la più prospera città di Longobardia …”[cxci] mentre, dalla parte ionica, il limite tra queste due realtà era costituito dal territorio della città di Cassano ed in particolare, dall’antico luogo confinario che continuava ad essere detto “Petram Sanguinariam”, come riferisce un atto del 18 aprile 969, stipulato “in Kalabria in suburbio Cassano”. Questo documento riferisce che quando l’imperatore Ottone I si trovava “in Kalabria”, “in confine atque planicie que est inter Cassanum et Petram Sanguinariam, ibique nostro imperiali iure”, aveva imposto a tutti i suoi sudditi, tanto ai Calabresi (“Kalabris”), quanto a tutti gli Italici, sia Franchi che Germanici (“omnibus Italicis Francisque atque Teutonicis”), le leggi ed i precetti dell’impero.[cxcii]
Una posizione di confine che, alcune volte, risulta riferita come quella esistente tra la Puglia e la Calabria, come evidenzia per questo periodo, il bios dell’abbate Gregorio di Burtscheid, che ricorda il santo come “in confinio Calabriae et Apuliae oriundus”.[cxciii]
Questa situazione risulta confermata durante l’offensiva condotta dall’imperatore d’Occidente Ottone II contro i musulmani nella primavera-estate del 982. In questa occasione, dopo lo scontro con l’esercito nemico e la disfatta delle forze imperiali, il 13 luglio 982 presso Crotone,[cxciv] l’imperatore, che era riuscito a trovare riparo via mare a Rossano, si avviò verso Salerno. Il 27 luglio egli era “in Calabria iuxta civitatem que dicitur Cassianum”, mentre il 31 si trovava “in Calabria iuxta civitatem quae dicitur Rossianum”. Il 2 agosto egli era ancora “in Calabria” presso il fiume detto “Laginum”, come testimonia un atto stipulato “in Calabria iuxta flumen quod vocatur Laginum”.[cxcv]
Gli uomini del nord
Dopo la conquista da parte dei Normanni, la provincia di “Calabria”, anticamente detta “Britania”, come riferisce Guidone nella sua Geografia, verso gli inizi del sec. XII,[cxcvi] ormai in mano ai nuovi conquistatori che avevano sconfitto i Bizantini “circa Crotonem in Calabria”,[cxcvii] fu sottoposta al dominio di Roberto il Guiscardo.
Quest’ultimo, sulla scorta di quanto risulta precedentemente documentato per Argiro figlio di Melo che, nel maggio 1054, compare con il titolo di duca d’Italia, Calabria, Sicilia e Paphlagonia (δουκὸς ἰταλίας ϰαλαβρίας σικελίας παφλαγονίας),[cxcviii] attraverso la concessione di papa Nicolo II (1059-1061) e sulla base dell’autorità arbitraria della chiesa romana, nell’agosto del 1059 assunse il titolo di “dux Apuliae et Calabriae” per grazia di Dio e di San Pietro, augurandosi, come recita il suo “Iuramentum” fatto al papa, qualificandolo così come il proprio signore (“domino meo”), di divenire presto anche duca di Sicilia, con l’aiuto d’entrambi.[cxcix]
A seguito di ciò, le “Calabritans ecclesias, que in terra iuris sanctae Romanae Ecclesiae, consistunt”, furono tutte sottoposte all’autorità della Sede apostolica di Roma.[cc] Fatto che produsse alcuni cambiamenti significativi nella organizzazione ecclesiatica del territorio dove, alla metropoli di Reggio, pur confermata, rimasero solo i vescovati della porzione meridionale della Calabria. Tale situazione appare riconducibile già al tempo di papa Gregorio VII (1073-1085), come ricorda la bolla di Alessandro III del 19 novembre 1165: “Archiepiscopo Rhegino confirmat iura metropolitana super ecclesiis Tropeensi, Neocastrensi, Sillana, Cassanensi, Bovensi, Geratina, Opensi et Crotonensi.”.[cci]
Una realtà in radicale trasformazione
Le informazioni circa i vescovati calabresi di questo periodo, che ci provengono dalle fonti medievali, spesso posteriori ai fatti del tempo ed a volte, contraddittorie, oppure, in alcuni casi, palesemente false, risentono notevolmente delle trasformazioni che interessarono il territorio conseguentemente alla conquista normanna. Evento che, segnando la fine del lungo dominio bizantino iniziato nella prima metà del sec. VI d.C., determinò il progressivo abbandono delle forme di governo del territorio, proprie del precedente passato imperiale, attraverso l’introduzione del rapporto feudale.
La riorganizzazione dei vescovati calabresi in funzione di tale rapporto, sarà comunque un processo ancora lungo che, seguendo la definizione dei nuovi territori, dimensionati secondo l’articolazione dei rapporti di forza stabiliti tra i nuovi signori, determinerà la formazione delle “terre”. Un processo mediante il quale, ad esempio, l’antica organizzazione legata all’originaria dimensione di monastero ancora posseduto dalla chiesa cattedrale di questo periodo, sarà ricomposta nel tempo attraverso la costituzione delle diocesi cittadine, mentre permarrà altrove ancora a lungo, continuando a caratterizzare l’organizzazione rurale delle abbazie.
Tracce di questo antico assetto, comune a tutte le realtà vescovili del tempo, emergono, ad esempio, attraverso la notizia riferita dal Fiore, secondo cui, la chiesa di Isola fu anticamente un monastero benedettino, il cui abate trasformò attorno al Mille in cattedrale,[ccii] o attraverso quella che, lo stesso Fiore, riferisce circa l’appartenenza alla “diocesi di Gerenzia” del monastero Tassitano posto nella Sila.[cciii]
Ancora al tempo del c.d. Decennio francese, nei luoghi silani, la Mensa vescovile di Cerenzia possedeva la difesa di Trepidò Sottano[cciv] mentre, a riscontro di quello che era stato il suo antico assetto ecclesiastico, sorto nell’ambito di un vasto territorio che aveva visto la presenza d’importanti realtà dell’evo antico, rileviamo che, al tempo della erezione della cattedrale di Cariati (1437), quest’ultima fu unità alla sede vescovile di Cerenzia[ccv] e non a quella più vicina Umbriatico, costituendo la nuova diocesi con i territori di Cariati, Scala, Terra vecchia e S. Maurello che, precedentemente, facevano parte della diocesi di Rossano, alla quale andarono quelli di Campana e Bocchigliero, precedentemente appartenuti alla diocesi di Cerenzia.[ccvi]
Una chiara illustrazione di questa situazione relativa alla persistenza dell’antica organizzazione delle chiese calabresi al tempo dell’arrivo dei Normanni, ci proviene da un “brébion” risalente a verso la metà del sec. XI, che elenca i beni fondiari posseduti della metropolia di Reggio, ovvero di “Calabria” (Καλαβρίας).[ccvii]
Attraverso tale documento apprendiamo che, ancora durante tale periodo, quest’ultima possedeva beni in una vasta area della Calabria che ricadevano anche in luoghi molto distanti dalla città. Pur nell’incertezza legata alla difficile identificazione di molti luoghi menzionati in questo documento, emerge, comunque, come l’area in cui ricadevano tali possessi, o almeno quelli riferiti ai luoghi più chiaramente identificabili, sembra escludere completamente il Cosentino e l’area silana corrispondente, giungendo sino al limite costituito dal corso dei fiumi Crati e Savuto.
Per quanto attiene ai luoghi della regione più prossimi al Crotonese, oltre a possedere beni fondiari a Taverna, a Squillace ed a Soverato,[ccviii] la metropolia di Reggio possedeva anche il monastero di San Giovanni di Campolongo (Καμπoλόγγoυ),[ccix] e sempre in questa località, che è richiamata negli antichi privilegi del vescovo di Isola,[ccx] aveva il possesso di Santa Vennera a Campolongo (Καμπoλόγγoν).[ccxi]
Alla metropolia di Reggio appartenevano anche i beni del monastero di Santa Eufemia di Nicastro, che era una sua grangia, tra cui quelli posti lungo il versante ionico a sud del fiume Crati, che si trovavano presso il corso dello stesso fiume, di fronte a “Lykosyria” (Λυϰoσύρια), vicino a Mandatoriccio (Mανδατoριτζίων), ed ancora in questa stessa località, presso il mare di Alice (Ἁλυϰῆς), con la montagna chiamata Castiglione (Kαστελίoνας).[ccxii] Altri beni della grangia di Santa Eufemia in quest’area, si trovavano ancora presso Palopoli (Παλαιoπόλεως), a Volviti (Boυβλίτoυ), di fronte a Cariati (Kαριάτι) ed a Manipuglia (Moνoπoύλια).[ccxiii]
Sempre in quest’area compresa tra il corso del fiume Trionto e quello del fiume Neto, la metropolia di Reggio possedeva, ancora, il monastero di San Nicola di Campana (τῆς Καμπάνας),[ccxiv] ed il monastero di Santa Marina, che deteneva possessi posti a “Ptéléa” (Πτελέαν) e Melissa (Mελισσά).[ccxv] Il casale di “Ptéléa” (Xωρίoν Ἡ Πτελέα), sopravvivenza medievale dell’antica città dei Brettii, apparteneva interamente alla metropolia.[ccxvi]
Accanto all’antica organizzazione della Chiesa, anche quella relativa alle istituzione civili facenti capo all’organizzazione imperiale, rimase in uso in Calabria ben oltre i primi anni della conquista normanna.
L’esistenza del thema di Calabria (ϑέματη ϰἀλἁβρίας), cui apparteneva il castrum di Stilo, documentata da un atto che il Trinchera attribuisce al novembre 1059, dove Stephano risulta vicario di Calabria (προσωπου ϰαλαβριας) del dominus Antioco, protospatario imperiale e stratego di Calabria (στρατηγου ϰαλαβριας),[ccxvii] continua ad essere documentata da un atto del 1079, che riferisce l’appartenenza della città di Gerace al thema di Calabria.[ccxviii]
In riferimento più specifico al Crotonese, accenni relativi alle trasformazioni delle istituzioni appartenenti al precedente ordinamento politico-amministrativo bizantino, durante questo primo periodo del dominio normanno, emergono attraverso alcuni documenti del secolo successivo.
Lo stratego (στρατηγοϋ) Petro Drako è menzionato in un documento del 1115-1116 (a.m. 6624) relativo ad una concessione enfiteutica in territorio di Roccabernarda,[ccxix] mentre Costa, notaro e stratego di Santa Severina e Crotone (νoτάριoν ϰαὶ στρατηγὸν ἁγίας σευηρίνας ϰαὶ ϰρoτόνης), risulta menzionato in un atto dell’aprile 1121, relativamente ad una sentenza riguardante alcune terre poste in territorio di Santa Severina.[ccxx] Ufficio che, in una carta latina del 1118, appare invece ricoperto da “Girardum baiulum Sancte Severine et Cutroni”.[ccxxi]
Michele, catapano di Crotone (ϰατεπάν ϰρoτωνoς), sottoscrisse un atto del 1159 (a.m. 6667),[ccxxii] mentre Nicola, catapano di Cerenzia (ϰἀτεπανoς ἀϰερετιας), sottoscrisse un atto del 1170 (a.m. 6678).[ccxxiii]
I due fratelli
Più che attraverso i pochi documenti conservati, le prime trasformazioni in atto, generate dall’introduzione del rapporto feudale, emergono attraverso alcune cronache medievali, che ci forniscono un racconto ricavato sulla base delle gesta dei principali personaggi artefici di questo periodo, attraverso le dispute e le lotte che trovarono protagonisti questi nuovi padroni.
Relativamente all’anno 1058, il Malaterra riferisce che, fatta pace tra di loro, Ruggero avrebbe ottenuto dal duca Roberto suo fratello, la concessione di “medietatem totius Calabriae a iugo montis Nichifoli et montis Sckillacii”, parte già conquistata, fino a Reggio, anche se quest’ultima porzione rimaneva ancora da conquistare e lo sarebbe stata solo nel 1060. Questo confine, identificabile attraverso una linea che dall’Angitola sulla costa tirrenica, raggiungeva quella ionica presso Squillace, era in effetti quello da sempre più importante per il controllo dei movimenti tra le due parti della Calabria divise dall’istmo.[ccxxiv]
Non stupisce, quindi che, in tale contesto, sempre secondo quanto riporta il Malaterra, nell’anno 1065 il duca Roberto, assieme al conte Ruggero suo fratello, realizzarono una spedizione che li portò all’assedio di alcuni “castra Calabriae”, posti in posizioni chiave di questo confine. Tale azione condotta contro il castrum di Policastro ed “in provincia Cusentii”, contro quelli di “Rogel” (Rogliano ?) e di “Ayel” (Aiello),[ccxxv] sembra poter essere inquadrabile nel contesto di quelle che, successivamente, trovarono ancora protagonisti i due Altavilla, contro altri importanti capisaldi che presidiavano il confine tra la parte meridionale e quella settentrionale della regione.
Come indicano i fatti riferibili agli anni 1073/74, relativi alle vicende relative alla disputa che interessò il controllo della città di Santa Severina, episodio subito conseguente alla conquista di Palermo (gennaio 1072), a seguito della quale, secondo Amato di Montecassino, i due fratelli giunsero ad accordarsi circa la spartizione delle terre già conquistate, spartendosi anche quelle che lo sarebbero state in futuro. In questa occasione, Roberto avrebbe concesso a Ruggero la metà della Sicilia, assieme alla metà della Calabria che già deteneva.[ccxxvi]
Questa loro sintonia d’intenti appare evidenziata anche in occasione dell’episodio conseguente a questi fatti, riguardante Santa Severina, quando i due intervennero assieme nella lotta contro l’altro loro familiare Abagelardo, figlio del conte Humfredo che, divenuto ribelle al duca Roberto suo zio, si era arroccato “apud Sanctam Severinam, Calabriae urbem”. Qui, dalla Sicilia, si recò ad assediarlo il conte Ruggero, chiamato dal duca suo fratello, al quale, in seguito, giunse a dare manforte lo stesso Roberto. Fu così che, stretto d’assedio attraverso l’erezione di “tria castella”, Abagelardo fu costretto a cedere la città.[ccxxvii]

Sigillo del capitolo di Santa Severina che raffigura Santa Anastasia reggere in mano un simulacro della città con tre castelli.
Nelle “terre” di Calabria
Le lotte che avevano trovato protagonisti i primi conquistatori, ripresero vigore dopo la morte di Roberto il Guiscardo (1085) quando, in relazione alla sua successione, i Normanni si divisero in due fazioni contrapposte. Una facente capo al duca Ruggero detto Borsa (1085-1111), figlio del Guiscardo e di Sichelgaita, indicato dallo stesso Roberto quale suo successore, l’altra che parteggiò per Boemondo, nato dal primo matrimonio di Roberto con Alberada, poi ripudiata.
Durante tale critico frangente, sempre secondo il racconto del Malaterra, nel 1085, il conte Ruggero si schierò dalla parte del duca Ruggero Borsa che, in questa occasione, lo avrebbe ricompensato concedendogli per intero, “omnia castella Calabriae, quorum necdum nisi medietatem cuiusquam comes Rogerius habebat”.[ccxxviii]
In questo quadro si svilupparono i fatti che condussero alla costituzione della contea di Catanzaro quando, nel 1087, Mihera “filius Hugonis Falloc”, che aveva ereditato dal padre “Catanzarium et Roccam” (Rocca Fallucca), si schierò con Boemondo impadronendosi di “Maja” (Maida).
Avvenuta però la riconciliazione tra Boemondo ed il duca Ruggero, Mihera cercò di rientrare nelle grazie del duca restituendogli Maida. La sua mossa fu vana, perché il conte Ruggero e Roberto de Loretello, figlio di Goffredo, fratello di Roberto il Guiscardo, che il duca Ruggero aveva chiamati in suo aiuto contro Boemondo, sfruttando l’occasione favorevole, lo attaccarono per impadronirsi delle sue terre.
Mihera, rifiutando lo scontro, si ritirò monaco a Benevento, lasciando erede il figlio Adam. Anche questi, comunque, fu costretto alla resa, ma prima di cedere all’assedio postogli nel 1088 da Rodulpho de Loretello, fratello minore di Roberto, appiccò il fuoco ai propri beni. Fu così che questi fatti condussero il conte Ruggero e Rodulpho a spartirsi le sue terre,[ccxxix] portando quest’ultimo a divenire il primo conte di Catanzaro (1088-1098).[ccxxx]
La particolare importanza strategica di Catanzaro nel quadro dei collegamenti tra la Puglia e la Sicilia durante questo periodo, si evidenzia assieme a quella di altri centri del versante ionico della Calabria, come Cerenzia e Rossano.
In questi ultimi anni del secolo, infatti, le lotte per stabilire il dominio feudale dei luoghi appartenenti a quest’area, coinvolsero anche l’antica Cerenzia, il cui territorio, limitrofo a quello rossanese, s’andava a formare alle falde della Sila che lo divideva dal Cosentino.
Secondo le cronache, che riconducono i fatti al 1090, al tempo in cui il conte Ruggero si accingeva alla spedizione contro Malta, lo scontro con quest’ultimo sarebbe nato dal rifiuto di “Mainerius de Gerentia” di partecipare all’impresa. Constatata tale insolenza, il conte avrebbe quindi differito la sua partenza per Malta, spostandosi dalla Sicilia “in Calabriam”, per ricondurre al proprio volere il feudatario ribelle. Quest’ultimo, atterrito dall’assedio postogli da Ruggero, sarebbe dunque giunto a più miti consigli, e chiedendo supplice la misericordia del conte, si sarebbe sottomesso pagandogli mille solidos d’oro.[ccxxxi]
Rispetto a questo sviluppo dei fatti fornitoci dal Malaterra, diversa appare la conclusione della vicenda secondo le cronache di Lupo Prothospatario e di Romualdo Salernitano che, concordemente, riferiscono la devastazione e l’incendio della città di “Acherontia” nel 1090.[ccxxxii]
In questo caso, come abbiamo visto precedentemenete, in occasione dell’episodio che condusse alla costituzione della contea di Catanzaro, al pari di altri menzionati dalle cronache medievali, tali devastazioni, prodotte ricorrendo all’incendio dei luoghi, vanno interpretate alla luce del processo di ricomposizione del territorio, assumendo un significato rigenerativo/rifondativo.
Nell’ambito della “Calabria”, limite di tale azione condotta negli antichi territori di tradizione greca, risulta essere stato Rossano che, in questa fase, assunse funzioni di confine. Già nel bios di San Nilo, infatti, dove si distingue l’Italia (ovvero la Longobardia) dalla Calabria, in qualità di territori differenti,[ccxxxiii] Rossano è ricordata ai confini della Calabria (Kαλαϐρίας τέρμασι).[ccxxxiv] Il Malaterra individua la città, dove il duca eresse il castello (1073), nella provincia di Calabria,[ccxxxv] come conferma un atto del 1091, dove si specifica l’appartenenza del luogo in cui si trovava il monastero di S. Adriano: “quod positum est in Calabria in pertinentiis Rossani”.[ccxxxvi]
La Valle del Crati
Dopo la conquista normanna, la porzione più settentrionale della Calabria, posta oltre il limite segnato dal corso del fiume Crati, territorio caratterizzato dall’antica presenza latina dei Longobardi, andò strutturandosi secondo un proprio assetto nell’ambito della nuova organizzazione feudale, assumendo anche una propria identità, distinta da quella del resto del territorio calabrese di tradizione greca.
L’esistenza del territorio detto di Valle Crati, posto nella porzione più settentrionale di quello di “Calabria”, secondo limiti che ricalcavano gli antichi confini, è posta in evidenza attraverso la narrazione delle vicende del monaco Vitale di Castronovo che, secondo quanto risulta riportato nel suo bios, dopo aver già vissuto per due anni in un monastero presso Santa Severina, ed essere ritornato in Sicilia, tornò nuovamente “in Calabriam” e “peragratis (sic) finibus”, giunse presso la città di Cassano (“Cassani civitatis”), fermandosi nel monte detto “Liporachi” e successivamente, visse nel luogo che “nunc Petra Roseti dicitur”.[ccxxxvii]
Questo luogo confinario, anticamente segnato dalla “pietra del sangue” posta presso il fiume Sinni, risulta evidenziato verso la metà del sec. XII, dal geografo musulmano Edrisi, che lo individua con il territorio della “città” di Roseto. Quest’ultima, posta a dodici miglia dopo il fiume Crati, si trovava a dodici miglia dal “confine tra i Franchi e i Longobardi”, posto nel luogo detto in arabo sahrat saku, espressione che l’Amari e lo Schiapparelli, pur in forma dubitativa, traducono in “il sasso del Sinno” ed individuano nella Pietra di Roseto. Sei miglia separavano questo confine dal fiume Sinni.[ccxxxviii]
La menzione del territorio di Valle Crati, si rinviene anche nella cronaca del Malaterra, opera che si ritiene scritta negli ultimi anni del sec. XI.
La localizzazione “in valle Cratensi” e nell’ambito della Calabria, del castrum posto in “loco qui Scribla dicitur”, è riferita da questo autore, in occasione dei fatti che, attorno alla metà del secolo, trovarono protagonista Roberto il Guiscardo “ad debellandos Cusentinos et eos qui adhuc in Calabria rebelles erant.”[ccxxxix] Tale situazione è evidenziata anche da un passo successivo di questa cronaca, relativo all’anno 1062, quando il territorio di Valle Crati compare nell’ambito della “provincia” definita “totam Calabriam”.[ccxl] Territorio al quale appartenevano Castrovillari e San Marco,[ccxli] a volte menzionato come “provincia” di Cosenza,[ccxlii] città comunque di “Calabriae”,[ccxliii] i cui confini meridionali sul versante tirrenico, erano rappresentati dal territorio di Martirano e dal corso del fiume Amato.[ccxliv]
Riscontrano questi racconti, alcuni documenti degli inizi del sec. XII. In un atto del 1112, il senescalco Riccardo, risulta “magister di tutta la Calabria” (μαΐστορος πάσης Kαλαβρίας),[ccxlv] mentre un atto del maggio 1130, riferisce che re Ruggero confermò all’abbate del monastero della “intemeratae Dei Matris et Novae Hodegetriae Patris”, tutti i privilegi e le donazioni di terre precedentemente fatte “in tota Valle Crathis, et Rusiani, et S. Mauri” (βαϑείαν τοῦ Γράτου ϰαὶ Ρoυσιανοῦ ϰαὶ ἅγιον Mαῦρον).[ccxlvi]
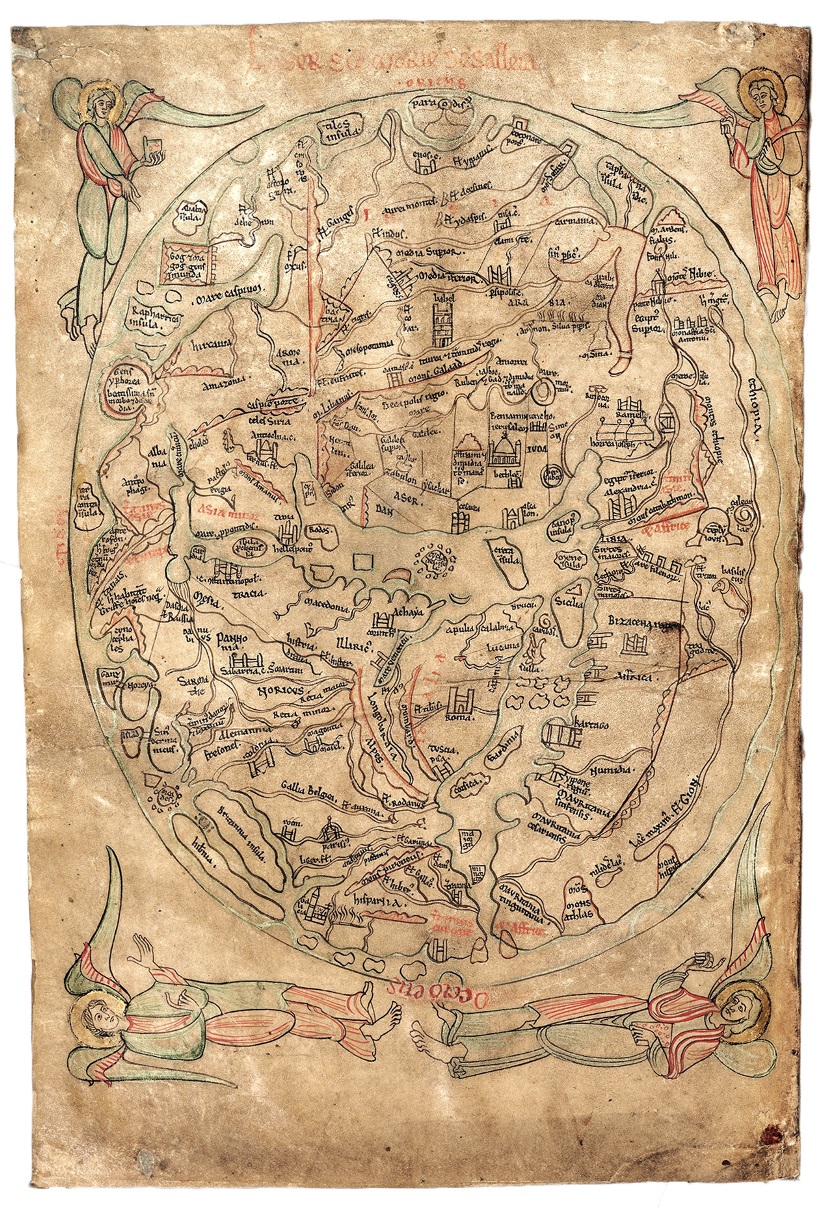
L’antica centralità della Calabria e dei territori vicini, continua ad essere rappresentata nella c.d. Carta di Sawley, la più antica mappa mundi inglese, che illustra la popolare cronaca storica del teologo Onorio Augustodunensis (1080-1154). In questa carta, disegnata con l’oriente in alto ed al cui centro troviamo l’isola di Delo, ritenuto il luogo di nascita di Apollo, le poche indicazioni relative all’Italia sono concentrate soprattutto nella sua porzione meridionale, dove compaiono i toponimi: “campania”, “lucania”, “apulia”, “calabria” e “brucii”, quest’ultimo retaggio relativo all’antico stanziamento di questa popolazione.
Santa Severina di Calabria
Sul confine con i territori della Valle del Crati, assieme con i vescovati che componevano la sua arcidiocesi, si trovava da tempo anche Santa Severina, ovvero Santa Severina “di Calabria” (Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας), come risulta documentato già verso la fine del sec. IX.[ccxlvii]
Questa sua posizione e questa sua appartenenza sono poste in evidenza in occasione della rifondazione dell’abbazia di Calabro Maria, detta anche della Vergine Maria de Calabro (poi detta di Altilia), posta in diocesi di Santa Severina, che fu una delle più antiche ed importanti abbazie di rito greco esistenti nella vallata del Neto.
Il toponimo “Calabro” rimanda alla località nella quale si trovavano le famose ed importanti Saline di Neto (“de salina Neti, quae est prope Calabromariam”), dette anche le “salinas Calabriae”,[ccxlviii] dove il luogo sacro dedicato alla Vergine Maria, come avvenne in altri casi similari, aggiunse il nome della località al toponimo agiografico.
Abbandonata ed andata in rovina, essa risorse alla fine del sec. XI, per opera del vescovo di Cerenzia Polycronio il quale, col consenso del metropolita di Santa Severina Costantino, la riedificò e la ripristinò, reintroducendovi i monaci, e la dotò di molti beni.
In questa occasione, su istanza dello stesso vescovo, l’abbazia fu confermata nei possessi e arricchita di privilegi dal duca Ruggero Borsa (“à Rogerio Duce Italiae, Calabriae, et Siciliae”), che il 31 maggio 1099 (a.m. 6607), in Tropea, le concesse il territorio silano di San Duca, libero da servitù e con ogni bene esistente, affinché i monaci potessero aprirvi un altro monastero.
In seguito, su richiesta dello stesso Polycronio, i beni dell’abbazia furono confermati dal conte Ruggero II (“Rogerio Comite Calabriae, et Siciliae”) che, in Santa Severina, il primo giugno 1115 (a.m. 6623), aggiunse 12 once annuali da riscuotere dalle saline di Neto, col solo peso per il monastero di versare tre libbre di cera alla chiesa di Santa Severina. Successivamente, il 18 ottobre 1149 (a.m. 6653), dietro l’esibizione dei privilegi del convento da parte del vescovo di Isola Tasimeo, lo stesso Ruggero II, nel frattempo divenuto re di Sicilia, confermò le concessioni precedenti, elargendo ai monaci altri privilegi nel quadro del contesto economico e produttivo del territorio in cui sorgeva la loro abbazia, che prevedevano di poter usare l’acqua del Neto per animare mulini, la giurisdizione sul casale Caria ed il libero pascolo nei tenimenti di Santa Severina e Roccabernarda per il proprio bestiame e per quello forestiero, nel caso quest’ultimo vi avesse pascolato per conto del monastero.[ccxlix]
L’ampiezza dell’area caratterizzata dalla presenza del toponimo “Calabria”, sottoposta alla città di Santa Severina risulta estesa ben oltre la località dove erano poste la Salina, l’abbazia dedicata alla Vergine ed il casale di Calabrò,[ccl] come dimostra l’esistenza del canonicato della cattedrale di Santa Severina intitolato alla chiesa di Santa Maria di “mon Calabria” o di “Boncalabria”/“BuonCalabria”, posta in territorio di Scandale, casale di Santa Severina, la cui esistenza comincia ad essere documentata agli inizi del Cinquecento,[ccli] anche se il toponimo sembra apparire già in periodo svevo, quando “Matheus de Mencalabri” (sic) sottoscrisse un atto dell’aprile 1224, riguardante il possesso di alcuni beni posti in tenimento di Santa Severina.[cclii]
In potere del duca
Alcuni atti che riportano le concessioni fatte dai signori feudali a cominciare dalla fine del secolo XI, documentano il lungo ed ininterrotto dominio dei duchi normanni nel Crotonese, fino al tempo della costituzione del regno di Sicilia.
Poco tempo dopo la conquista normanna, la cattedrale di Isola che risultava “diruta, lacerata et deserta”, fu ripristinata e ridotata per privilegi concessi nel maggio 1092 dal duca Ruggero Borsa (1085-1111). Privilegi che saranno confermati ed ampliati nel 1145, da re Ruggero II a Luca vescovo di Isola.[ccliii]
Le concessioni fatte dei duchi normanni sono documentate anche in seguito, come risulta per il duca Guglielmo (1111-1127), figlio del duca Ruggero Borsa, che troviamo in un atto del 1112, in qualità di duca d’Italia, di Calabria e di Sicilia (δουκὸς Ἰταλίας Kαλαβρίας καὶ Ʃικελίας).[ccliv]
In questa occasione, sottoscrivendo entrambi l’atto, il duca, assieme al senescalco Riccardo, “magister di tutta la Calabria” (μαΐστορος πάσης Kαλαβρίας), donarono a Thomas, categumeno del monastero di Santa Maria della Matina, l’ospedale edificato nella città di Crotone da Kottophridas Philbouè, con tutti i suoi domini, le sue terre, le vigne, le case ed i villani.[cclv]
Le concessioni di questi due signori feudali sono documentate anche in territorio di Santa Severina, come risulta in occasione della conferma dei privilegi dell’arcivescovo di Santa Severina, da parte del papa Lucio III (1183), tra cui sono ricordate le libertà e le immunità, precedentemente concesse ai suoi predecessori, dal duca Ruggero e dal senescalco Riccardo, figlio di Drogone conte di Venosa.[cclvi]
La lunga persistenza del dominio dei duchi normanni in territorio di Santa Severina, è ripercorsa dalle notizie contenute in un atto del novembre 1118 quando, “Girardum baiulum Sancte Severine et Cutroni”, sentenziò contro “Arnaldus de Fontana Coperta cognominatus”, in merito alla controversia sollevata da questi contro l’abbazia di Santa Maria della Matina, circa il possesso di alcune terre contese tra le parti, poste presso il fiume Tacina.
La ricostruzione dei fatti riportata nel documento, che ci fornisce indicazioni sull’articolazione locale del dominio feudale tra il dominus ed i suoi vassalli, faceva risalire l’originario possesso di queste terre, alla erezione da parte del “biscontis” di Santa Severina “Nicolaus qui de Grimaldo cognominatur, qui tunc castri Sancte Severine principabatur”, delle chiese di Santa Maria e di S.to Nicola, edificate “in loco Castelli et fluminis Tachine in uno loco” e dotate dallo stesso Nicola con propri beni ed animali, al fine di realizzare un “monasterium parvum quod est prope flumen Tachine”.
Dopo la morte del detto Nicola, il monastero era stato detenuto dal duca Ruggero Borsa (“dux ille fortis tunc dominus noster”, morto il 22.06.1111) che, prima, lo aveva concesso a “Brienio magnato suo” e, successivamente, all’altro suo “magnatus” “Alioctus”.
Dopo la morte di Aliocto, il duca aveva concesso il monastero a “Gottofridus filius Yvum” e dopo la morte di quest’ultimo, l’aveva concesso a “Cheles comestabulus” che, successivamente lo aveva restituito al duca. Questi lo aveva quindi dato, a “Fulconem de Monte Curbino” che, in seguito, con l’assenso del “metropolitanus dominus Gregorius”, aveva infine offerto il detto “monasterium subiectum”, alla “Sanctissime Marie Dei genitricis de Matina”.[cclvii]
Un’altra concessione da parte del senescalco Riccardo, si rileva, in questo periodo, nell’ambito diocesano di Umbriatico, come evidenzia un atto del 15 giugno 1115 scritto “aput castrum S. Mauri, quod est in Calabria”, luogo forse identificabile con quello menzionato da Edrisi, posto a cinque miglia da Rossano, a sei dal mare ed a nove da Bisignano.[cclviii] In questa occasione, al fine di realizzare “aliquam mansionem vel receptaculum in terra nostra, que ad Ebriaticum pertinet”, il senescalco Riccardo, presente alla stesura dell’atto, figlio del gran conte Drogone (“Ricardus, senescallus, magni comitis Drogonis filius”), “pro rimedio” della sua anima, di quella di suo padre, “nobilissimi comitis”, nonché di Roberto il Guiscardo suo avunculo, “probissimi ducis”, del figlio di questi Roggerio, “non minoris memorie ducis”, di sua madre, di sua moglie Altrude e di sua sorella Rocca, concedeva alla “ecclesie S. Salvatoris de Monte Tabor” ed all’abate Raymundo, nonché a tutti i “fratribus monacis ejusdem loci, tam presentibus quam futuris”, il “montem totum, in quo situm fuit castrum Licie”.[cclix]
La “comitissa” Mabilia
Accanto a quella fornitaci da questi documenti, una idea sulla strutturazione del possesso feudale in Calabria, al tempo del dominio dei primi conquistatori normanni, ci perviene attraverso le vicende di Mabilia, figlia di Roberto il Guiscardo che, qualche anno prima che suo padre partisse per la spedizione in Oriente, durante la quale trovò la morte nel 1085, andò sposa a Guglielmo de Grantemanil, nipote ex frate di Roberto, abbate di Santa Eufemia, portandogli in dote quindici castelli.[cclx]
Secondo il Pontieri, Guglielmo fu “signore di Castrovillari, S. Marco, Crotone, Oriolo” per volontà del Guiscardo, che “gli assegnò in feudo queste importanti cittadine e volendolo legare vieppiù a se, gli dette pure in moglie la figlia Mabilia. Carattere avventuroso e ambizioso, il Grantmesnil aspirava anche a Rossano, come appannaggio dotale della moglie; ma non si agitò finchè visse suo suocero.”.[cclxi]
Morto il Guiscardo, però, Guglielmo de Grantemanil si schierò dalla parte di Boemondo contro quella di Ruggero Borsa, ed assediato in Castrovillari da questi e dal conte Ruggero, fu costretto alla resa venendo privato dei feudi. Partito per Costantinopoli, dopo aver raggiunto la riappacificazione, fece ritorno in patria, ottenendo così la restituzione dei suoi feudi “excepto castro Sancti Marci”.[cclxii]
Nel 1096 partì per la crociata sotto le bandiere di Boemondo ma, successivamente, dopo aver abbandonato l’assedio di Antiochia nel 1098, incorse nella scomunica da parte di papa Pasquale II, morendo, probabilmente, poco tempo dopo, lasciando la moglie ed i figli Guglielmo iuniore e Roberto.[cclxiii]
Le notizie riguardanti i possedimenti di Guglielmo seniore, che emergono attraverso le cronache che lo ricordano, trovano riscontro in alcuni documenti, dove sono menzionate le sue concessioni e quelle dei suoi familiari: “in tenimento Castrovillari”,[cclxiv] a Oriolo ed Altomonte,[cclxv] nell’area compresa tra i fiumi Crati e Coscile,[cclxvi] “in tenimento Sagicte” (territorio di Chiaromonte e diocesi di Anglona),[cclxvii] ed ancora, presso Isola e nelle pertinenze di Crotone dove, le primitive donazioni all’abbazia di Santa Maria del Patir, risalivano al duca Roberto il Guiscardo.
Tra i primi privilegi del monastero greco di Santa Maria della Nuova Odigitria, detto Santa Maria del Patir, spicca infatti quello del duca di Calabria Roberto il Guiscardo, che concesse il libero pascolo per gli animali del monastero, presso Isola e nelle pertinenze di Crotone.[cclxviii]
Nel maggio del 1130 (a.m. 6638), in Messina, re Ruggero II confermava allo stesso Luca, abbate del monastero della “intemeratae Dei Matris et Novae Hodegetriae Patris”, tutti i privilegi e le donazioni precedentemente fatte “per totam Vallem Crathis”, tra cui ogni cosa donata da Guglielmo Grandtemanel (Γουλλέλμου Γρανδτεμανὴλ). Confermava inoltre l’obbedienza, che il monastero aveva in agro di Crotone, cioè “sanctum Costantium Asylorum cum omnibus suis instrumentis, sigillis et possessionibus, et cum omnibus pascuis et iumentis, ut iis sine impedimento fruantur”.[cclxix]
Nel febbraio 1132, Mabilia, figlia di Roberto il Guiscardo, investita nuovamente della contea di Crotone dal re Ruggero II, per la salvezza della sua anima e di quella del padre Roberto confermava all’abate Luca, che era accompagnato dall’arcivescovo di Santa Severina Romano, il privilegio a suo tempo concesso dal padre di libero pascolo, cioè senza impedimento e senza ostacoli eccetto la decima, per gli animali del monastero, presso Isola e nelle pertinenze di Crotone, sia in primavera che d’estate e la donazione, fatta dal vescovo di Isola Giovanni, della chiesa di San Costantino con i suoi diritti e pertinenze e con il mulino situato nel torrente Ceramida, fatto da Monachus. Inoltre, per la salvezza delle anime di suo padre, dei suoi antenati e sua, aggiungeva alcune terre in territorio di Isola presso la chiesa di S. Costantino.[cclxx]
Il regno di Sicilia
Rispetto alle prime trasformazioni avvenute durante il dominio dei duchi normanni, maggiori e più profondi cambiamenti interessarono il territorio calabrese al tempo della costituzione del regno di Sicilia, quando tale avvenimento, che possiamo considerare il prodotto delle lunghe lotte protrattesi per quasi un secolo, stabilizzò i rapporti di forza tra i poteri formatisi durante il processo di conquista, determinando un primo assestamento delle tensioni generatesi tra i principali signori che meglio erano riusciti a radicarsi sul territorio.
Questi ultimi esprimevano un potere costituito attraverso il rapporto feudale che, fino a questo punto, era vissuto articolandosi attorno a diversi centri di gravità, ma che, durante questa nuova fase, cominiciò ad esprimersi in forme più unitarie rispetto al passato, formando i primi abbozzi di organizzazione statale che, diversi storici degli ultimi due secoli passati, hanno voluto considerare (assieme alla monarchia d’Inghilterra), come una delle prime anticipazioni dei moderni stati europei.
Morto senza figli il duca Guglielmo (28 luglio 1127), figlio di Ruggero Borsa, le vicende videro succedergli nel titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia, il conte Ruggero II, nel frattempo già succeduto al padre Ruggero I nel titolo di conte di Sicilia.
Quest’ultimo era morto nel 1101 ed era stato sepolto a Mileto “in provincia di Calabria”,[cclxxi] mentre sua moglie Adelaide, a causa della minore età dei figli, aveva assunto la reggenza comitale di Sicilia, prima per il primo figlio Simone e dopo, morto anche costui, per l’altro figlio Ruggero II, detenendola fino alla maggiore età di quest’ultimo (1112).
Romualdo Salernitano, afferma che Ruggero II sarebbe stato designato nella successione direttamente dal duca,[cclxxii] mentre Falcone Beneventano, fonte a lui ostile, riferisce che, precedentemente a questi fatti, il duca Guglielmo era dovuto ricorrere al suo aiuto, per sedare la ribellione di Giordano conte d’Ariano, concedendogli in cambio in questa occasione, la propria metà delle città di Palermo e Messina e di “totius Calabriae” (1122),[cclxxiii] tacendo circa la sua istituzione ad erede da parte del duca e descrivendo l’aspro confronto che invece l’oppose al papa.[cclxxiv]
In qualità di dominus dei feudi appartenuti al duca, dopo la morte di Guglielmo, spettava infatti ad Onorio II concedere i feudi del duca ad nuovo vassallo. Concessione per la quale si proponeva Ruggero II, essendo il parente maschio più prossimo del suo defunto nipote. Alla fine, comunque, il papa investì Ruggero II in qualità di duca di Puglia, Calabria e Sicilia (1128).
Le contrastate vicende che condussero Ruggero II ad essere incoronato re di Sicilia, il giorno di Natale del 1130, trovarono protagonista anche il signore feudale di Crotone Roberto de Grantemanil, figlio di Guglielmo e di Mabilia che, inizialmente, si schierò dalla parte di Ruggero II e nel giugno del 1127, assieme ad altri feudatari, giunse all’assedio del “castellum Obmanum”, dove si erano radunate le forze fedeli al conte.[cclxxv]
Nel giugno del 1129, Roberto partecipò anche all’assedio di Montalto ma, in seguito, postosi in contrasto con Ruggero II,[cclxxvi] e divenutogli ribelle, si arroccò in Oriolo e Castrovillari ma, stretto d’assedio, fu infine obbligato ad abbandonare i castelli che possedeva.[cclxxvii]
Uffiali e territori
Rispetto alla precedenti forme di governo del territorio, fondate principalmente sull’intervento locale di uomini appartenenti alla corte del proprio signore – uomini inseriti nei quadri di una gerarchia feudale che, in parte, risentiva ancora del recente passato imperiale – con la costituzione del regno di Sicilia comincia ad apparire una organizzazione centrale più strutturata e composta da diversi uffici, ciascuno articolato localmente secondo i diversi territori che componevano il nuovo regno.
Secondo alcuni, l’esistenza di questi uffici sarebbe documentata già al tempo di Ruggero I, quando risalirebbe la notizia della presenza di un “camerarius totius Calabriae et Vallis Gratis et Vallis Sinni atque Vallis Marsici”,[cclxxviii] anche se la cronaca di Romualdo Salernitano riferisce esplicitamente, che re Ruggero II istituì camerari e giustizieri nel 1139 per tutto il regno: “Rex autem Roggerius in regno suo perfecte pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace camerarios et iustitiarios per totam terram instituit, leges a se noviter conditas promulgavit, malas consuetudines de medio abstulit.”.[cclxxix]
A seguito di ciò, in relazione all’amminsitrazione della giustizia, il territorio di “tutta la Calabria” fu affidato ad un mastro giustiziere e fu diviso in distretti giudiziari detti giustizierati, affidati ciscuno ad un giustiziere.
Accanto a compiti amministrativi e ricognitivi, a questi ufficiali era affidata, principalmente, l’amministrazione della giustizia nelle cause più importanti, rispetto ai feudatari che, detenendo la bagliva, secondo specifici capitoli e con differenze legate ai singoli territori, avevano, in genere, solo il potere di riconoscere le prime e seconde cause nell’ambito del loro feudo.
Lo stesso giustiziere poteva detenere l’amministrazione della giustizia anche in più distretti che oltre a quello di “Calabria”, toponimo che continuava a definire il territorio abitato dalla popolazione greca, comprendevano anche quelli abitati dai longobardi, ossia i territori di “Valle Crati”, di “Valle Sinni”, di “Valle Laino” e di “Valle Marsico”, che riprendevano la suddivisione dei più antichi gastaldati longobardi esistenti al tempo del principato di Salerno.
Una situazione che comincia ad essere documentata già attorno alla metà del secolo, quando Carbonello di Tarsia e Guglielmo figlio di Ruggero, che detenevano “in vall(e) G[r]atis regali potestate primatum iudiciorum”, sentenziarono contro il monastero di Santa Maria della Matina a San Marco nell’aprile 1153,[cclxxx] mentre, nel gennaio del 1157, Riccardo de Say “comestabulus et iusticiarius”, assieme a Carbonello de Tarsia e Ruggero di Sangineto, “iustificatores in valle Gratis”, sentenziarono a Cassano.[cclxxxi]
Un atto del febbraio 1168 ricorda il “comite Hugone catanzarii; magistro iusticiario et comestabulo totius calabrie”,[cclxxxii] mentre in un atto del giugno 1181, compaiono “Guillelmo Rogerii filio et Goffrido de Barento Vallis Gratis, regiis iustitiariis”.[cclxxxiii]
In questo periodo, la distinzione di un territorio detto “Valle de Grati” ed uno detto “vallem de Sinu” (sic, ma Sinni) nell’ambito di quello di Calabria, emerge nella cronaca dell’Anonimo Cassinense.[cclxxxiv]
Accanto a questa divisione per territori, nell’ambito dei quali s’estendeva la giurisdizione dei diversi ufficiali regi che avevano il compito di amministrare il regno, quest’ultimo risultava distinto in due porzioni principali, divise da un confine stabilito “secondo la linea del fiume Sinni”[cclxxxv] che ripartiva la Dogana, vocabolo forse derivato dall’arabo “Diwân”, che avrebbe avuto lo stesso significato di “Curia”, designando “l’uffizio, che soprintendeva all’amministrazione della rendita pubblica di qualunque natura essa fosse”. Tale ufficio relativo a compiti amministrativi di tesoreria relativi al regio tesoro, è detto nei documenti semplicemente “Dohana”, ma anche “Dohana de secretis”, in quanto questo confine divideva i territori posti sotto la giurisdizione dei due secreti, oppure “Dohana baronum”, come si rinviene nelle antiche costituzioni del Regno di Sicilia.[cclxxxvi]
Questo secondo appellativo risulta relativo alla ripartizione del pagamento dell’Adoha, come dimostra una significativa omissione, che possiamo riscontrare nel c.d. “Catalogo dei Baroni”: una copia trecentesca, di un elenco che si fa risalire a verso la metà del secolo XII,[cclxxxvii] compilato allo scopo di fissare la contribuzione ai fini militari, spettante ai feudatari del regno normanno di quel tempo dove, in virtù della loro diversa appartenenza, la Calabria come, del resto, la Sicilia, non risultano elencate.[cclxxxviii]
Esso, infatti, “comincia coi feudi di Terra di Bari, Basilicata e Terra d’Otranto, passa indi a quelli di Capitanata, del Molise, e dei Principati, toccando di nuovo taluni punti della Basilicata; va poscia di nuovo nel Molise, e in Terra di Lavoro, e termina cogli Abruzzi e colla lista dei militi di Arce, Sora, ed Aquino.”.[cclxxxix]
La geografia di Edrisi
Attorno alla metà del sec. XII, il geografo musulmano Edrisi, ci fornisce una descrizione molto particolareggiata del regno di Sicilia. Nella sua opera commissionatagli da Ruggero II, “re di Sicilia, Italia, Longobardia e Calabria”,[ccxc] egli distingue la Calabria (qillawrîah) dalla Longobardia (’ankubardah) territorio, quest’ultimo, che oltre a comprendere gli antichi principati longobardi,[ccxci] comprendeva anche la Puglia (bûlîah), nomi che identificavano questi due “territorii o provincie”.[ccxcii]
A sud di Bari, che “è la capitale del paese de’ Longobardi ed è una delle metropoli rinomate dei Rûm”,[ccxciii] ovvero “Sulla riviera di ponente del golfo dei Veneziani” (il mare Adriatico), Edrisi pone Brindisi, Ostuni, Monopoli, Conversano, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Canne, Siponto/Viesti, Rodi, Lesina e Campo Marino. “Tutte queste città fanno parte dell’ ’ankubardah (Longobardia) e si trovano [come abbiam detto] sulla costa di ponente del golfo [dei Veneziani].”.[ccxciv]
Egli pone invece la città di Otranto “nel paese dei rûm”, essendo appartenente alla “[costiera] orientale della qillawrîah (Calabria)”[ccxcv] mentre, lungo quello che chiama il “mare di Siria” (ovvero il Mediterraneo), pone Tacina (ṭâǵ.nah), Crotone (quṭrûnah), Rossano (ruśśânah), Roseto (rûsît) e Taranto (ṭâr.nt).
Appartenevano alle “città di Calabria”: Catanzaro (qaṭ.nsân), Martirano (marṭurân), Viggiano, Castrovillari (q.ṭ.rûb.lî), Benevento, Melfi, Conza, Venosa, Sant’Agata, Chiaromonte, Senise, Bisignano (b.snîân), Simeri (sîm.rî), Strongoli (’.st.r.nǵ.lî), Tricarico, e “ǵ.rsanah (leg. ǵ.ransah Acerenza). Queste, [diciamo], sono tutte città di Calabria”.
Fra “le città di ’ankubardîah (Longobardia)” Edrisi annovera invece: Matera, Cerignola, Mottola, Gravina, Canosa, Ordona, Ascoli Satriano, San Lorenzo, Sambiase, Civitate, San Severo, Monte Sant’Angelo, Lesina, Campo Marino e Termoli.[ccxcvi]
Sull’altro versante, sono definiti “paesi di qillawrîah (Calabria)”: Reggio (rîyû), Massa (’al mâssah), Nicotera (n.qûtrah), Tropea (’at.rbîah) e Sant’Eufemia (śant fîmî).[ccxcvii] Da questa parte, l’appartenenza di Benevento alla Calabria, sopra ricordata, appare controversa rispetto ad un altro passo dello stesso Edrisi che menziona Amalfi, Sorrento, Benevento e Sant’Angelo dei Lombardi, confinanti con le città della Calabria.[ccxcviii]
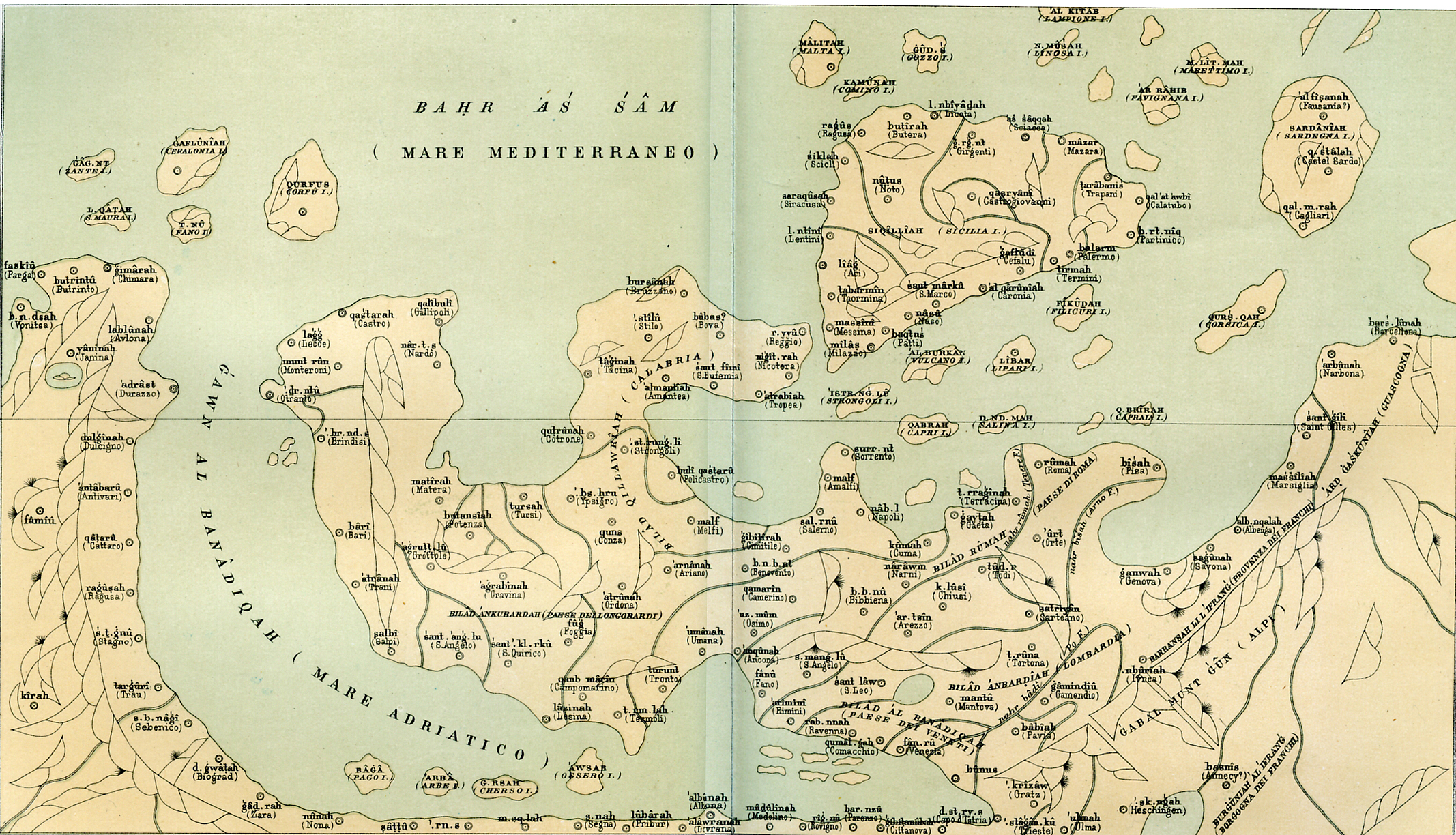
Restituzione della carta di Edrisi che illustra le principali località della penisola italiana e della Sicilia (particolare).
Vescovati vecchi e nuovi
Accanto alla nuova organizzazione delle istituzioni civili, conseguente alla costituzione del regno, in questa fase, anche quella ecclesiatica giunse a definire una strutturazione territoriale più matura rispetto ai tempi.
Ne abbiamo riscontro verso la fine del secolo XII, attraverso il provinciale vetus di Albino dove, ai vescovati suffraganei della metropolia di Reggio menzionati precedentemente, risulta aggiunto quello di Catanzaro, mentre Rossano e Cosenza figurano entrambe come metropoli, quest’ultima con il vescovo di Martirano suffraganeo. Sempre in “Calabria”, risultavano invece immediatamente dipendenti dal pontefice romano, i vescovati di Bisignano, San Marco, Squillace e Mileto.
Significative trasformazioni risultano evidenziate da questa fonte, anche nell’ambito della metropolia di Santa Severina dove, accanto agli antichi vescovati di Umbriatico (“Hembriacensem”), di Belcastro (“Genecocastrensem”) e di Cerenzia (“Gerentinum”), compare il nuovo vescovato di Strongoli (“Stroniensem”) in luogo di quello antico di Policastro. Anche l’altro antico vescovato di Isola non compare, ma troviamo al suo posto quello “Cotroniensem”.[ccxcix]Una incongruenza giustificabile alla luce del fatto che, per quasi tutto il Medioevo, pur permanendo sempre in qualità di “civitas”, essendo una diocesi vescovile suffraganea di Santa Severina, Isola fu “casale” di Crotone e fu detta “Insula Cutroni”[ccc] o Torre d’Isola.[ccci]
Tali cambiamenti ed incongruenze, trovano significative giustificazioni in altre fonti di questo periodo, che ribadiscono le importanti trasformazioni intervenute in questa fase.
Le notitiae episcopatuum scritte in greco da Nilo Doxapatrio attorno alla metà del sec. XII, sulla base dell’antica organizzazione ecclesiastica del patriarcato Constantinopolitano, riferiscono che alla metropolia di Reggio di Calabria (ʽΡηγίου τῆς Kαλαβρίας) appartenevano tredici vescovati, tra cui quelli di Cosenza, Tauriana e Mileto (che aveva preso il posto di Vibona), mentre cinque erano i vescovati suffraganei della metropolia di Santa Severina di Calabria (Ἁγία Σεβερίνη τῆς Kαλαβρίας), ovvero “Calliopolin” (Kαλλιούπολιν), “Asyla” (Ἄσυλα), “Acerontiam” (Ἀϰεροντίαν), “et reliquas”.[cccii]
La probabile presenza di Strongoli tra questi ultimi, risulta confortata dalla testimonianza di Edrisi che, descrivendo il percorso del fiume Neto, individua la città presso la sua foce durante questo periodo: “Il nahr nîṭû (fiume Neto) scende da ’aṣṣîlâ (la Sila) a destra di ǵ.runtîah (Cerenzia) e si dirige verso levante. A sinistra di questa città esce un altro fiume (fiume Lese) che si unisce col precedente nel luogo chiamato ’al mallâḥah (“la Salina” in oggi Salina di Altilia), distante da ǵ.runtîah, che dicesi pur ǵ.ransîah (Cerenzia), nove miglia. Il Neto quindi continua il suo corso fino a che passa sotto śant samîrî (Santa Severina) lontano un miglio e mezzo, e proseguendo tra quṭrûnî (Cotrone) e ’.str.nǵ.lî (Strongoli) mette in mare.”.[ccciii]
In relazione alla sua istituzione più recente, evidenziata anche dal titolo della sua cattedrale che, in sintonia con questo periodo di passaggio alla dipendenza della Sede Apostolica romana, fu dedicata ai SS. Pietro e Paolo, il vescovato di Strongoli non risulta menzionato nella bolla di Lucio III (1183) tra quelli suffraganei dell’arcivescovo di Santa Severina dove, accanto ai vescovi di Umbriatico (“Ebriacensem”), Cerenzia (“Geretinensem”) e Belcastro (“[Geneoc]as[tr]ensem”), compaiono quelli “Giropolensem” e “Lesim[anensem]”, in ragione di una evidente falsificazione.[ccciv]
Un artificio che sembra trovare spiegazione in relazione al progressivo superamento della fase classica e altomedievale relativa all’antica Petelia che, ancora verso la metà del sec. XI, costituiva un casale (Xωρίoν Ἡ Πτελέα) appartenente alla metropolia di Reggio, annoverato tra quelli “esenti” dalla locale giurisdizione vescovile[cccv] mentre, successivamente, diverrà una città, in qualità di vescovato suffraganeo della metropolia di Santa Severina.
Un caso che trova alcune corrispondenze con quello di Isola, dove, nell’ambito di situazioni più articolate, riguardanti la difficile ricomposizione di alcuni antichi territori, riscontriamo, contemporaneamente, la dipendenza della città dall’arcidiocesi di Santa Severina, per quanto riguarda la sfera ecclesiastica, a cui fa riscontro la sua dipendenza dalla città di Crotone in qualità di casale, per quanto attiene a quella civile.
Gli Svevi
Dopo essere passato attraverso il dominio di Guglielmo I “il Malo” (1154-1166), figlio di Ruggero II, e quello di suo figlio Guglielmo II “il Buono” (1166-1189), alla morte di quest’ultimo (1189) senza figli, sua zia Costanza d’Altavilla ereditò il regno di Sicilia, aprendo così la fase che condusse al dominio svevo.
Attraverso una certa continuità con il periodo precedente, anche a seguito dell’avvento degli Svevi, aperta attraverso il matrimonio della regina Costanza con Enrico VI di Svevia, figlio dell’imperatore Federico Barbarossa e suo successore, l’impianto delle principali istituzioni costituite al tempo dei re normanni, pur attraverso adattamenti, continuò a permanere ed a costituire la base dell’organizzazione civile, economica e militare del territorio. A cominciare dalla suddivisione amministrativa del regno in due parti.
Sappiamo, infatti che, in periodo Svevo, il “locus calabriae” detto “petra roseti” o “porta Roseti”, posto al confine tra la Calabria e la Puglia, dove passava la via principale che collegava questi due territori,[cccvi] costituiva il termine che divideva il regno in due parti: una settentrionale che giungeva “usque Trontum”[cccvii] ed una meridionale che, giunta allo Stretto (“usque Farum”), comprendeva anche tutta la Sicilia.[cccviii]
Sotteso a questo termine, il territorio calabrese risultava suddiviso nel giustizierato di “Vallisgratae”, che giungeva fino al corso del fiume Crati, da cui iniziava quello di “Terrae Jordanae”[cccix] che, lungo il versante ionico, comprendeva tutto il Crotonese ed il Catanzarese, fino al confine con il territorio di Squillace,[cccx] da cui iniziava il giustizierato di “Calabriae”.
La terra Giordana
L’esistenza di un territorio detto di “terre Iordanis”, distinto da quello di Valle Crati, dal quale si distinguevano anche i territori detti della valle di “Sinni” e della “vallis Layni”, comincia ad essere documentata agli inizi del periodo svevo, quando compare uno specifico giustiziere deputato ad amministrarvi giustizia.
Nell’anno 1194/95, detenendo anche diversi altri uffici, “Lambertus” risulta infatti “Iusticiarius tocius Calabrie sinni et Layni et terre Iordanis”[cccxi] mentre, nello stesso periodo, relativamente ad un ufficio la cui giurisdizione era estesa all’intero territorio calabrese, “Bartholomei de Lucy” risulta mastro giustiziere di “tocius Calabrie”.[cccxii]
L’attività degli ufficiali regi addetti all’amministrazione della giustizia in Calabria, durante questo primo periodo del regno svevo, è documentata da altri atti.
I giustizieri “Guillelmus de Bisianiano, et Alexander filius Guillelmi”, compaiono in qualità di “regii vallis Gratis justitiarii” nel 1199. Incarico che avevano precedentemente ricoperto anche “Rogerio filio Johelis” e “Simeone de Mamistra”, quest’ultimo detenendo più uffici, in qualità di “justitiario vallis Gratis, vallis Signi, et vallis Layni”.[cccxiii]
Il regio giustiziere Guglielmo di Bisignano compare anche successivamente, in un atto del 1209: “Instrumentum donationis factae per Guglielmum de Bisiniano regium iusticiarium fratri Mattheo Veneri abbati Florensi unius casalini in civitate Cosentiae, in anno 1209.”.[cccxiv] In un atto del marzo 1200, l’illustre Simone de Mamistra risulta invece mastro giustiziere di “Calabriae”,[cccxv] mentre sappiamo che il conte di Crotone Stefano Marchisorto, detenne l’ufficio di capitano e di “magister iusticiarius Calabriae” nel periodo 1214-1216.[cccxvi]
Greci e latini
I documenti relativi agli inizi del dominio svevo, evidenziano che anche dopo l’istituzione del giustizierato di Terra Giordana, il territorio Crotonese e quelli vicini, pur ricadendo nell’ambito di tale ripartizione, per un certo tempo continuarono ad essere identificati in “Calabria”.[cccxvii]
Ciò in relazione alla loro antica identità etnica e religiosa che, pur avviata a disgregarsi ed a omologarsi a quella latina, persisterà ben oltre il periodo della dominazione sveva.
Agli inizi del Duecento, infatti, la lingua ed il rito greco nel Crotonese, anche se minacciati dalle nuove istituzioni politico-religiose, mantenevano ancora la loro forza, rappresentando i tratti caratteristici di una particolare identità e di una specifica appartenenza, dalla quale discendevano usi propri e specifici diritti della popolazione. In particolare quelli che riguardavano il governo locale.
Come leggiamo nella decretale di Innocenzo III del 6 febbario 1198, nella quale è riferito che i canonici componenti il capitolo della cattedrale di Santa Severina, parlavano ed officiavano in greco: “Cum igitur in ecclesia vestra, quae sub obedientia sedis apostolice perseverans, Graecorum hactenus et ritum servavit et linguam”, mantenendo i loro antichi diritti, tra cui quello che consentiva loro di eleggere il proprio vescovo. Identità e prerogative però, che cominciavano ad essere contrastate.
Proprio in questa occasione, infatti, il Capitolo si era rivolto al papa chiedendone l’intervento, al fine di rimuovere un vescovo imposto “per laicalem potentiam” dallo scomunicato senescalco imperiale Marcovaldo che, agendo senza l’autorità e l’elezione da parte dei canonici, aveva insediato sul trono vescovile di Santa Severina, un pastore latino definito “barbarus” ed “intrusus”. Accogliendo le richieste del Capitolo, il papa concedeva ai canonici la libertà di eleggere un nuovo pastore, secondo gli statuti e l’antica consuetudine della chiesa di Santa Severina[cccxviii] e qualche giorno dopo (9 febbraio 1198), scriveva alla regina Costanza d’Altavillla, affinché non frapponesse ostacoli.[cccxix]
A quel tempo, i canonici di Santa Severina che, al pari degli altri ecclesiastici della città, non osservavano il vincolo del celibato[cccxx] e che, in relazione alla loro importanza, possedevano la prerogativa riservata solo a vescovi ed abati, di portare la mitra,[cccxxi] costituivano il governo della diocesi, ed intervenivano nelle decisioni più importanti assunte dall’arcivescovo, in quanto questi poteva agire e prendere le decisioni, solo “cum consensu et voluntate capituli” e “cum consilio et consensu totius capituli”, come testimoniano alcuni documenti riguardanti la fondazione del monastero cisterciense di Sant’Angelo di Frigillo, al tempo dell’arcivescovo di Santa Severina Bartolomeo.[cccxxii]
La presenza di un clero di rito greco è ancora documentata a Catanzaro alla fine del Trecento[cccxxiii] mentre, ancora in età moderna, gli arcivescovi di Santa Severina, conservavano il diritto si spoglio nei confronti dei propri suffraganei.[cccxxiv]
L’abbazia Florense
In tale quadro dove quel che restava dell’antico mondo greco-bizantino, ancora ben radicato nella parte meridionale della regione, conviveva accanto alla ormai irreversibile penetrazione latina che filtrava attraverso la sua porzione più settentrionale, questi primi anni della dominazione sveva, testimoniano di un importante intervento della corona nel Crotonese.
Verso la fine del sec. XII, infatti, presso il confine silano della Valle Crati, fu fondato il monastero di San Giovanni in Fiore che, secondo i documenti più antichi, si trovava eretto “in tenimento Sile”, ovvero nel “tenimentum in Sila Calabriae, in qua eorum monasterium situm est”,[cccxxv] dove l’abbate Gioacchino aveva realizzato “quoddam receptaculum” per il rifugio dei suoi frati, “in loco qui dicitur Caput Album in extrema parte Silae, quae adjacet civitati Cusentinae”.[cccxxvi] Luogo che si trovava “in frigidissimis Sylae finibus”.[cccxxvii]
Questa nuova fondazione latina andò ad influire profondamente sulla vita dei monasteri più antichi e degli altri abitati greci presenti in quest’area. Nell’ambito della sua attività economica, infatti, i regnanti svevi assegnarono al monastero di Fiore, non solo diritti e possedimenti nell’ambito silano, ma anche “per totam Calabriam”, come evidenziano già i primi privilegi concessi all’abate Gioacchino, più volte riconfermati.
Ciò risulta, ad esempio, riguardo il diritto di pascolo che questi privilegi assegnavano all’abbazia nell’ambito del tenimento di “Fluca” posto “in maritima Calabriae”, presso la confluenza dei fiumi Vitravo e Neto, “et aliis tenimentis tam demani nostri, quam aliorum, quae sunt per totam Calabriam, tam scilicet in terris cultis et incultis, quam nemoribus et silvis absque glannatico et herbatico.”.
Il diritto dei Florensi si estendeva per privilegio anche sulle saline di “Calabriae” presso il fiume Neto, dove era concesso loro di prendervi il sale senza alcun impedimento o esazione, e di poterlo vendere ed acquistare “absque theleonatico, plateatico et passagio”.[cccxxviii]
Nell’ambito dei larghi favori dati ai Florensi dai privilegi regi già in antico, fu anche concesso loro e più volte riconfermato, di poter “cavare et percipere meneras ferri, per omnes meneras Calabriae”, mentre nel caso fossero state rinvenute nuove miniere nei tenimenti del monastero, queste sarebbero potute rimanere nel suo possesso perpetuo.[cccxxix]
Tali concessioni che, in relazione alle attività economiche condotte dall’abbazia, erano incentrate sullo sfruttamento delle risorse montane del territorio silano, ma comunque collegate ed estese a quelli limitanti, determinarono spesso dispute tra i Florensi ed i loro vicini. Occasioni in cui risulta che già nei primi anni di vita, l’abbazia ricadeva nella giurisdizione del giustiziere di Valle Crati.
Come si rileva già nel giugno del 1199, quando “Guillelmus de Bisianiano, et Alexander filius Guillelmi regii vallis Gratis justitiarii”, sentenziarono in merito alla richiesta dell’abate Gioacchino che lamentava i danni arrecatigli dai monaci del monastero dei SS. Trium Puerorum e dagli uomini di Caccuri che, a mano armata, avevano attaccato i suoi monaci che custodivano le pecore ed avevano invaso il suo monastero suffraganeo “quod dicitur de Bono Ligno”, distruggendo le “officinas ipsius monasterii” e saccheggiando i suoi beni.
In precedenza, per avere giustizia nel merito della questione che riguardava la contesa di questi beni, l’abate aveva richiesto l’intervento dei “justitiarii Cusentini” che però, né erano venuti, né avevano fatto cessare le invasioni. Richiesta simile era stata fatta in tal senso, anche dal “comite Raynero Marchisorte dicti temporis calabriae Capitaneo”, senza però che i facinorosi cessassero le violenze. L’abate era quindi dovuto ricorrere ai giustizieri di Valle Crati ed al dominus Simeone de Mamistra “capitaneo, et magistro comestabulo, atque justitiario vallis Gratis, vallis Signi, et vallis Layni”.[cccxxx]
Pur confermando questa situazione, altri documenti, pongono in risalto come l’abbazia occupasse comunque una delicata posizione di confine, tra il territorio di Valle Crati gravitante sulla città di Cosenza ed sui suoi casali, e quello di Calabria posto oltre questi confini. Una presenza duramente avversata dai monaci dei monasteri vicini e dagli altri abitanti dell’area che, evidentemente, si facevano forti di precedenti diritti.[cccxxxi]
Come si evidenzia in un atto del giugno 1221, quando, in occasione di alcune usurpazioni riguardanti, tra l’altro, i possedimenti ed i pascoli del monastero Florense che erano stati invasi specialmente dai monaci “de Patyro”, mentre altri “de Calabria et Vallis Gratis”, agendo in danno del monastero “faciunt furnos picis, fractas et venationes alias”, Federico II ordinava ai “Iusticiariis et camerariis Calabriae et Vallis Gratis”, d’intervenire per far rispettare i diritti dei Florensi.[cccxxxii] L’intervento degli ufficiali che agivano nei due diversi territori, si riscontra anche in seguito. Il 19 agosto 1222, dall’accampamento di Jato, Obizo arcivescovo di Cosenza e Biagio vescovo di Cassano, autenticavano la trascrizione di un atto di Federico II, attraverso cui il sovrano, rivolgendosi ai “Magistris iusticiariis et camerariis Calabriae et Vallis Gratis”, li ammoniva affinchè fossero rispettati i privilegi da lui concessi al monastero ed a questo confermati dai pontefici romani, senza pretendere di trarlo “ad civile forum”.[cccxxxiii]
In potere dell’imperatore
L’assetto del territorio Crotonese rimase inalterato anche durante i primi anni seguenti all’ascesa di Federico II alla corona imperiale, quando continuò ad appartenere al giustizierato di Terra Giordana.
L’appartenenza del Crotonese alla giurisdizione dei giustizieri di “Terrae Iordanae” o “Terrae Iordani”, è documentata da un atto del gennaio 1223, quando troviamo “Iohanne Nicolao e Bartholomeo de Logotheta imperialibus iusticiariis Terrae Iordanae”, constituiti nell’esecuzione del loro ufficio “in Psychro” (Cirò), dove si presentò “frater Belprandus” per parte del venerabile abate e degli altri suoi confratelli del monastero Florense, portando con sé la lettera di Federico II data in Cosenza il 4 novembre 1222 ed indirizzata ai “Iusticiariis Terrae Iordani”, che fu trascritta in questo documento.[cccxxxiv]
Durante la prima metà del Duecento, le principali suddivisione amministrative del territorio calabrese, corrispondenti a quelle di quest’ufficio, possono essere apprezzate attraverso la giurisdizione assegnata ai giustizieri menzionati in alcuni atti di questo periodo, che spesso ne detenevano più d’una e spesso passavano da una all’altra.
Emblematico è il caso del giustiziere Alessandro di Policastro, che detenne questo ufficio già nel 1215[cccxxxv] e che, in seguito, compare prima in qualità di giustiziere della contea di Catanzaro (1222)[cccxxxvi] e poi, di giustiziere imperiale di Calabria e Terra Giordana (1226)[cccxxxvii] mentre, successivamente, fu “imperialis iusticiarie Calabrie et Vallis Gratis” (1230).[cccxxxviii]
L’ufficio di giustiziere ricoperto dall’ormai “quondam” Alessandro, è ricordato ancora nel 1240, al tempo in cui Tholomeo de Castellione era “justitiario vallis Gratis et terre Jordane.”.[cccxxxix]
In tale frangente, però, il giustizierato di Valle Crati e quello di Terra Giordana, erano stati precedentemente uniti sotto la giurisdizione di un unico giustiziere.
Nell’ambito del processo descritto ed ormai avviato, che perseguiva l’assimilazione della Calabria greca da parte della sua porzione latina, a seguito della promulgazione delle c.d. Costituzioni di Melfi (1231) da parte di Federico II che, in questa occasione, tra l’altro, definì funzioni e competenze, nonché estensioni dei giustizierati,[cccxl] il territorio di Calabria[cccxli] che, dallo Stretto giungeva “ad portam Roseti”,[cccxlii] risultò suddiviso in due distinte provincie: una corrispondente al territorio appartenente alla giurisdizione del giustiziere di Calabria, l’altra che univa i territori di Valle Crati e di Terra Giordana nell’ambito di un secondo giustizierato.
Come risulta evidenziato già nel gennaio del 1234 quando, in merito alle modalità di congregazione della curia, che avrebbe dovuto riunirsi due volte all’anno “per singulas provincias regni nostro”, era stabilito che nel caso di quelle di “Calabria, terra Giordani et vallis Cratis”, i partecipanti si congregassero “apud Consentiam”.[cccxliii]
Una situazione che, nell’ambito della provincia costituita dei territori di “valle Gratis” e di “terram Jordanem”,[cccxliv] trovò agire il “Iusticiario Vallis Gracie (sic) et Terre Iordane”, come testimonia un atto del 3 gennaio 1238, riguardante un relevio feudale relativo ad alcuni villani in Santa Severina,[cccxlv] e come risulta in occasione della ripartizione tra i baroni del regno dei prigionieri lombardi fatta nel dicembre dell’anno dopo, quando questi ultimi risultano elencati, distintamente, “in justitiariatu Calabriae” ed “in justitiariatu vallis Gratis et terre Jordane”.[cccxlvi]
Nell’ambito di quest’ultimo ricadeva anche Genicocastro. Nel 1240, in occasione di una contoversia riguardante un feudo posto in territorio di Genicocastro, rileviamo che in questa occasione agì Tholomeo de Castellione “Iustitiario Vallis Gratis” mentre, precedentemente, lo aveva fatto G. de Montefusculo “Tunc temporis justitiarius Vallis Gratis, ut videtur”.[cccxlvii]
La Sila di Cosenza
Rispetto agli antichi documenti che, al tempo della formazione del tenimento dell’abbazia di San Giovanni in Fiore, ne riferiscono l’ubicazione nella Sila di “Calabriae”, con evidente riferimento ai luoghi che, in epoche più antiche di quella in cui fu fondata l’abbazia, dovevano essere stati nel dominio dei monasteri greci che sorgevano alle falde dell’altopiano, gli atti della prima metà del Duecento evidenziano, invece, che il tenimento dell’abbazia costituiva una pertinenza della “Sylae de Cusentia”.
Nella Sila di Cosenza, presso il fiume Ampollino ed i confini dell’abbazia di San Giovanni in Fiore, si trovava anche il tenimento di “Sanduca”, che i Normanni avevano anticamente concesso all’abbazia di Calabromaria.
Rispetto ai riferimenti che emergono in queste prime concessioni, che noi però possediamo solo attraverso una trascrizione settecentesca degli antichi privilegi tradotti dal greco in latino il 2 dicembre 1253, dove il tenimento di “Sanduca” risulta genericamente individuato “in Sila” o “apud Silam”,[cccxlviii] in una memoria cinquecentesca senza datazione, che riporta alcuni passi della conferma dei possedimenti fatta all’abbazia da papa Gregorio IX nel 1227, si legge: “Confirmamus dictum Tenimentum in Sila Cosensiae quod Sanduca dicitur prope flumen Ampolini, cum pratis, et vineis, terris, nemoribus, …”. Nello stessa memoria si specifica ancora: “Donatio sup(radi)ttorum bonorum, et aliorum non descriptarum fuit fatta Monast.o dictae Abbatiae et sig(nant)er dicti territorii positi in Sila Cosensiae à Rege Rugerio p.o Rege Neapolis sub anni 1129 ut apparet ex privilegio grece scripto, et in latino traducto, quod Privilegium fuit confirmatum et ampliatum ab Imperatore Federico Rege Siciliae in anno 1221 …”.[cccxlix]
L’appartenenza del territorio dell’abbazia di San Giovanni in Fiore alla Sila di Cosenza, risulta evidenziata al tempo in cui i conti di Catanzaro entrarono in possesso del feudo di Policastro, il cui territorio penetrava profondamente nella montagna della Sila.
In alcuni atti relativi ad una lunga lite sorta tra l’abbazia di San Giovanni in Fiore ed i conti di Catanzaro, riguardante il tenimento di “Ampulinus”, posto presso i confini del territorio abbaziale, s’evidenziava, infatti, come i monaci rivendicassero il tenimento conteso nelle pertinenze della “Sylae de Cusentia”, opponendosi ai conti di Catanzaro che, invece, lo dichiaravano ricadente nel territorio del loro feudo di Policastro.
I procuratori dell’abbazia evidenziavano come, le ingiuste pretese della loro parte avversa, poggiassero sul fatto che, il “tenimentum in libello designatum, quod dicit esse in pertinentiis Policastri et ignorat ipsum tenimentum esse in pertinentiis Cusentiae”. Tale situazione aveva già portato a redigere un “instrumentum” nel luglio del 1253 quando, in occasione di un arbitrato, era stata pronunciata una sentenza in favore del comitato di Catanzaro, rappresentato da “domino Riccardum Gactum procuratorem comitatus Catanzarii per dominum Petrum Ruffum”, contro l’abbate ed il convento di San Giovanni in Fiore.[cccl]
L’appartenenza del territorio dell’abbazia alla giurisdizione del giustieziere di Valle Crati e Terra Giordana, si evidenzia nel maggio 1248, in Cosenza, quando “Raynonus de Misiano imperialis magister camerarius Vallis Gratis, et Terrae Iordanae”, insieme con “domino Riccardo de Neocastro”, ricognirono i beni del monastero al fine di accertare i diritti fiscali dovuti al loro ufficio. In questa occasione l’abbate ed il convento del monastero di Flore, essendosi rifiutati di contribuire per “quedam lignamina galearum”, erano stati citati ed erano comparsi in giudizio innanzi alla curia imperiale, mostrando i privilegi “et alia iura eorum”, che comprovavano i loro diritti. In questa occasione essi mostrarono anche la lettera data loro precedentemente dal dominus Matteo Marclafabe. In questa lettera il detto Matteo “imperialis doanae de secretis et questorum magister”, rivolgendosi ai “camerariis, procuratoribus demaniis, collectoribus lignaminum, baiulis” ed a tutti gli “officialibus per Calabriam, Vallem Gratis et Terram Iordanam”, affermava che il monastero Florense con le sue grangie e dipendenze, godeva di ampi privilegi da parte della curia imperiale ed era esente dalla contibuzione del legname e da ogni servizio feudale.[cccli]
Nel regno di Napoli
Le vicende che condussero gli Angioini a stabilire il dominio della loro dinastia nell’Italia meridionale, ebbero per la Calabria importanti ricadute da un punto di vista territoriale generale, considerato che la loro azione, determinò il distacco della Sicilia dalla parte continentale del regno. Per i Calabresi, infatti, ciò produsse l’inversione della polarità geografico-politica precedentemente esistente, facendoli passare dall’appartenenza al regno di Sicilia con capitale Palermo, a quella del regno di Napoli.
Tale appartenenza, inizialmente, non determinò modifiche dell’assetto amministrativo del nuovo regno che, durante il primo periodo conseguente all’affermazione di Carlo I, dopo la sconfitta e la morte di Corradino (1268), conservò per un certo periodo l’impianto precedente. Successivamente, invece, durante gli anni della c.d. Guerra del Vespro, il sovrano intervenne nel modificare l’assetto esistente, probabilmente per ragioni di opportunità politica legate alle necessità strategico-militari di questa guerra.
Fu così che nelle imminenze del conflitto, il territorio del giustizierato o provincia di Valle Crati e Terra Giordana[ccclii] fu ridimensionato dal sovrano, in favore di quello di Calabria.[cccliii]
Il 13 febbraio 1280, re Carlo d’Angiò, notificava a Goffrido de Sumesot, giustiziere di Valle Crati e Terra Giordana, l’aggregazione al giustizierato di Calabria, di alcune terre precedentemente appartenute alla sua giurisdizione, ovvero: Catanzaro, Taverna, Sellia, Simeri, Genicocastro e Mesoraca con i loro casali, Policastro, Tacina, Le Castella, Roccabernarda, Santa Severina con i casali, San Giovanni Monaco e Crotone con i casali.[cccliv]
Se ne fa menzione anche il 17 aprile di quell’anno, quando “Re Carlo rimuove dall’ufficio di Giustiziere di Calabria Roberto di Richeville e vi nomina in sua vece Geberto de Herville, aggiungendo all’antico Giustizierato tutto quel tratto di paese che sta dal fiume Neto al fiume Gattino”.[ccclv] Quest’ultimo forse individuabile con il corso del fiume Ghetterello che attualmente scorre nel territorio di Squillace.
Sempre relativamente a questi ultimi anni del secolo, sappiamo che il confine settentrionale del territorio di Terra Giordana continuava ad essere rappresentato dal corso del fiume Crati, come si evidenzia nel 1294 a riguardo di “Ameraco de Possiaco milite, padrone di Strongolo, regio capitano e giustiziero della Calabria ‹‹et Terrae Joardanae usque ad flumen Gratis, nec non secreto» maestro portulano e procuratore e maestro del sale di tutta la Calabria.”.[ccclvi]
Lungo il fiume Neto
I cambiamenti apportati da questi provvedimenti, si riscontrano attraverso alcuni documenti degli inizi del Trecento quando, nell’ambito del territorio del ducato di Calabria, esistevano due distinte provincie coincidenti con i due giustizierati sottoposti, rispettivamente, al giustiziere di Calabria ed a quello di Valle Crati e Terra Giordana.[ccclvii]
Una situazione che, per quanto riguarda il Crotonese ed i particolari aspetti legati alla sua natura di terra di confine, può essere evidenziata attraverso le vicende di alcuni possedimenti del monastero di San Giovanni in Fiore posti lungo il corso del fiume Neto, che costituiva il confine tra queste due provincie.
Come testimonia agli inizi del secolo, una controversia riguardante il territorio di “Fiuca” o “Fluce” posto presso la foce del fiume, sulla quale sentenziarono in Cirò, il giustiziere di Valle Crati e Terra Giordana ed i suoi giudici,[ccclviii] e come si rileva in una “regales patentes litteras”, data in Napoli 20 giugno 1331 e trascritta in un atto del 16 agosto di quell’anno, dove la grangia di Santa Maria della Terrata, posta in territorio di Rocca di Neto ed alla sinistra idrografica del fiume, risultava appartenere al giutizierato di Valle Crati e Terra Giordana.
In questa occasione, re Roberto, rivolgendosi ai “comes generalibus capitaneis utriusque provinciae Calabriae et iustitiariis Vallis Gratis et Terrae Iordanae”, ordinava loro di fare giustizia in merito a quanto aveva appreso da parte di “Guillelmi abbatis monasterii Sancti Iohannis de Flore de dicta provincia”, ed in relazione alla situazione di “quadam grancia, quae Terrata dicitur” appartenente a detto monastero, che si trovava “in iusticieratu Vallis Gratis et Terrae Iordanae”.[ccclix]
In relazione alla presenza di zone estrattive, evidentemente poste in corrispondenza di entrambe le sponde del fiume, meno definita doveva apparire invece la situazione relativa all’appartenenza della salina di Neto. Come risulta attraverso un atto del 5 gennaio 1346, quando il re Ludovico e la regina Giovanna I, rivolgendosi ai “Vicemgerenti nostro in partibus Siciliae ac toto Ducato Calabriae ac iustitiariis Calabriae et Vallis Gratis et secretis ducatus eiusdem necnon quibuscumque perceptioribus iurium, reddituumet proventuum salinae Neti de tenuta Sanctae Severinae”, intervennero affinchè non fossero frapposti ostacoli all’abbate Petro ed al convento del monastero di Fiore in merito alla riscossione dei 50 bisanzi d’oro sopra le entrate della detta salina, concessa dai loro antecessori re di Sicilia e da loro confermata.[ccclx]
Una situazione controversa che doveva caratterizzare anche i possessi dei Florensi e quelli delle loro dipendenze, posti lungo il confine tra i due giustizierati che correva lungo la media valle del fiume. Come evidenziano un gruppo di documenti stipulati in occasione dei danni subiti dai monaci di Flore, da parte del signore feudale di Caccuri e dei suoi vasalli, i quali avevano occupato i beni del monastero, commettendo violenze e sopprusi che, in particolare, avevano interessato i possedimenti i “Sanctae Mariae Novae positi intra tenimentum dicti monasterii Florensis cum grancia de Berdò, posita prope terram Caccuri”. In queste occasioni, il re Ludovico e la regina Giovanna I, intervennero attraverso i loro “magnificis viris vicemgerentibus nostris in insula Siciliae et ducatu Calabriae, necnon iustitiariis Vallis Gratis et Terrae Iordanae, consiliariis et fidelibus nostris”,[ccclxi] ma anche chiamando in causa i “iustitiariis Calabriae”.[ccclxii]
I confini silani
Al tempo di re Roberto d’Angiò (1309-1343), un atto del 24 dicembre 1333, prodotto in funzione di salvaguardare i diritti della corona e sulla base dei documenti conservati nei regi archivi di quel tempo, ci fornisce una ricognizione dei confini silani del tenimento di Cosenza, evidenziando come il “tenimentum, seu territorium Silae de ducatu Calabriae”, “quae fore noscitur de maero nostro demanio et antiquo”, fosse interamente compreso entro i confini del tenimento di Cosenza.
Questi limiti del “tenimentum Cosentiae, in quo est Sila”, risultavano: “incipit a fluminis Arentis et ascendit per Sanctum Maurum de Sifonatis, et vadit ad flumen de Ponticellis, et ascendit ipsum flumen, et vadit ad flumen Mucconis et ascendit per ipsum vallonem Mucconis et vadit ad flumen de Melissa, et ascendit per ipsum flumen ad Petram de Altari, quae est supra Longobuccum, et vadit ad ripam Russam at ab inde vadit ad serram de Pimeriis et vadit ad vallonem de Afari in confinio Campanae et descendit per ipsum vallonem usque ad flumen de Laurenzana, et ascendit per ipsum flumen ad serram de Minera, et vadit ad serram de Alessandrella et ascendit ad locum dictum ortum de Menta, et abinde vadit ad Sanctum Nicolaum de Parnice, et vadit per viam Nicolai Laurenzana, et exinde vadit ad portum et descendit usque ad flumen Neti, et ascendit ad Hominem mortum supra Cutroneos et ab inde descendit ad flumen Tacinae, et ascendit et ferit ad Petram scriptam supra Policastrum, et ferit ad Petram irtam et vadit ad Petram de Duo et exinde vadit ad Petram de Diacono, et ferit ad Serram de Morone, et vadit ad Serram de Paludara et abinde vadit ad Serram de Piro et vadit ad Serram de Bibulo.”.
All’interno dei confini di questo territorio (“tenimentum Silae”), in cui si trovava il tenimento dato dall’imperatore Enrico VI al monastero di Fiore, la regia corte deteneva diversi diritti (“ius plateatici, herbagii, affidature animalium extraneorum, glandagii et ius picis”), al cui pagamento non rimanevano soggetti gli “hominibus Cosentiae et casalium suorum”. La regia corte deteneva anche il diritto di esigere la “decima victualium” sulle miniere di ferro in qualunque parte della Sila, mentre gli antichi monasteri greci del Patire e di S.to Adriano, pur continuando a poter usare i pascoli silani all’interno dei confini menzionati, erano tenuti a pagare annualmente ai baiuli della Sila due oncie e 4 capre per ogni mandra introdotta.[ccclxiii]
I Ruffo “de Calabria”
Il 18 ottobre 1390, re Ladislao di Durazzo concedeva il titolo di marchese di Crotone a Nicola Ruffo, primogenito di Antonello conte di Catanzaro.[ccclxiv]
Attraverso tale atto, la vasta signoria dei Ruffo, compostasi durante il corso dei sec. XIII-XIV, che comprendeva territori posti tanto alla destra che alla sinistra del corso del fiume Neto, in questo periodo confine tra le provincie di “calabria citra et ultra”, unificò in poche mani, un vasto comprensorio di terre costituito da seminativi e da terre pascolative che, dalla Sila, giungeva sino alla marina.
Da quanto risulta posteriormente, attraverso l’atto di papa Martino V, relativo alla conferma dei possessi del marchese (11.07.1426), a quel tempo il “nobilis vir Nicolaus Ruffus Marchio Cotronis”, possedeva la città Crotone, con il titolo di marchese e quella di Catanzaro, con il titolo di conte, assieme ai rispettivi marchesato e comitato, Cirò con le pertinenze di Alichia, Melissa, il feudo di S.to Stefano, le terre di Policastro, Roccabernarda, Mesoraca, Le Castella, Tacina, San Mauro, Rocca Falluca, Gimigliano, Tiriolo, i casali di Cutro, San Giovanni Monaco, Papanice, Cromito, Aprigliano, Mabrocolo, Misicello, Lachano, Crepacore, Massanova e Torre d’Isola, ed ancora, tra le altre, Barbaro con Cropani e la terra di Taverna.[ccclxv]
Sempre a quel tempo, Cariati, Scala, Verzino, Rocca di Neto, Campana, Bocchigliero, Cerenzia e Caccuri, facevano parte dei feudi che, dopo la morte di Carlo II Ruffo, conte di Montalto, avvenuta nel 1414, erano pervenuti alla figlia Polissena. Possessi che nel 1417, le furono confermati dalla regina Giovanna II.[ccclxvi]
In seguito, “Covella Ruffo, erede della sorella Polissena, ebbe la città di Umbriatico, la terra di Casabona, Rocca di Neto, la città di Cerenzia con la salina di Miliati, la terra di Caccuri con il diritto di plateatico e con le saline di S. Giorgio e la terra di Verzino”.[ccclxvii]
NOTE
[i] Virgilio, Aeneidos I, 530-533.
[ii] “Alle falde delle Alpi inizia quella che ora si chiama Italia.” (Strabone, Geografia V, 1, 1).
[iii] “La parte restante dell’Italia, poi, è stretta e allungata e termina con due punte una delle quali finisce allo stretto di Sicilia, l’altra al capo Iapigio; essa è abbracciata dell’Adriatico da una parte, dal mar Tirreno dall’altra.” (Strabone, Geografia V, 1, 3).
[iv] Servio, Ad Aeneidem III, 400.
[v] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Bρέττος.
[vi] “Gli antichi, infatti, chiamavano col nome di Italia l’Enotria, che si estendeva dallo Stretto di Sicilia fino al Golfo di Taranto e di Posidonia; poi il nome prevalse e si estese fino alle falde delle Alpi. (…) Si può supporre che i primi a chiamarsi Itali, grazie alla loro prosperità, fecero partecipi di questo nome anche i popoli confinanti e continuarono ad estenderlo fino all’epoca della conquista romana. Più tardi, dopo che i Romani ebbero concesso il diritto di cittadinanza agli Italici, essi decisero di concedere lo stesso onore anche ai Galli cisalpini ed ai Veneti e di chiamare tutti Italici e Romani;”. (Strabone, Geografia V, 1, 1).
“Antioco, nella sua opera Sull’Italia, dice che la suddetta regione si chiamava Italia e che su essa verteva la sua trattazione: prima però, era chiamata Enotria. Egli ne dà come confine dalla parte del Mar Tirreno lo stesso che abbiamo indicato per la Lucania, vale a dire il fiume Laos; dalla parte del mar di Sicilia, Metaponto. Considera esterna all’Italia la regione tarantina, contigua a Metaponto, chiamando i suoi abitanti Iapigi. Antioco dice inoltre che, in età ancora più antica si chiamavano Enotrî ed Itali solo quelli che gravitavano sullo Stretto di Sicilia, all’interno dell’istmo.” (Strabone, Geografia VI, 1, 4).
[vii] “Avendo già descritto la regione dell’antica Italia fino a Metaponto, devo ora parlare delle regioni immediatamente vicine. Subito confinante con essa c’è la Iapigia; i Greci la chiamano anche Messapia, mentre la popolazione autoctona chiama terra dei Salentini la parte intorno al Capo Iapigio, Calabria tutto il resto. Al di sopra di questi , procedendo verso settentrione, si trovano i popoli chiamati in greco Peucezî e Dauni. La popolazione del posto, invece, dà a tutto il territorio che viene dopo la Calabria il nome di Apulia. (…)” (Strabone, Geografia VI, 3, 1).
“La terra a cui si gira intorno andando da Taranto a Brentesion assomiglia ad una penisola; l’itinerario interno da Brentesion fino a Taranto, è percorribile da un corriere in un solo giorno di cammino e forma l’istmo della suddetta penisola. La maggior parte della gente chiama quest’ultima con il nome generale di Messapia, oppure Iapigia, oppure Calabria o anche Salentina, sebbene alcuni distinguano più parti, come ho già detto in precedenza. (…)” (Strabone, Geografia VI, 3, 5).
[viii] Strabone, Geografia VI, 1, 1.
[ix] Strabone, Geografia VI, 1, 4.
[x] Strabone, Geografia VI, 1, 2.
[xi] Strabone, Geografia V, 3, 1; “I Lucani sono di stirpe sannitica” (Strabone, Geografia VI, 1, 3).
[xii] Strabone, Geografia VI, 1, 2.
[xiii] “Praeter Petelinos Brutti omnes”, Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXII, 61. “Eodem tempore Petelinos, qui uni ex Bruttiis manserant in amicitia Romana”, Ibidem, XXIII, 20. “Petelia in Bruttis”, Ibidem XXIII, 30.
[xiv] Appiano, Annibalica, 57.
[xv] Strabone, Geografia VI, 1, 3.
[xvi] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVII, 41.
[xvii] Attianese P., La Monetazione dei Brettii, 2015.
[xviii] Strabone, Geografia V, 3, 6; 4, 10; VI, 3, 1; 3, 5-8; 3, 10.
[xix] Procopio di Cesarea, De bello Gothico II, 15; IV, 20. Ed. Comparetti D., La Guerra Gotica di Procopio di Cesarea, voll. 3, Roma 1895, 1896, 1898, in Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano.
[xx] Trumper J. B., Geostoria Linguistica della Calabria, 2016, p. 48.
[xxi] Nelle fonti troviamo: “Est ergo folio maxime querno adsimulata, multo proceritate amplior quam latitudine, in laevam se flectens cacumine et Amazonicae figura desinens parmae, ubi a medio excursu Cocynthos vocatur, per sinus lunatos duo cornua emittens, Leucopetram dextra, Lacinium sinistra.” Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 43. “De Italia magis quia ordo exigit quam quia monstrari eget, pauca dicentur: nota sunt omnia. Ab Alpibus incipit in altum excedere, atque ut procedit se media perpetuo iugo Appennini montis adtollens, inter Hadriaticum et Tuscum sive, ut aliter eadem adpellantur, inter Superum mare et Inferum excurrit diu solida. Verum ubi longe abiit, in duo cornua finditur, respicitque altero Siculum pelagus, altero Ionium: tota angusta et alicubi multo quam unde coepit angustior.” Pomponio Mela, Chorographia, II, 51. “Hucusque Hadria, hucusque Italiae latus alterum pertinet. Frons eius in duo quidem se cornua, sicut supra diximus, scindit: ceterum mare quod inter utraque admisit tenuibus promunturiis semel iterumque distinguens non uno margine circumit, nec diffusum patensque sed per sinus recipit.” Pomponio Mela, Chorographia, II, 60.
[xxii] Strabone, Geografia VI, 1, 4.
[xxiii] Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XVI, 15, 1-2.
[xxiv] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Bρέττος, dove si ricorda “l’oscura, orribile lingua Brettia” (μέλαινα δεινὴ γλῶσσα Bρεττία παρῆν).
[xxv] “Itaque fatigatus querelis sociorum Dionysius, Siciliae tyrannus, sexcentos Afros ad conpescendos eos miserat; quorum castellum proditum sibi per Bruttiam mulierem expugnaverunt ibique civitatem concurrentibus ad opinionem novae urbis pastoribus statuerunt Bruttiosque se ex nomine mulieris vocaverunt.” Giustino, XXIII, 1, 11-12.
[xxvi] Tito Livio, Ab Urbe Condita, VIII, 24.
[xxvii] “Ed altri intanto giungeranno sulle inaccessibili alture della Sila e sul promontorio di Lino che alto si protende nel mare – regione posseduta da una Amazone – e accoglieranno il giogo di una donna di condizione servile. Lei condurranno le onde, errabonda, in straniera contrada, lei, serva di quella indomita vergine che va tutta coperta di bronzo, e cui, nell’atto di esalare l’estremo spirito, sarà strappato un occhio, che costerà la vita ad un Etolo pernicioso, brutto come una scimmia; il quale dall’asta ancora calda di sangue sarà passato da una parte all’altra. Un giorno, in vero, distruggeranno la città dell’Amazone i Crotoniati, uccidendo la regina che porta il nome del suo paese; ma molti pria cadranno sotto i colpi di lei mordendo coi denti la terra, né senza affanno abbatteranno le torri quei nepoti di Laureta.” Licofrone, Alexandra vv. 993-1007.
[xxviii] Schol. Vet. ad Lycophronem, Alexandra, v. 996; Etymologicum Magnum 517, 54.
[xxix] Attianese P., La Monetazione dei Brettii, 2015.
[xxx] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Ἀβρεττηνή.
[xxxi] Iordanes, De origine actibusque Getarum, XXX, 156.
[xxxii] Paulo Diacono, Historia Langobardorum II, 17; MGH Hannoverae 1878, p. 98.
[xxxiii] “L’entroterra di questa città [Locri] è occupato dai Brettî; vi si trovano la città di Mamertium e quella foresta che chiamano Sila, che produce la pece migliore che si conosca, detta «pece brettia». È ricca di piante e di acqua e si estende in lunghezza per 700 stadî.” Strabone, Geografia, VI, I, 9.
[xxxiv] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 193.
[xxxv] Pugliese Carratelli G., I Brettii, in Magna Grecia, 1987, p. 285.
[xxxvi] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Πανδοσία.
[xxxvii] “E giungerà pure alla città di Siris e al golfo Lacinio, dove Teti farà crescere alla dea Oplosmia un bosco tutto ornato di belle piante come un giardino. Già sarà sempre costume delle donne di quel paese piangere il nepote di Eaco e di Doride, lo smisurato eroe fulmine di guerra; e non ornarsi, allora, le candide membra di aurei vezzi, né cingere molli vesti tinte di porpora: e per questo l’una dea darà all’altra, come dimora, il grande promontorio.” Licofrone, Alexandra vv. 956-965.
[xxxviii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIV, 3.
[xxxix] Strabone, Geografia VI, 1, 5.
[xl] Anonymi (vulgo Scymni Chii), Orbis Descriptio vv. 326-327, in Geographi Graeci Minores, Parisiis 1855, I, p. 209.
[xli] Tito Livio, Ab Urbe Condita, VIII, 24, 5.
[xlii] Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XIX, 2.
[xliii] Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XIX, 10.
[xliv] La presenza di un abitato presso il fiume Traente, dove si erano stabiliti i Sibariti per sfuggire il pericolo della guerra civile nella loro patria, viene fatta risalire al tempo in cui ad Atene era arconte Lisimachide (445-444 a.C.) ed in cui a Roma, erano consoli Tito Menenio e Publio Sestio Capitolino (452 a.C.). Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XII, 22.
[xlv] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 274.
[xlvi] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXII, 61.
[xlvii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIII, 30.
[xlviii] “Eadem aestate in Bruttiis Clampetia a consule ui capta, Consentia et Pandosia et ignobiles aliae ciuitates uoluntate in dicionem uenerunt. et cum comitiorum iam appeteret tempus, Cornelium potius ex Etruria ubi nihil belli erat Romam acciri placuit. is consules Cn. Seruilium Caepionem et C. Seruilium Geminum creauit. inde praetoria comitia habita. creati P. Cornelius Lentulus P. Quinctilius Uarus P. Aelius Paetus P. Uillius Tappulus; hi duo cum aediles plebis essent, praetores creati sunt. consul comitiis perfectis ad exercitum in Etruriam redit.” Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIX, 38.
[xlix] Dionigi di Alicarnasso, Antichità Romane, Exc. XX, 15.
[l] Appiano, Annibalica, 61; Libica, 256-257.
[li] Gellio, Le notti attiche, X, 3, 18-19.
[lii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXI, 7 e 11.
[liii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVII, 7.
[liv] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVII, 35.
[lv] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVII, 36.
[lvi] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVIII, 10.
[lvii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVIII, 38.
[lviii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVIII, 45.
[lix] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIX, 13.
[lx] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXX, 1; 27; 40; 41. XXXV, 20; 41. XXXVI, 2.
[lxi] Polibio, Storie, XI, 6.
[lxii] Appiano, Annibalica, 54.
[lxiii] “in oppida Bruttii agri”, Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXX, 20.
[lxiv] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVIII, 44.
[lxv] “Eodem tempore in Bruttiis ex duodecim populis, qui anno priore ad Poenos desciverant, Consentini et Tauriani in fidem populi Romani redierunt …”, Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXV, 1.
[lxvi] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXX, 19.
[lxvii] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Bάδιζα.
[lxviii] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Λαμπέτεια.
[lxix] Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, fr. XXI, 3.
[lxx] Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XXXVII, 2.
[lxxi] Appiano, Annibalica 44.
[lxxii] Erodiano, De Prosodia Catholica, vol. 3/1, pp. 286-287 Lentz, in Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 179.
[lxxiii] Appiano, Annibalica, 56. Stefano Bizantino, citando Dionigi di Alicarnasso, riferisce che “Costanteia” (Kωστάντεια) si trovava nella Brettia (Bρεττίας). Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Kωστάντεια.
[lxxiv] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVII, 11.
[lxxv] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXX, 19.
[lxxvi] Pausania, Descrizione della Grecia, VIII, 15, 9.
[lxxvii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXIV, 53.
[lxxviii] Strabone, Geografia, VI, 1, 3.
[lxxix] Pseudo-Acrone, Commentari a Quinto Orazio Flacco, carme III 9, in Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, pp. 179-180.
[lxxx] Girolamo, Cronaca di Eusebio, p. 156 ed. Helm., in Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 150.
[lxxxi] Il console P. Sempronio, che si trovava nella provincia dei Brettii (“Bruttii provincia”), durante la sua azione nel territorio di Crotone (“in agro Crotoniensi”) ebbe con Annibale uno scontro tumultuoso (Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXIX, 36). In occasione della spoliazione delle tegole del tempio di Giunone Lacinia, da parte del censore Q. Fulvio Flacco (173 a.C.), Tito Livio afferma che l’episodio era avvenuto quando quest’ultimo si era recato “in Bruttios” (Tito Livio, Ab Urbe Condita, XLII, 3).
[lxxxii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXIV, 45.
[lxxxiii] Minieri Riccio C., Studi Storici su Fascicoli Angioini dell’Archivio della Regia Zecca di Napoli, 1863, pp. 19-20.
[lxxxiv] Cicerone, Brutus, 85.
[lxxxv] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXV, 40.
[lxxxvi] Erodiano, De Prosodia Catholica, vol. 3/1, p. 364 Lentz, in Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 179.
[lxxxvii] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Ἰππώνιoν.
[lxxxviii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXI, 6.
[lxxxix] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXI, 12.
[xc] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXII, 1.
[xci] Polibio, Storie, I, 56.
[xcii] Strabone, Geografia, VI, I, 9.
[xciii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXVII, 15.
[xciv] Polibio, Storie II, 39, 1.
[xcv] Polibio, Storie II, 39 1-2.
[xcvi] Rende P., Mito e Storia di Crotone nella Magna Grecia, cap. 9, www.archiviostoricocrotone.it
[xcvii] Erodoto IV, 15.
[xcviii] Napoli M., Civiltà della Magna Grecia, 1978, p. 30.
[xcix] “Questi ultimi, infatti, a cominciare già dai tempi della guerra di Troia, si erano impadroniti sia di gran parte dell’entroterra, accrescendosi a tal punto da chiamare questa terra «Magna Grecia», sia della Sicilia.” Strabone, Geografia, VI, I, 2.
[c] “Interiora eius aliae aliaeque gentes; sinistra parte Carni, et Veneti colunt Togatam Galliam; tum Italici populi, Picentes, Frentani, Dauni, Apuli, Calabri, Sallentini. Ad dextram sunt sub alpibus Ligures, sub Apennino Etruria; post Latium, Volsci, Campania et super Lucaniam Bruttii.” Pomponio Mela, Chorographia, II, 52. Ed. Muratori G.F, 1855, pp. 97-98.
[ci] “Sinus est continuo Apulo litore incinctus, nomine Urias, modicus spatio, pleraque asper accessu: extra Sipontum, vel (ut Grai dixere) Sipus; et flumen, quod Canusium attingens, Aufidum appellant: post Barium, et Gnatia, et Ennio cive nobiles Rudiae: et iam in Calabria Brundisium, Valetium, Lupiae, Hydrus mons, tum Sallentini campi, et Sallentina litora et urbs Graia Callipolis. Hucusque Hadria, hucusque Italiae latus alterum pertinet. Frons eius in duo quidem se cornua (sicut supra diximus) scindit: ceterum mare, quod inter utraque admittit, tenuibus promontoriis semel iterumque distinguens, non uno margine circuit, nec diffusum patensque, sed per sinus recipit. Primus Tarentinus dicitur, inter promontoria Sallentinum, et Lacinium; in eoque sunt Tarentus, Metapontum, Heraclea, Croto, Thurium: secundus Scyllaceus, inter promontoria Lacinium et Zephyrium; in quo est Petilia, Carcinus, Scylaceum, Mystiae: tertius inter Zephyrium et Bruttium, Consentiam, Cauloniam, Locrosque circumdat. In Bruttio sunt, Columna Rhegia, Rhegium, Scylla, Taurianum, et Metaurum.” Pomponio Mela, Chorographia, II, 59-61. Ed. cit., pp. 101-103.
[cii] “Hinc in Tuscum mare est flexus, et eiusdem terrae latus alterum. Medama, Hippo, nunc Vibon, Temesa, Clampetia, Blanda, Buxentum, Velia, Palinurus, olim Phrygii gubernatoris, nunc loci nomen, Paestanus sinus, Paestum oppidum, Silerus amnis, Picentia, Petrae quas Sirenes habitavere, Minervae promontorium, omnia Lucaniae loca;”. Pomponio Mela, Chorographia, II, 62. Ed. cit., pp. 103-104.
[ciii] “Nunc ambitum ejus, urbesque enumerabimus. Qua in re praefari necessarium est, auctorem nos Divum Augustum secuturos, discriptionemque ab eo factam Italiae totius in regiones XI, sed ordine eo, qui litorum tractu fiet, urbium quidem vicinitates oratione utique praepropera servari non posse : itaque interiori in parte digestionem in litteras ejusdem nos secuturos, coloniarum mentione signata, quas ille in eo prodidit numero.” Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 46. Ed. Domenichi M.L., 1844, p. 349.
[civ] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 291.
[cv] “A Silaro regio tertia, et ager Lucanus Bruttiusque incipit : nec ibi rara incolarum mutatione. Tenuerunt eam Pelasgi, Oenotri, Itali, Morgetes, Siculi, Graeciae maxime populi : novissime Lucani a Samnitibus orti duce Lucio. Oppidum Paestum, Graecis Posidonia appellatum, sinus Paestanus; oppidum Elea, quae nunc Velia. Promunturium Palinurum : a quo sinu recedente trajectus ad Columnam Rhegiam centum M. pass. Proximum autem huic flumen Melpes : oppidum Buxentum, graeciae Pyxus : Laus amnis : fuit et oppidum eodem nomine. Ab eo Bruttium litus : oppidum Blanda, flumen Batum : portus Parthenius Phocensium : sinus Vibonensis, locus Clampetiae : oppidum Temsa, a Graecis Temese dictum, et Crotoniensium Terina, sinusque ingens Terinaeus. Oppidum Consentia. Intus in paeninsula fluvius Acheron, a quo oppidani Acherontini. Hippo, quod nunc Vibonem Valentiam appellamus, portus Herculis, Metaurus amnis, Tauroentum oppidum, portus Orestis et Medua. Oppidum Scyllaeum, Cratais fluvius, mater (ut dixere) Scyllae. Dein Columna Rhegia : Siculum fretum, ac duo adversa promontoria : ex Italia Caenys, ex Sicilia Pelorum, duodecim stadiorum intervallo. Unde Rhegium duodecim M D pass. Inde Appennini silva Sila, promontorium Leucopetra XII M. pass. ab ea Locri cognominati a promontorio Zephyrio, absunt a Silaro CCCIII M. passuum.” (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 71-74. Ed. cit., pp. 359-361.
[cvi] “A Lacinio promontorio secundus Europae sinus incipit, magno ambitu flexus, et Acroceraunio Epiri finitus promontorio, a quo abest LXXV M pass.. Oppidum Croto, amnis Neaethus. Oppidum Thurii inter duos amnes Crathin et Sybarin, ubi fuit urbs eodem nomine. Similiter est inter Sirin et Acirin Heraclia, aliquando Siris vocitata. Flumina : Acalandrum, Casuentum : oppidum Metapontum, quo tertia Italiae regio finitur. Mediterranei Brutiorum, Aprustani tantum : Lucanorum autem, Atinates, Bantini, Eburini, Grumentini, Potentini, Sontini, Sirini, Tergilani, Ursentini, Volcentani, quibus Numestrani iunguntur. Praeterea interisse Thebas Lucanas Cato auctor est. Et Pandosiam Lucanorum urbem fuisse Theopompus, in qua Alexander Epirotes occubuerit.” (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 97-98. Ed. cit., pp. 369-371.
[cvii] “Conectitur secunda regio, amplexa Hirpinos, Calabriam, Apuliam, Salentinos, CCL M sinu, qui Tarentinus appellatur, ab oppido Laconum, in recessu hoc intimo sito, contributa eo maritima, colonia quae ibi fuerat. Abest CXXXVI M pass. a Lacinio promontorio, adversam ei Calabriam in paeninsulam emittens. Graeci Messapiam a duce appellavere; et ante Peucetiam a Peucetio Oenotri fratre. In Sallentino agro inter promontoria C M pass. Intersunt : latitudo paeninsulae a Tarento Brundisium terreno itinere XXXXV M pass. patet, multoque brevius a portu Sasine.” Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 99. Ed. cit. p. 371.
[cviii] “A Locris Italiae frons incipit, Magna Graecia appellata, in tres sinus recedens Ausonii maris; quoniam Ausones tenuere primi : patet octoginta duo mila pass. ut auctor est Varro. Plerique LXXII M fecere. In ea ora flumina innumera, sed memoratu digna a Locris Sagra, et vestigia oppidi Caulonis, Mystia, Consilinum castrum, Cocinthum, quod esse longissimum Italiae promontorium aliqui exsistimant. Dein sinus Scyllaceus : et Scylacium, Scylletium Atheniensibus, quum conderent, dictum : quem locum occurens Terinaeus sinus peninsulam efficit : et in ea portus, qui vocatur Castra Hannibalis, nusquam angustiore Italia : XX M pass. latitudo est. Itaque Dionysius major intercisam eo loco adjicere Siciliae volvit. Amnes ibi navigabiles : Caecinos, Crotalus, Semirus, Arocha, Targines. Oppidum intus Petilia : mons Clibanus, promontorium Lacinium : cujus ante oras insula X M pass. a terra Dioscoron : altera Calypsus, quam Ogygiam appellasse Homerus exstimatur : praetera Tiris, Eranusa, Meloessa. Ipsum a Caulone abesse LXX M pass. prodidit Agrippa.” Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 95-96. Ed. cit. p. 369.
[cix] Tolomeo, Geografia, lib. III, 1, ed. Nobbe C.F.A., Tom. 1 Lipsia 1843, p. 141.
[cx] Tolomeo, Geografia, lib. III, 1, ed. cit., p. 154.
[cxi] Tolomeo, Geografia, lib. III, 1, ed. cit., p. 142.
[cxii] Tolomeo, Geografia, lib. III, 1, ed. cit., p. 154.
[cxiii] Strabone, Geografia VI, 3, 1; 5.
[cxiv] Pomponio Mela, Chorographia, II, 59-61. Ed. cit., pp. 101-103.
[cxv] De Nuptiis Philologiae et Mercurii, VI, 638-639.
[cxvi] Tolomeo, Geografia, lib. III, 1, ed. cit., pp. 141-142.
[cxvii] Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 73-74.
[cxviii] “I monti Appennini, (…) raggiunta la terra dei Lucani, essi inclinano piuttosto verso l’altro mare e passando, per la parte restante, in mezzo ai Lucani e ai Brettî, terminano al promontorio detto Leucopetra, nel territorio di Rhegion.” Strabone, Geografia, V, 1, 3. “Chi naviga da Rhegion verso levante per una distanza di 50 stadî, trova quel promontorio che dal colore chiamano Leucopetra, con quale, dicono, finiscono gli Appennini. Segue poi il promontorio di Eracle, che è l’ultimo ad essere rivolto verso mezzogiorno: infatti chi doppia questo capo naviga direttamente spinto spinto dal Libeccio, fino al promontorio Iapigio; poi la rotta inclina sempre più verso settentrione e verso occidente sino al golfo Ionio. Dopo il promontorio di Eracle si trova quello di Locri, detto Zefiro, che ha il porto protetto dai venti occidentali e da ciò deriva anche il nome.” Strabone, Geografia, VI, 1, 7.
[cxix] Dionisio il Periegeta, Descrizione della Terra, 360-363.
[cxx] Prisciano, Periegesi, 356-357.
[cxxi] Niceforo Blémmide, Geografia Sinottica, 36.
[cxxii] Rende P., Mito e Storia di Crotone nella Magna Grecia, cap. 9, www.archiviostoricocrotone.it.
[cxxiii] Napoli M., cit., p. 31.
[cxxiv] Servio, Ad Aeneidem, I, 569.
[cxxv] “A Scylletium segue la terra dei Crotoniati e i tre promontori degli Iapigi; viene poi il Lacinio, un santuario di Era, una volta assai ricco e pieno di doni votivi. Le distanze fra questi luoghi non si possono dire con esattezza, eccetto che, in generale, Polibio dà una distanza di 1.300 [2.300] stadi dallo Stretto fino al Lacinio e una distanza di 700 stadi di qui al promontorio Iapigio e questa è la così detta bocca del golfo di Taranto. Il golfo stesso poi, ha un periplo di ragguardevole lunghezza, pari a 240 miglia secondo il Corografo; esso sarebbe invece pari a 2.300 stadi secondo Polibio che però, al dire di Artemidoro, ne considererebbe 80 in meno rispetto alla reale ampiezza dell’imboccatura del golfo. Quest’ultimo è rivolto verso il levante invernale e inizia dal promontorio Lacinio. Chi doppia questo promontorio trova subito quelle città che un tempo appartenevano agli Achei e che ora non esistono più, ad eccezione di Taranto; (…).” (Strabone, Geografia VI, 1, 11). Nell’ambito delle cose meravigliose raccolte nel suo scritto, lo Pseudo Aristotele affermava che presso Pandosia in Iapigia, erano mostrate le impronte lasciate da Ercole lungo il suo percorso, alle quali a nessuno era consentito accostarsi. Pseudo Aristotele, De Mirabilibus Auscultationibus, 97.
[cxxvi] Polibio, Storie, framm. lib. X, 3-4-5-6. Rende P., Sulle rotte di Levante. Crotone e la navigazione in “alto mare” nell’Antichità e nel Medioevo, www.archiviostoricocrotone.it
[cxxvii] Arriano, Samn., 7.
[cxxviii] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXV, 23.
[cxxix] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXVII, 2.
[cxxx] Tito Livio, Ab Urbe Condita, XXXVII, 50; XXXVIII, 36.
[cxxxi] “A Sasonis insula traiectus Hydrunto provinciae Calabriae … stadia CCCC. ab Hydrunto litoraria Leucas provinciae supra scriptae … stadia CCC. a Leucis Crotona provinciae supra scriptae … stadia DCCC. a Crotona Naus provinciae supra scriptae … stadia C. a Naus Stilida provinciae supra scriptae … stadia DC. ab Stilida Zephyrio provinciae supra scriptae … stadia CCCC. a Zephyrio Regio civitas provinciae supra scriptae … stadia CCCCXX”. Parthey G. e Pinder M., Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum, 1848, pp. 236-237.
[cxxxii] “Hinc sinus Herculei, si vera est fama, Tarenti cernitur; attollit se diva Lacinia contra Caulonisque arces et navifragum Scylaceum.” Virgilio, Aeneidos III, 551-553.
[cxxxiii] “Cavlonisque arces Aulon mons est Calabriae, ut Horatius «et amicus Aulon fertilis Baccho»: in quo oppidum fuit a Locris conditum, quod secundum Hyginum, qui scripsit de situ urbium Italicarum, olim non est. alii a Caulo, Clitae Amazonis filio, conditum tradunt. navifragum scyllaceum periculosum navibus. dictum Scyllaceum aut a tractu, vel a periculi similitudine: nam inde Scylla longe est. alii dicunt Ulixen post naufragium in Italia de navium fragmentis civitatem sibi fecisse, quam navifragum Scyllaceum nominavit. alii ab Atheniensibus, qui cum Mnestheo duce venerant et a Libya redierant, conditum tradunt.” Servio, Ad Aeneidem, III, 553.
[cxxxiv] Orazio, Ode 2, 6.
[cxxxv] Romanelli D., Antica Topografia Istorica del Regno di Napoli, Parte Prima, 1815, pp. 168-169.
[cxxxvi] Polemio Silvio, Ex Laterculo Polemii Silvii. Nomina Omnium Provinciarum, in Riese A., Geographi Latini Minores, 1878, p. 130.
[cxxxvii] Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 51.
[cxxxviii] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, pp. 281-309.
[cxxxix] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, pp. 291-309.
[cxl] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 292.
[cxli] Intrieri M. e Zumbo A., I Brettii, Tomo II Fonti letterarie ed epigrafiche, 1995, p. 293 nota 229.
[cxlii] Volpe G., La Daunia nell’Età della Romanizzazione: Paesaggio Agrario, Produzione, Scambi, 1990, p. 217.
[cxliii] Liber Coloniarum I, Ed. Blume F., Lachmann K., Rudorff A., Berlin 1848, pp. 209-211.
[cxliv] Liber Coloniarum II, Ed. Blume F., Lachmann K., Rudorff A., Berlin 1848, pp. 261-262.
[cxlv] “Anastasio Cancellario Lucaniae et Bruttiorum”, Cassiodoro, Variae, XII 14, 1 e 3. “Maximo V.C. Cancellario Lucaniae et Bruttiorum”, Ibidem, XII 15, 5. “Anastasio Cancellario Lucaniae et Bruttiorum”, Ibidem, XII 12. “Vitaliano V.C. Cancellario Lucaniae et Bruttiorum”, Ibidem, XI 39, 3.
[cxlvi] “Ad postremum Romae ingressi Halarico iubente spoliant tantum, non autem, ut solent gentes, igne supponunt nec locis sanctorum in aliquo paenitus iniuria inrogare patiuntur. Exindeque egressi per Campaniam et Lucania simili clade peracta Brittios accesserunt; ubi diu resedentes ad Siciliam et exinde ad Africae terras ire deliberant. Bryttiorum si quidem regio in extremis Italiae finibus australi interiacens parti – angulus eius Appinini montis initium fecit – Adriaeque pelagus velut lingua porrecta a Tyrreno aestu seiungens nomen quondam a Bryttia sortitus regina.” Iordanes, De origine actibusque Getarum, XXX, 156.
[cxlvii] Nel menzionare “gli assediati nel castello di Rossano”, Procopio di Cesarea riferisce che tra di loro, oltre alle truppe bizantine “dell’esercito romano” ed illiriche, si trovavano molti e distinti Italiani (Ἰταλῶν), mentre successivamente, nel descrivere i fatti relativi all’assedio di Crotone, egli si sprime affermando che l’imperatore ordinò alle truppe inviate in soccorso della città, di navigare “al più presto verso l’Italia” (Ἰταλίαν). Procopio di Cesarea, De bello Gothico III, 30 e IV, 26. Ed. Comparetti D., La Guerra Gotica di Procopio di Cesarea, voll. 3, Roma 1895, 1896, 1898, in Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano.
[cxlviii] “Belisario, lasciata guarnigione in Siracusa e in Palermo, col resto dell’esercito passò da Messina a Reggio (…) L’esercito procedette per terra per gli Abbruzzi (sic) e la Lucania e seguivalo lungo il continente la flotta. Procopio di Cesarea, De bello Gothico I, 8.
[cxlix] Procopio di Cesarea, De bello Gothico III, 28. Ed. Comparetti D., La Guerra Gotica di Procopio di Cesarea, voll. 3, Roma 1895, 1896, 1898, in Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano.
[cl] “Molti invece andranno a stanziarsi presso Siris e i campi di Leuternia, dove ha un tumulo l’infelice Calcante (…) là, dove rapide passano le correnti del Sinis bagnando la bassa campagna di Cônia. Come Troia, anche là un giorno gli sciagurati distruggeranno una città, e a Pallade, dea Trombettiera che concede il bottino della guerra, arrecheranno grande dolore sgozzandole nel tempio i discendenti di Csuto, che già avanti hanno occupato quel paese. La statua della dea chiuderà le palpebre – pur essendo inanimate – alla vista dell’orrida strage che gli Achei fanno degli Ioni sbranando quei loro parenti a guisa dei lupi della foresta, quando cadrà morto il giovinetto sacerdote, figlio della sacerdotessa, e bagnerà per il primo l’altare di nero sangue.” Licofrone, Alexandra vv. 978-992.
[cli] “Al di qua di questo golfo trovasi per prima la piccola città di Dryrunte (?) oggi detta Odrunte (Otranto); a destra di questa stanno i Calabri, i Pugliesi, i Sanniti, dopo i quali vengono i Piceni, che abitano quel paese fino alla città di Ravenna; a sinistra sta l’altra porzione della Calabria e gli Abbruzzi e la Lucania, dopo la quale viene la Campania fino a Terracina, a cui succedono i confini dell’Agro Romano. Queste popolazioni abitano la costa di ambedue i mari e tutta quanta la regione interna. E questa è qualla che già chiamossi Magna Grecia, poiché negli Abbruzzi trovansi i Locresi Epizephirii, i Crotoniati ed i Turi.” Procopio di Cesarea, De bello Gothico I, 15. Ed. Comparetti D., La Guerra Gotica di Procopio di Cesarea, voll. 3, Roma 1895, 1896, 1898, in Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano.
[clii] Costantino Porfirogenito, De administrando imperio, c. 27. Ed. Immanuel Bekker, Bonnae 1840, p. 120.
[cliii] “Theoctistae patriciae et Andreae de triginta aurei libris gratias agit, quarum dimidiam partem ad redimendos Crotonenses, qui anno superiore, capta a Longobardis urbe, praedae ceciderunt, se contulisse scribit.” (Russo F., Regesto I, 49 nota n. 36). Jaffè P., Regesta Pontificum Romanorum, 1956, vol. 1 p. 176
[cliv] “Gregorius Arogi duci. (…) Indicamu autem, propter ecclesias beatorum Petri ac Pauli aliquantas nobis trabes necessarias esse, et ideo Savino subdiacono nostro iniunximus, de partibus Brittiorum aliquantas incidere, et ut usque ad mare in locum aptum trahere debeat.”. Paulo Diacono, Historia Langobardorum IV, 19; MGH Hannoverae 1878, p. 153.
“Ab Aroge [Arechis], Duce Beneventano, petit ut in trabibus, ecclesiae BB. Petri et Pauli necessariis, e Bruttiis ad mare trahendis, Savino, subdiacono suo, cum hominibus et bobus subveniri iubeat.”. Russo F., Regesto I, 60.
“Mauritio, Magistro militum, mandat ut supradictam epistolam celeriter ad Arogem Ducem deferat et Savinum subdiaconum ei commendat, cui trabes in ecclesiis BB. Petri et Pauli necessarias e Bruttiorum partibus ad locum unde per mare duci possunt, trahat praeceperit quique ut auxilium pracbeat se Arogi scripsisse docet.” Ibidem, 61.
“Gregorio expraefecto petit ut Savino, subdiacono suo, homines et boves de possessionibus suis, quas ipse in emphiteusim habeat, ad emoliendas viginti trabes, ecclesiis BB. Petri et Pauli destinatas.” Ibidem, 62.
“Stephano, Tempsano episcopo, et Venerio, Vibonensi episcopo, scribit de hominibus bobusque Savino, subdiaconi ad trabes ad mare trahendas mittendis.”. Ibidem, 63.
[clv] Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, pp. 28-29.
[clvi] “Ἐπαρχία Kαλαβρίας. ʽΡήγιον, Λούϰρις, Σϰυλαϰίας, Kοτρώνων, Kωνσταντία, Τροπαίων, Ταυρίανα, Βιβώνων.”. Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 31.
[clvii] Oltre quelli controversi di Miria, Lusitania e Carina, compaiono i vescovati di Reggio, Locri, Squillace, Vibona, Cosenza, Nicotera, Crotone, Turio e Tempsa. Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi C.A.M., Napoli 1957, p. 43 n. 2.
[clviii] “… item provincia quae dicitur Calabria Brindicensis girat autem ipsa Italia id est de Adriatico mari in Gallico a provincia Pritas Rigiensis …”. Pinder M. et Parthey G., Ravvennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, 1860, p. 248.
[clix] “Porro octava Lucania, quae nomen a quondam luco accepit, a Silerio fluvio inchoat, cum Brittia, quae ita a reginae quondam suae nomine appellata est, usque ad fretum Siculum per ora maris Tyrreni, sicut et duae superiores, dextrum Italiae cornu tenens pertingit; in qua Pestus et Lainus, Cassianum et Consentia Regiumque sunt positae civitates.”. Paulo Diacono, Historia Langobardorum II, 17; MGH Hannoverae 1878, p. 98.
[clx] Mansi J. D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio …, 1759-1798, XI, 299-303 e 773-774.)
[clxi] Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi C.A.M., Napoli 1957, p. 43.
[clxii] Sposato P., Sinodi romani e concili orientali e la partecipazione dei vescovi del Brutium bizantino, in Atti del 4° Congresso Storico Calabrese, 1969, pp. 141-185. Mansi J. D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio …, XII, 1096; XIII 383.
[clxiii] Sposato P., Sinodi romani e concili orientali e la partecipazione dei vescovi del Brutium bizantino, in Atti del 4° Congresso Storico Calabrese, 1969, pp. 141-185. Mansi J. D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio …, XIV, 194-195.
[clxiv] Risultano presenti, il vescovo Pelagio “Cosentino” o di “Consentias” ed il vescovo Anderamo di “Bisuniano” o “Bisuntiano”. Mansi J.D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio …, XII, col. 384c e d.
[clxv] Burgarella F., Cosenza Durante la Dominazione Bizantina (sec. VI-XI), in Miscellanea di Studi Storici VI – 1987-88, p. 48.
[clxvi] Einhardi Vita Karoli Magni, 15, Scriptores Rerum Germanicarum in Usum Scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis Separatim Editi, 1905. In relazione ai luoghi che segnavano questo confine, sembra poter trovare corrispondenza la presenza del toponimo “petram Caroli Magni” (De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 9-10, 11-13, 29-31, 88-89, 123-130, 194-196, 230-233) sul confine settentrionale del territorio silano dell’abbazia di San Giovanni in Fiore, che pur riscontrandosi solo alla fine del sec. XII, potrebbe costituire un retaggio dei miti franchi legati a questo personaggio, sopravvissuto nella cultura dei dominatori svevi.
[clxvii] Russo F., Regesto I, 90.
[clxviii] Russo F., Regesto I, 97.
[clxix] Russo F., Regesto I, 112.
[clxx] Amari M., Storia dei Musulmani di Sicilia, I, Firenze 1854, pp. 253-275.
[clxxi] “I musulmani di Sicilia e di Africa si mostrano a un tempo nel Ionio e nel Tirreno. Occupano S. Severina e Amantea; presidiano Taranto; afforzansi al capo Licosa e si fan padroni di Ponza.”. Moscato G.B., Cronaca dei Musulmani in Calabria, 1902 rist. 1963, p. 15.
[clxxii] “Stefano fallisce un colpo sopra Amantea, tenuta dai musulmani; e Basilio manda in sua vece Niceforo Foca, creato stratego di Calabria; il quale ultima il riacquisto, prendendo Amantea e Santa Severina.” Moscato G.B., Cronaca dei Musulmani in Calabria, 1902, rist. 1963 p. 21.
[clxxiii] Costantino Porfirogenito, De thematibus, 10. Ed. Immanuel Bekker, Bonnae 1840, pp. 58-60.
[clxxiv] Ἰστέον ὅτι ἡ Kαλαβρίας στρατηγὶς δουϰάτον ἦν τò παλαιòν τῆς στρατηγίδος Σιϰελίας. Costantino Porfirogenito, De administrando imperio, c. 50. Ed. Immanuel Bekker, Bonnae 1840, p. 225.
[clxxv] Russo F., cit., 1957, p. 44. Basilii Notitia, in Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 27.
[clxxvi] “Τῷ ʽΡηγίῳ Kαλαβρίας. ὁ Βιβώνης, ὁ Ταυριάνης, ὁ Λοϰρίδος, ὁ ʽΡoυσιανοῦ, ὁ Σϰυλαϰίου, ὁ Τροπαίου, ὁ ’Aμαντίας, ὁ Kρωτώνης, ὁ Kωνσταντίας, ὁ Nιϰοτέρων, ὁ Bισουνιάνου, ὁ Nεοϰάστρου.”. Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 77.
[clxxvii] Theophanes Continuatus, V, 71, in Migne J. P., Patrologia greca, CIX, coll. 327-330.
[clxxviii] “Saraceni tam de Gariliano quam de Agropoli comuniter collecti, Calabriam, qua residebat Graecorum exercitus super Saracenos in sancta Severina commorantes, properarunt; ubi et omnes Graiorum gladiis extincti sunt. Dehinc Amanteum castrum captum est. Deinde et dictae beatae Severinae oppidum apprehensum est.” Erchemperti, Historia Langobardorum Beneventanorum, in L. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, Bologna 1976, Vol. II, p. 249.
[clxxix] “Anno 272” (18 giugno 885-7 giugno 886). “Spirata quest’anno la tregua che Sawâdah, emir di Sicilia, avea stipulato coi Rûm, ei mandò le gualdane nei paesi che i Rûm teneano ancora nell’isola; le quali predarono e ritornarono. Questo medesimo anno venne di Costantinopoli, con grande esercito, un patrizio per nome Niceforo; il quale posto il campo sotto Santa Severina assediolla e strinse i Musulmani che la tenenano; tanto ch’essi resero la città a patti, e se ne andarono in Sicilia. Quindi Niceforo mandò un esercito alla città di Amantea, la quale fu assediata e costretto il presidio a renderla a patto e (tornarsene) a Palermo in Sicilia.”. Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula volume primo 1880, pp. 399-400.
“L’anno 272 Sawâdah, principe di Sicilia, mandò le gualdane nei paesi dei Rûm; le quali ritornarono con preda. Lo stesso anno seguirono parecchi scontri tra i Musulmani ed un patrizio per nome Niceforo. Venuto di Costantinopoli con un grande esercito, questi entrò nella città di (Santa) Severina; dalla quale il presidio musulmano uscì per accordo e [ritornò] in Sicilia.”. Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula volume secondo 1881, pp. 17-18.
[clxxx] “MH. Tῇ Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας. ὁ Eὐρυάτων, ὁ ’Aϰερεντίας, ὁ Kαλλιπόλεως, [ὁ] τῶν ’Aησύλων.”. Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 82.
[clxxxi] Russo F., cit., 1957, p. 46.
[clxxxii] “Θρόνος τριαxοστὸς πρῶτος. Τῷ Kαλαβρίας ἤτοι τοῦ ʽΡηγίου. ὁ Βιβώνης, ὁ Ταυριανῆς, ὁ Λοϰρίδος, ὁ ʽΡωσιανοῦ, ὁ Σϰολαϰίου, ὁ Τροπαίου, ὁ ’Aμάντείας, ὁ Kρωτώνης, ὁ Kωνσταντίας, ὁ Nιϰοτέρων, ὁ Bισουνιανοῦ, ὁ Nεοϰάστρου, ὁ Kασάνου.”. “thronus trigesimus primus. Calabriae sive Regii. 1. Bibonae. 2. Tauriane. 3. Locridis. 4. Rusiani. 5. Scylacii.6. Tropaei. 7. Amanteae. 8. Crotonae. 9. Constantiae. 10. Nicoterorum. 11. Bisuniani. 12. Neocastri. 13. Casani.”. Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 119; Fabre M. P., Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine, I, Parigi 1889, p. 21.
“τῷ ʽΡηγίῳ Kαλαβρίας. ὁ Βιζώνης, ὁ Ταυριανῆς, ὁ Λοϰρίδος, ὁ ʽΡωσιανοῦ, ὁ Σϰυλαϰίου, ὁ Τροπαίου, ὁ ’Aμάντας, ὁ Kροτώνης, ὁ Kωνσταντείας, ὁ Nιϰωτέρων, ὁ Mισουνιανοῦ, ὁ Nεοϰάστρου, ὁ Kασάνου. ὁμοῦ ιγˊ.”. “31. Rhegio Calabriae: Bizonae. Taurianae. Locridis. Rosiani. Scylacii. Tropaei. Amantae. Crotonae. Constantiae. Nicoterorum. Misuniani. Neocastri. Casani; sunt 13.”. Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 216.
“τῷ ʽΡηγίῳ Kαλαβρίας. ὁ Βιζώνης, ὁ Ταυριανῆς, ὁ Λοϰρίδης, ὁ ʽΡωσιανοῦ, ὁ Σϰυλαϰίου, ὁ Τροπαίου, ὁ ’Aμάντας, ὁ Kροτώνης, ὁ Kωνσταντείας, ὁ Nιϰωτέρων, ὁ Mοσουνιανοῦ, ὁ Nεοϰάστρου, ὁ Kασάνου.” “30. Rhegio Calabriae: 1. Bizonae. 2. Taurianae. 3. Locridis. 4. Rhosiani. 5. Scylacii. 6. Tropaei. 7. Amantae. 8. Crotonae. 9. Constantiae. 10. Nicoterorum. 11. Mosuniani. 12. Neocastri. 13. Casani.”. Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 258.
[clxxxiii] “Θρόνος τεσσαραxοστὸς ὄγδοος. Tῷ Ἁγίας Σευηρινῆς, Kαλαβρίας. ὁ Eὐρυάτων, ὁ ’Aϰεραντείας, ὁ Kαλλιπόλεως, ὁ τῶν ’Aεισύλων, ὁ τοῦ Пαλαιοϰάστρου.”. “thronus quadragesimus octavus. Sanctae Severinae Calabriae. 1. Euryatorum. 2. Acerantiae. 3. Callipolis. 4. Aësylorum. 5. Palaeocastri.”. Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 126.
“τῇ Ἁγίᾳ Σευηρινῇ. ὁ Kαλαβρίας, ὁ Eὐρυάτων, ὁ ’Aϰερεντείας, ὁ Kαλλιπόλεως, ὁ τῶν ’Aησύλων, ὁ τοῦ Пαλαιοϰάστρου· ὁμοῦ ςˊ.”. “48. Sanctae Severinae: Calabriae. Euryatorum. Acerentiae. Callipolis. Aësylorum. Palaeocastri; sunt 6.”. “730-731 leg. τῇ Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας”. Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 222.
[clxxxiv] Russo F., Regesto I, 100 e nota n. 52. Relativamente all’erezione della metropolia di Salerno, esiste una conferma del 12 luglio 989 fatta da papa Giovanni XV ad Amato arcivescovo di Salerno, nella quale gli si riconosce la potestà di ordinare e consacrare i vescovi nei luoghi ad esso soggetti: “Paestanen., Consan., Acerentin., simul etiam et Nolan. et Bisuninen. et Malvitanen. et Cusentiae episcopatus”, come era già stato concesso dai suoi predecessori (Kehr P. F., Italia Pontificia, VIII, p. 346).
[clxxxv] Vita et conversatio sancti et deiferi patris nostri Nili, 70, in Migne J. P., Patrologia graeca, CXX, coll. 119-122. 892: “Sympathicius imperialis Protospathatius et Strategus Macedoniae, Thraciae, Cephaloniae ac Longobardiae” (Trinchera F., Syllabus cit., pp. XXI e 575). Maggio 911: “johannacio imperiali protospathario et stratigo langobardie” (Ibidem, pp. 4 n. V e 575). Dicembre 956: “mariano anthipato patricio, et stratjgo calabrie et langobardie” (Ibidem, pp. 5 n. VI e 575). Novembre 1059: “Antiochus imperialis Protospatharius et Strategus Calabriae” (Ibidem, pp. XXIII, 57-58 n. XLIV, 576).
[clxxxvi] Vita et conversatio sancti et deiferi patris nostri Nili, 45, in Migne J. P., Patrologia graeca, CXX, coll. 85-86.
[clxxxvii] Trinchera F., Syllabus cit., pp. 22-23 n. XXI e 576.
[clxxxviii] Maggio 975: “Michael Anthypatus Patricius et Catapanus Italiae” (Trinchera F., Syllabus cit., pp. 5 n. VII e 575). Novembre 999: “Gregorius imperialis Prothospatarius et Catapanus Italiae Trachaniotes” (Ibidem, pp. XXII, 9 n. X, 575). Ottobre 1011, agosto 1016, marzo 1032: “Basilius Mesardonites vel de Mesardonia Protospatharius et Catapanus Italiae” (Ibidem, pp. XXII, 14 n. XIV, 17 n. XVI, 24 n. XXIII, 575). Febbraio 1018, giugno 1019, giugno 1021, gennaio 1024: “Basilius Boianus, Bugianus vel Boius Protospatharius et Catapanus Italiae” (Ibidem, pp. 18-21 n. XVII – XVIII – XIX – XX, 576). Giugno 1019: “Tornicius Contoleo Protospatharius et Catapanus Italiae” (Ibidem, pp. 19 n. XVIII e 576). Marzo 1032: “Pothus Argyrius Protospatharius et Catapanus Italiae” (Ibidem, pp. XXIII, 24-25 n. XXIII, 27-29 n. XXV, 576). Novembre 1034: “Constantinus Opus Patricius et Catapanus Italiae” (Ibidem, pp. XXIII, 32 n. XXVIII, 576).
[clxxxix] Falkenhausen V., La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal IX secolo, 1978, pp. 46, 50-51, 90-92.
[cxc] Vanoli A., La Sicilia Musulmana, 2016, pp. 166-168.
[cxci] Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula, vol. I, 1880, pp. 24-25.
[cxcii] MGH, Ottonis I diplomata, 371. Consultato attraverso il sito della Bayerische StaatsBibliothek all’indirizzo ww.dmgh.de
[cxciii] Vita Gregorii Abbatis Prior., in MGH, Scriptores, tomo XV parte II, p. 1187. Consultato attraverso il sito della Bayerische StaatsBibliothek all’indirizzo ww.dmgh.de
[cxciv] “fecit proelium Otho Rex cum Sarracenis in Calabria in Civitate Cotruna, et mortui sunt ibi 40. mil. Poenorum cum Rege eorum, nomine Bulcassimus.” Lupus Protospatarius Barensis Rerum in Regno Neapolitano Gestarum Breve Chronicon ab Anno Sal. 860 vsque ad 1102, a. 981.
[cxcv] MGH, Ottonis II et III diplomata, 276, 277, 278. Consultato attraverso il sito della Bayerische StaatsBibliothek all’indirizzo ww.dmgh.de
[cxcvi] “Nona Calabria, quae primitus ab antiquis Britania dicta est ob immensam affluentiam totius delitiae atque ubertatis.” Pinder M. et Parthey G., Ravvennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, 1860, p. 503.
[cxcvii] 1048: Northmanni iverunt contra Graecos in Calabriam, et invaserunt eam, et victi sunt Graeci circa Tricaricum. Humphredus capit Trojam, et facit castrum in Bachareza. 1052: Fit proelium cum Argyro catapano Graecorum, et a Northmannis iterum fugatur exercitus eius circa Tarentum. Et item factum est proelium circa Crotonem in Calabria, et victus est Sico Protospata. Et dominium Northmannum factum est magnum in Calabria, et Apulia; et crevit potentia, et timor eorum in omni terra. Gambella A., Il Breve Chronicon Northmannicum, www.storiaonline.org.
[cxcviii] Trinchera F., Syllabus Graecarum membranarum, 1865, p. 53 n. XLII.
[cxcix] Russo F., Regesto I, 135, e sgg. “Iuramentum Roberti Guiscardi: «Ego Robertus Dei gratia et sancti Petri dux Apuliae et Calabriae et utroque subveniente futurus Siciliae …»”, Russo F. Regesto I, 136. “dux Apuliae et Calabriae et utroque subeveniente futurus Siciliae”, Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Biblioteca Apostolica Vaticana 1958, pp. 3-5 e pp. 6-12. 1059: “Robertus comes Apuliae factus est dux Apuliae, Calabriae, et Siciliae a papa Nicolao in civitate Melphis; et fecit ei hominium de omni terra.” Gambella A., Il Breve Chronicon Northmannicum, www.storiaonline.org.
[cc] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 13-16.
[cci] Russo F., Regesto I, 179.
[ccii] “Questa fu un venerabile monasterio di Benedettini, il cui abate, per nome N. (così stimando esser la maggior gloria di Dio) il tramutò in cattedrale circa gli anni del Signore 1000.” Fiore G., Della Calabria Illustrata II, p. 541.
[cciii] “Tassitano, diocesi di Gerenzia.”. Fiore G., Della Calabria Illustrata II, p. 594.
[cciv] Oliveti L., Istruttoria Demaniale per l’accertamento, la verifica e la sistemazione del demanio civico comunale di Cotronei 1997, p. 12.
[ccv] Russo F., Regesto II, 10355.
[ccvi] Nella relazione del vescovo Maurizio Ricci (1621) si legge che: “Queste tre Terre sudette [ossia Scala, Terra vecchia e S. Maurello] et Cariati erano della Diocesia di Rossano, et nell’erettione in Vescovato fatta di Cariati furono dismembrate da detta diocesia di Rossano, et in ricompensa le furono date due Terre grosse Campana, et Bucchigliero ch’erano della Diocesia di Gerentia. Et in segno di ciò la detta Chiesa di Gerentia, tiene ancora il jus conferendi un beneficio sub titulo Sancti Joannis posto con la Chiesa nel territorio di Campana.”. Scalise G.B. (a cura di), Una relazione di Mons. Ricci, in Siberene, Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, 1999, p. 437.
[ccvii] Guillou A., Le Brébion de la Métropole Byzantine de Région (vers 1050), Biblioteca Apostolica Vaticana, 1974.
[ccviii] Ibidem, p. 73.
[ccix] Ibidem, pp. 62 e 188.
[ccx] Nella conferma, tramandataci in copia, dei privilegi fatta nel 1145 dal re Ruggero II al vescovo di Isola Luca, tra i beni posseduti dalla cattedrale di Isola, troviamo: “… ecclesiam santi Joannis de Campolongo in tenimento Castellorum Maris et diocesi preditti episcopatus, cum terris et pertinentiis suis, …”. AVC, Privilegio dello Sacro Episcopato della città dell’Isula, in Processo grosso di fogli cinq.cento settanta due della lite, che Mons. Ill.mo Caracciolo ha col S.r Duca di Nocera per il Vescovato, ff. 417.
[ccxi] Guillou A., Le Brébion cit., pp. 58-59 e 186.
[ccxii] Ibidem, p. 81 e 199.
[ccxiii] Ibidem, pp. 82-83 e 200.
[ccxiv] Ibidem, pp. 82-83 e 200.
[ccxv] Ibidem, pp. 54-55 e 183-184.
[ccxvi] Ibidem, pp. 62 e 188.
[ccxvii] Trinchera F., Syllabus cit., pp. XXIII-XXIV e 57 n. XLIV.
[ccxviii] Mor C. G., Riflessi Bizantini nella Organizzazione Calabrese Avanti la Proclamazione del Regno, in Atti del 4° Congresso Storico Calabrese a cura della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Napoli 1969, p. 372.
[ccxix] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, p. 154-157.
[ccxx] Trinchera F., Syllabus cit., pp. 113-115 n. LXXXVII.
[ccxxi] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 27-30.
[ccxxii] Trinchera F., Syllabus cit., pp. 207-209 n. CLVII.
[ccxxiii] Trinchera F., Syllabus cit., pp. 231-232 n. CLXXVI.
[ccxxiv] “Quod cum Guiscardo renuntiatum esset, videns se Calabriam perdere et Apuliam totam turbari, fratrem per legatos accersiens, pacem cum ipso fecit, concedens ei medietatem totius Calabriae a jugo montis Nichifoli et montis Sckillacii, quod acquisitum erat, vel quousque Regium essent acquisituri.”. Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V, parte I, p. 22.
[ccxxv] “Caput Trigesimo Sextum. Guiscardo apud Regium remanente, Rogerius castra Calabriae expugnat. (…) XXXVI. (…) Dux itaque digressus, in Calabriam veniens, expeditionem solvit: Bugamenses, quos captivos adduxerat, Scriblam, quam desertaverat, restaurans, ibi hospitari fecit. XXXVII. – Anno vero Dominicae incarnationis MLXV Policastri castrum destruens, incolas omnes apud Nicotrum, quod ipso anno fundaverat, adducens, ibi hospitari fecit. Antequem iret versus Panormum, (…) dux et comes Rogerius prius in provincia Cusentii castrum quidem Rogel expugnaverunt et pro libitu ordinaverunt. Eodem anno castrum quoddam, quod Ayel dicitur, in provincia Cusentii, dux oppugnare vadens, per quattuor menses obsedit.”. Goffredo Malaterra, cit., p. 47.
[ccxxvi] “… et lo remena avec soi en Calabre; et de cellui temps en avant lo duc ot concorde avec son frère lo conte toute sa vie, et lui donna la moitié de Sycille et de Calabre que fust soe, et lautre moitié lui recommanda.”. Champolion-Figeac M., Lystoire de li Normant et la Cronique de Robert Viscart par Aimè Moine de du Mont-Cassin, Parigi 1835, pp. 285-286. Amato di Montecassino scrisse in latino una Storia dei Normanni, di cui c’è pervenuta una traduzione francese del sec. XIV.
[ccxxvii] Goffredo Malaterra, cit., pp. 59-60.
[ccxxviii] “Nam, fratribus Rogerio et Boamundo, utroque ducatum appetente, inter se dissidentibus, et pluribus – nunc ab isto, nunc ab illo incrementa expetendo – lucrum suum quaerentibus, multorum Apulorum fides, quanta fuerit, experimento claruit. Rogerius tandem adiutorio avunculi sui, Siculorum comitis, Rogerii, qui, vivent-e fratre, idem sibi promiserat, dux efficitur. Omnia castella Calabriae, quorum necdum nisi medietatem cuiusquam comes Rogerius habebat, a nepote ad plenum sibi concessa, consignantur.” Goffredo Malaterra, cit., p. 82.
[ccxxix] Goffredo Malaterra, cit., pp. 90-92. Ménager L. R., Roberto il Guiscardo e il suo tempo, cit., p. 273.
[ccxxx] Jamison E., Note e documenti per la storia dei conti normanni di Catanzaro, in ASCL a. I, 4, Roma 1931, pp. 453-455.
[ccxxxi] “Caput Decimo Sextum. Comes Melitam vadit.” (…) Dum ista geruntur, Mainerius de Gerentia a comite, ut sibi locutum veniat, invitatus, accedere differt, cum arrogatione, praesente adhuc legato comitis, respondens, se numquam ipsum, nisi ut damnum, si possit, inferat, visum velle. Quod – referente legato, qui missus fuerat – comes audiens, plurimum indignatus, festinus mari transmeato, a Sicilia in Calabriam venit: Petrum Mortonensem, cui vices suas plurimum commiserat exequendas, ut per Siciliam exercitum commovens post se acceleret, mittit. Qui prudenter iniuncta perficiens, infra octo dies ab omni Sicilia copioso exercitu congregato, mense maii ad comitem adduxit. Sicque comes versus Gerentiam accelerans, castrum terribili obsidione vallavit. Qua de re Mainerius territus, se stulte et fecisse et locutum fuisse cognoscens, supplex ad misericordiam comitis venit: equos, mulos, thesauros et omnia, quae habebat, veniam petens, in eius dispositione ponit. Comes super iis, quae fecerat, eum poenitere videns, ut semper pii cordis, omnia condonavit, excepto quod – quasi pro disciplina potiusquam ambitione – mille aureos solidos de suo accepit, ut eum a tali praesumptione ulterius coerceat. Sicque per ardua adiacentium montium inde digrediens, Cusentium venit.”. Goffredo Malaterra, cit., p. 94.
[ccxxxii] “Eodem anno Acherontia civitas cremata est mense augusti, in tantum enim eodem vastata est igne, ut nulla domus, nullum inveniretur edificium quod non ab igne consumptum deperierit. Homines etiam XXV eodem incendio mortui sunt.”. Romualdi Salernitani Chronicon, in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. VII parte I, p. 199. “mense Augusti Acherontia admirandum in modum cremata est a se ipsa, et mortuus est Iordanus Princeps.”. Lupus Protospatarius Barensis Rerum in Regno Neapolitano Gestarum Breve Chronicon ab Anno Sal. 860 vsque ad 1102, a. 1090.
[ccxxxiii] Vita et conversatio sancti et deiferi patris nostri Nili, 60, in Migne J. P., Patrologia graeca, CXX, coll. 103-106.
[ccxxxiv] Vita et conversatio sancti et deiferi patris nostri Nili, 2, in Migne J. P., Patrologia graeca, CXX, coll. 17-18.
[ccxxxv] “Dux vero a Sicilia in Calabriam veniens, apud Russanum, eiusdem provinciae urbem, dolentibus incolis, castellum firmavit.” Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V, parte I, p. 57.
[ccxxxvi] Trinchera F., Syllabus cit., p. 68 n. LII.
[ccxxxvii] Caietano O., Vitae Sanctorum Siculorum, Tomus Secundus, Palermo 1657, p. 87.
[ccxxxviii] “Da Rossano ad ’al wâdî ’al kabîr («il fiume grande», fiume Crati) dodici miglia. Da ’al wâdî ’al kabîr alla città di rûśît (Roseto) dodici miglia. Da Roseto a sahrat saku («il sasso del Sinno ?», Pietra di Roseto) dodici miglia. Questo sasso segnava il confine tra i Franchi e i Longobardi. Dal Sasso al wâdî saktah (fiume Sinno) sei miglia. In questo fiume entrano le navi: esso offre eccellente ancoraggio.” Amari M. e Schiapparelli C., L’Italia descritta nel “Libro di Re Ruggero” compilato da Edrisi, in Atti della Reale Accademia dei Lincei anno CCLXXIV, 1876-77, serie II – volume VIII, Roma 1883, pp. 73-74. “Da Rossano ad ’al wâdî ’al kabîr («il fiume grande», fiume Crati) dodici miglia. Da ’al wâdî ’al kabîr alla città di rûśît (Roseto) dodici miglia. Roseto è città di antica fondazione; [giace] in luogo ameno [ed è ben] popolata, benchè le case non siano molte. La cingono solide mura. Da questa a sahrat saku («il sasso del Sinno ?», Pietra di Roseto) che è il confine tra i Franchi e i Longobardi, dodici miglia. Da questa al wâdî s.knah (fiume Sinno) che offre sicuro ancoraggio, sei miglia.”. Ibidem, p. 133.
[ccxxxix] “Hic fratrem suum Umfredum Abagelardum comitem, apud castrum quod Lavel dicitur, virum prudentissimum, consilio Apuliensium et Normannorum ordinavit, Robertum vero Guiscardum in Calabria posuit, firmans ei castrum in valle Cratensi, in loco qui Scribla dicitur, ad debellandos Cusentinos et eos qui adhuc in Calabria rebelles erant.” Goffredo Malaterra, cit., p. 14.
[ccxl] “Dux itaque, videns castrum, quod melius in ipsa provincia habebat, sibi ablatum, sciens totam Calabriam per illud facile posse turbari, in valle Cratensi cum fratre sibi conventionem executus, Calabriam partivit. Sicque in Apuliam vadit, comes vero in Calabriam portionem suam recepturus redit.” Goffredo Malaterra, cit., p. 39.
[ccxli] “Dux ab omni Apulia equitum peditumque copiis, fratre Boamundo sibi in auxilium cum Ydrontinis et Tarentinis et reliquis, qui sui iuris erant, assumptis, Vallem Gratensem, versus Castri-villam occupat.” “Dux autem in valle Gratensi comitem, dum veniat, sustinet; castrum, quod Sancti Marci dicitur, usque properans, deditione civium tali pactione firmata, suscipit, ut in perpetuum – dum in vita comes fuerit illud – Guillelmo non reddant.” Goffredo Malaterra, cit., p. 100.
[ccxlii] Goffredo Malaterra, cit., p. 47.
[ccxliii] “apud Cusentium, Calabriae urbem”. Goffredo Malaterra, cit., p. 46.
[ccxliv] “Exercitu itaque commoto et his quae ad expeditionem necessaria erant [paratis], versus partes Calabriae aciem dirigit: pertransiensque Cusentinos fines et Marturanenses, juxta calidas aquas super flumine, quod Lamita dicitur, …”. Goffredo Malaterra, cit., p. 18.
[ccxlv] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 141-144.
[ccxlvi] Trinchera F., Syllabus cit., pp. 138-141 n. CVI.
[ccxlvii] Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 82.
[ccxlviii] De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 9-10, 11-13, 29-31, 88-89, 99-101, 102-103, 123-130.
[ccxlix] Dietro la richiesta dell’abate Nicola, i privilegi furono tradotti dal greco in latino a Crotone, dai due giudici Nicola à Iudice e Michele de S. Mauro, come si rileva nell’atto redatto il 2 dicembre 1253, per mano del pubblico notaio Giovanni di Pietra Paula. Ughelli F., Italia Sacra, t. IX, coll. 475-478.
[ccl] Pesavento A., Antichi Casali della Vallata del Neto: Calabrò, Caria ed Altilia, www.archiviostoricocrotone.it
[ccli] Pesavento A., Il Capitolo di Santa Anastasia, www.archiviostoricocrotone.it.
[cclii] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 317-321.
[ccliii] AVC, “Privilegio dello Sacro Episcopato della città dell’Isula, in Processo grosso di fogli cinq.cento settanta due della lite, che Mons. Ill.mo Caracciolo ha col S.r Duca di Nocera per il Vescovato”, ff. 417 e sgg.
[ccliv] Ruggero Borsa compare in qualità di duca d’Italia, di Calabria e di Sicilia (δουϰός ἰταλίας ϰαλαβριας ϰαὶ σικελίας) in un atto del 1091. Trinchera F., Syllabus cit., p. 68 n. LII.
[cclv] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 141-144.
[cclvi] “Praeterea, libertates, et inmunitates a bonae memoriae duce Rogerio, et Riccardo Senescalco, et aliis principibus eccl(esi)ae tuae cl(er)icis ratio(nabilite)r concessas, et hactenus observatas, videlicet ut ipsi cl(er)ici ab omni laicali exactione liberi sint penitus, et absoluti, ratas habemus, et eas futuris temporibus illibatas permanere sanceimus.” AASS, pergamena 001. AASS, 22A. “Nell’aver dunque il Pontefice nominati insieme il Duca Rogerio con Riccardo Senescalco devesi ragionevolmente alcche i Donatori siano stati Rogerio Duca di Puglia figlio di Roberto Guiscardo e Riccardo suo Senescalco figlio di Dragone Conte di Venosa …” AASS, 84A.
[cclvii] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 27-30.
[cclviii] “Da Pietrapaola a ’.b.shrû (Ipscrò, oggi Cirò) trentare miglia. Tra Cirò a rûsyânû (Rossano) la marittima quindici miglia. Da Rossano a śant mawrû (San Mauro) cinque miglia. Tra San Mauro ed il mare sei miglia.”. (…) E da San Mauro a b.snîân (Bisignano) nove miglia.” Amari M. e Schiapparelli C., cit., p. 112. Il luogo risulta menzionato “in Calabriam”, anche nella cronaca di Romualdo Salernitano (Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1845, vol. I, p. 5) mentre, sappiamo che al tempo di re Guglielmo I, in occasione della conferma di tutti i privilegi e di tutte le donazioni fatte alla Chiesa di S. Maria di Valle Giosafat dal re Ruggiero suo padre, e da parecchi baroni, tanto nella Puglia che in Calabria e Sicilia, figura: “in calabria in rossanensi parrochia iuxta castrum s(anc)ti mauri eccl(esi)am b(e)ate marie”. Archivio di Stato di Palermo, Diplomatico, Tabulario dei monasteri di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat e di San Placido di Calonerò, TSMG 0047, consultato attraverso www.archivi-sias.it. Sull’incerta identificazione del castello di San Mauro, Maone P., San Mauro Marchesato e le sue vicende attraverso i secoli, Catanzaro 1975, pp. 45 e sgg.
[cclix] Delaville Le Roulx J., Cartulaire Général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1110-1310), Parigi 1897, tome second (1201-1260), pp. 900-901.
[cclx] Crocenti G., Mabilia contessa di Oriolo in Calabria Letteraria 7/9, 1985, pp. 122-124. Nel cognome di Guglielmo, corrotto nei documenti che, in diversi casi, furono tradotti dal greco al latino, rimane, probabilmente, quello della sua importante consorte.
[cclxi] Pontieri E., Tra i Normanni nell’Italia meridionale, Napoli 1964, p. 169.
[cclxii] Goffredo Malaterra, cit., pp. 99-101.
[cclxiii] Ménager L. R., Inventaire des Familles Normandes et Franques Emigrées en Italie Méridionale et en Sicilie XI – XII siecles, in “Roberto il Guiscardo e il suo Tempo, Relazioni e comunicazioni nelle Prime Giornate normanno-sveve”, Bari maggio 1973, pubblicato a cura del Centro di Studi Normanno-Svevi, Università degli Studi di Bari, in Fonti e Studi del Corpus mambranarum italicarum XI, Roma 1975, p. 317.
[cclxiv] Nel maggio del 1097, il duca Ruggero confermava alla SS. Trinità di Venosa, le donazioni e le concessioni fatte da “Guilielmus Grandemanillus”, della chiesa di “sancte marie de Roccecta que est super fluvium cochili in tenimento Castrovillari”, assieme agli uomini, i possessi ed i diritti. (Del Giudice G., Codice Diplomatico del Regno di Carlo I e II d’Angiò, Napoli 1863, app. I n. X, pp. xxiv-xxvii.
[cclxv] Nel gennaio del 1114 (a.m. 6622), Filippo figlio del visconte e cavaliere del dominus Guglielmo Grantemani (ϰυρ γουδελμου γραντεμανι), donava al monastero di S. Pietro di Altomonte, obbedienza della SS. Trinità di Cava, delle terre a Oriolo. Trinchera F., Syllabus cit., pp. 99-100 n. LXXVI. Nel settembre 1117 (a.m. 6626), la contessa Mabilia, domina di Oriolo e moglie del defunto protosebasto Guglielmo Grantemanil (γουλλιἔμου γραντεμανὴλ), assieme a suo figlio Guglielmo iuniore (γουλιἔμου γραντεμανὴλ), donavano alla SS. Trinità di Cava, la chiesa di S. Petro di Altomonte, con il casale e le pertinenze. Trinchera F., Syllabus cit., pp. 108-110 n. LXXXIII.
[cclxvi] Nell’agosto del 1122 (a.m. 6630), “Mabilia, et Guillelmus Granti Maniliae filius”, donavano al dominus Bartholomeo, abbate del “Sancti Monasterii venerandae Dominae nostrae Dei genitricis de Neanova odigytrea”, le “nostras culturas praediorum, quae habemus in medio duorum fluviorum Cratis, et Conchili”. Ughelli F., Italia Sacra, t. IX, 292.
[cclxvii] Nel gennaio del 1130, la contessa Mabilia “uxoris quondam Guillelmi protoplasto de Gratamanilla”, donava delle terre all’abbazia di Santa Maria della Matina, poste “in tenimento Sagicte”. Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 34-35.
[cclxviii] Pesavento A., La chiesa di San Costantino in territorio di Isola, www.archiviostoricocrotone.it.
[cclxix] Trinchera F., Syllabus cit., pp. 138-141 n. CVI. Il documento è riportato anche da Martire D., Calabria Sacra e Profana Vol. I, Cosenza 1876, pp. 212-214.
[cclxx] Ughelli F., Italia Sacra, t. IX, 481-482. “Al medesimo monasterio Manilia stessa, l’anno 1131 (sic) conferma la donazione fattagli da Giovanni, vescovo dell’Isola, della chiesa di S. Costantino, e ’l privilegio concedutogli da Roberto suo padre, che pasca liberamente i suoi animali di qualunque maniera ne’ territori di Cotrone e dell’Isola.” Fiore G., Della Calabria Illustrata II, p. 585-588.
[cclxxi] “Egli morì l’anno quattrocento novantaquattro (nov. 1100 ad ott. 1101) in provincia di Calabria, nella rocca di Mileto e quivi fu sepolto.” (Amari M. e Schiapparelli C., cit., p. 24.
[cclxxii] “Comes vero Roggerius, audita morte W[illelmi] ducis, qui eum heredem instituerat …”. Romualdi Salernitani Chronicon, in Muratori L.A., Rerum Italicarum Scriptores, vol. VII parte I, p. 214.
[cclxxiii] “Medietatem suam Palermitanae civitatis, et Messanae, et totius Calabriae Dux ille eidem Comiti concessit, ut ei super his omnibus auxilium largiretur. Continuo sexcentos milites, et quingentas uncias auri ei largitus est.” Falconis Beneventani Chronicon, in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1845, vol. I, p. 186.
[cclxxiv] Falconis Beneventani Chronicon, in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1845, vol. I, pp. 193 e sgg.
[cclxxv] “Mense iunii eodem indictione dum castellum Obmanum, iussione Rogerii comitis Siciliensis a comitibus Calabrie, id est Alexandro Senesii et a Robberto Grandi-Maruli et aliis multis …”. Romualdi Salernitani Chronicon, in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. VII parte I, pp. 215, 391. “Ruggiero colla moglie Giuditta nel 1127 si chiude nel castello di Omignano, assediato dai conti di Calabria per ordine di Ruggero II di Sicilia, ma è vinto”. Ibidem, p. 397.
[cclxxvi] “Robertus de Grantimania licentiam ad sua redeundi rogat, qua negata a Rogerio recedit” (Alexandri Telesini Coenobii Abbatis de Rebus Gestis Rogerii Siciliae Regis Libri Quatuor, in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1845, vol. I p. 97. “Dux Lacupesulum vadit, Robertum de Grantimania qui a militia recesserat, arguit, et ad propria redire permittit.”. Ibidem, p. 99.
[cclxxvii] Ibidem, p. 100.
[cclxxviii] La notizia riportata dal Pontieri, risulta tratta dal libro del Minieri Riccio, Saggio di Codice diplomatico, Napoli 1878. Mor C. G., Riflessi Bizantini nella Organizzazione Calabrese Avanti la Proclamazione del Regno, in Atti del 4° Congresso Storico Calabrese a cura della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Napoli 1969, p. 388, nota n. 17.
[cclxxix] Romualdi Salernitani Chronicon, in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. VII parte I, p. 226. Relativamente all’anno 1140, Falcone Beneventano riferisce che, riunita la curia presso la città di Ariano, Ruggero II, emanò alcune norme: “… Arianum civitatem advenit, ibique de innumeris suis actibus Curia Procerum, et Episcoporum ordinata tractavit.”. Falconis Beneventani Chronicon, in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1845, vol. I, p. 251.
[cclxxx] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 48-51.
[cclxxxi] Pratesi A., Carte Latine cit., p. 53-55.
[cclxxxii] Jamison E., Note e documenti per la storia dei conti normanni di Catanzaro, in ASCL a. I, 4, Roma 1931, pp. 465-470.
[cclxxxiii] De Leo P., Documenti cit., pp. XXIX e 7-8.
[cclxxxiv] “Nono Kalen. Junii Terremotus adeo magnus, et terribilis fuit per totam Calabriam in Valle de Grati, et vallem de Sinu. Ecclesiae omnes, et omnia aedificia murorum corruerunt, et Rufus Cusentinus Archiepiscopus, et multi alii sub murorum praecipitio suffocati sunt.” (Anonymi Monachi Cassinensis Breve Chronicon, in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1845, vol. I p. 470.
[cclxxxv] De Leo P., Dalla Tarda Antichità all’Età Moderna, in Crotone Storia Cultura Economia, 1992, p. 138.
[cclxxxvi] Capasso B., Sul Catalogo dei Feudi e dei Feudatari delle Provincie Napoletane sotto la Dominazione Normanna, Napoli 1868,, pp. 321-322 e nota 1.
[cclxxxvii] Secondo le valutazioni del Capasso, la compilazione del documento sarebbe da circoscrivere al periodo 1154-1169. Esso sarebbe infatti “il complesso di vari quaderni”, “compilati prima del 1161, ed indi rifatti non più tardi del 1168”. Capasso B., Sul Catalogo cit., pp. 319 e 328 e sgg.
[cclxxxviii] “Mancano poi interamente, né per verità dovevano starci, le Calabrie, le quali allora ed anche per parecchi anni dopo facevano amministrativamente parte della Sicilia, e non del ducato di Puglia; conseguenza della prima divisione fatta dopo la conquista Normanna tra Roberto Guiscardo, ed il gran Conte Ruggiero, indi verso i primi anni Angioini distrutta.” Capasso B., Sul Catalogo cit., p. 309.
[cclxxxix] Ibidem.
[ccxc] “… il ridottato re Ruggiero, esaltato da Dio, potente per divina grazia, re di Sicilia, Italia, Longobardia e Calabria, sostegno del pontefice di Roma e difensor della religione cristiana; [ben così detto] poiché egli avanza il re dei rûm (il sovrano bizantino) per [estensione] di territorio e nerbo [d’imperio] …”. Amari M. e Schiapparelli C., L’Italia descritta nel “Libro di Re Ruggero” compilato da Edrisi, in Atti della Reale Accademia dei Lincei anno CCLXXIV, 1876-77, serie II – volume VIII, Roma 1883, p. 2.
[ccxci] “Questo terzo compartimento del Clima quinto abbraccia quel tratto [di paese] nel quale giacciono le terre di Calabria e di Longobardia (Principati longobardi) e la maggior parte del golfo dei Veneziani (Adriatico) …”. Amari M. e Schiapparelli C., cit., p. 99.
[ccxcii] “Le città che abbiam [testè] ricordate e le castella famose [delle quali abbiam fatta menzione] son tutte a un dipresso valide fortezze e grosse terre alle quali fa capo ogni genere di commercio. Ferace oltremodo è il loro suolo e su la loro difesa può farsi assegnamento. Il maggior numero di esse, e diciam pur tutte, fan parte della qillawrîah (Calabria) e della bûlîah (Puglia), come s’addimandano [due] territorii o provincie [che dir si vogliano ciascuna] delle quali comprende molti paesi.” Amari M. e Schiapparelli C., cit., p. 111.
[ccxciii] Ibidem, p. 103.
[ccxciv] Ibidem, p. 100.
[ccxcv] Ibidem, p. 12.
[ccxcvi] Ibidem, p. 101.
[ccxcvii] Ibidem, p. 16.
[ccxcviii] Ibidem, p. 79. In un altro passo, Edrisi afferma anche che la penisola di Sorrento, fa parte della Calabria. Ibidem, p. 19.
[ccxcix] “Metropolis Regium hos habet suffraganeos episcopos: Cassanensem, Neocastrensem, Catacensem, Crotoniensem, Tropiensem, Opiensem, Bovensem, Geratinum. Metropolis Cosentia hos habet suffraganeos episcopos: Marturanensem. Metropolis Rossanun nullum suffraganeum episcopum habet. Metropolis Sancte Severine hos habet suffraganeos episcopos: Hembriacensem, Stroniensem, Genecocastrensem, Cotroniensem, Gerentinum.”. “Hii sunt Collaterales et Consecratores Romani Pontificis. (…) In Calabria. Bisignanensis, episcopus Sancti Marci, Squillacensis, Miletensis.” Fabre M. P., Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine V, Parigi 1889, pp. 104-105.
[ccc] De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 44-45, 123-130, 143-145. Reg. Ang. IV, p. 159.
[ccci] Reg. Ang. XIII, p. 267; Reg. Ang. XVII, pp. 57-58. Campanile F., L’armi Ovvero Insegne Dè Nobili, 1610, p. 280. ASV, Reg. Vat. Vol. 355, ff. 287-288.
[cccii] Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, pp. 293-303.
[ccciii] Amari M. e Schiapparelli C., cit., p. 128.
[ccciv] “Ebriacensem, Giropolensem, Geretinensem, [Geneoc]as[tr]ensem et Lesim[anensem.]”. AASS, pergamena 001. “Ebriacensem, Giropolensem, Gerentiensem, Gereocastrensem et Lesimanensem.” AASS, 22 A.
[cccv] Guillou André, Le Brébion cit., pp. 62 e 188.
[cccvi] “Ultimus pullus aquile casurus erat sub petra roseti : et hac de causa rex ipse pertimebat de petra roseti, quod est locus calabriae, et propterea nunquam abinde transitum volvit habere : locus enim ille conterminat ab appulis calabros, et e contra.” Bartolommeo di Neocastro, in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1868, vol II, p. 421.
[cccvii] Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, p. 649, 667, 670, 724.
[cccviii] “prelatis ecclesiarum, justiciariis, magistris camerariis, camerariis, bajulis, castellanis et universis officialibus a porta Roseti usque ad fines regni constitutis”. “Andree de Cicala fidelis nostri, constituimus eum capitaneum et magistrum justitiarium a porta Roseti usque ad fines regni”. “Roggerio de Amicis a porta Roseti usque Farum et per totam Siciliam [capitaneo et magistro justitiario statuto.]”. Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, pp. 950-951.
[cccix] “videlicet praedictus Archipresbyter per introitum Morani, et Oddo Marchio de Honebruch, cui Comitatus Catanzarii per Papam concessum erat, per introitum Pontis (sici) Roseti, Vallisgratae fines intrasset. … Item quod duodecim galeae Brundusinorum venissent ad maritimam Cutroni ad partes Terrae Jordani”. Jamsilla N., in Del Re G., Cronisti e Scrittori Sincroni Napoletani editi ed inediti 1868, vol II p. 181. “Fu l’ultimo del 1294 cogli altri presentato ad Ameraco de Possiaco milite, padrone di Strongolo, regio capitano e giustiziero della Calabria ‹‹et Terrae Joardanae usque ad flumen Gratis, nec non secreto» maestro portulano e procuratore e maestro del sale di tutta la Calabria.”. De Leo P., Documenti cit., p. XXVI e nota n. 152.
[cccx] Reg. Ang. XXIII, pp. 269-270.
[cccxi] “Lambertus regiae Curiae praepositus et principalis magister camerarius ac magnus Iudex totius Calabriae, Sinni, Laini et regionis Iordani”, Trinchera F., Syllabus cit., p. 322 n. CCXXXIX. “… in una carta del 1195 di Enrico VI peraltro Imperatore Svevo, sistente nel grande Archivio della Zecca, la quale contiene la confinazione della Grangia di S. Fantino fatta per ordine di Lamberto si legge: Lambertus imperialis aule princeps et Capitaneus Magister Camerarius adque Iusticiarius tocius Calabrie sinni et Layni et terre Iordanis.” Giustiniani L., Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797, vol. I, p. CXXIII, nota 4.
[cccxii] Nel 1195, Enrico IV su richiesta di “Bartholomei de Lucy, Comitis Paternionis, magistri iustitiarii tocius Calabrie, Fidelis Nostri”, conferma al monastero di Tremestieri di Messina alcuni beni siti in Sicilia. Böhmer J. F., Regesta Imperii IV, 3.1 ed. Baaken 1972, p. 164 n. 402. Sito www.regesta-imperii.de.
[cccxiii] De Leo P., Documenti cit., pp. 221-225; Ughelli IX, coll. 198-200.
[cccxiv] De Leo P., Documenti cit., p. XXXI.
[cccxv] “illustri viri Simonis de Mamistra regii Calabriae magistri iustitiarii”. De Leo P., Documenti cit., pp. 16-17.
[cccxvi] “Stephanus Marchisortus Dei et regia gratia comes Cotroni, capitaneus et magister iusticiarius Calabriae”, De Leo P., Documenti cit., pp. XXXII e 54-55. “Stephanus Marchisortus Dei et regia gratia comes Cotroni, capitaneus et magister iustitiarius Calabriae”, Ibidem, pp. 61-62. “Stephanus Dei et regia gratia comes Cotroni, capitaneus et magister iustitiarius Calabriae”, Ibidem, pp. XX e 65-66.
[cccxvii] In un atto del 1215, risulta che Gaytigrima, figlia di Guilielmi Criti de Bisiniano, abitava “in Calabria in civitate Genicocastri”. Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 256-257.
[cccxviii] Russo F., Regesto I, 446.
[cccxix] Russo F., Regesto I, 448.
[cccxx] De Leo P., Documenti cit., pp. 47-49.
[cccxxi] “molte … vecchie mitre piccole di tela, che da quelle si prende testimonianza che in tempo antico li canonici di quella chiesa siano stati mitrati”. ASV, Rel. Lim. S. Severina, 1603.
[cccxxii] Pratesi A., Carte Latine cit., pp.170, 283.
[cccxxiii] Il 14 agosto 1386, in Policastro, in occasione della stesura del proprio testamento, il nobile Simeone de Bondelmonti di Firenze, istituiva alcuni legati, tra cui quello in favore del clero latino e di quello greco di Catanzaro: “item clero Latinorum Catacensium uncias duas et clero Grecorum unciam unam”. www.archiviodistato.firenze.it.
[cccxxiv] Per un approfondimento su questo diritto, Carnì M., Il Diritto Metropolitico di Spoglio sui Vescovi Suffraganei, Torino 2015.
[cccxxv] De Leo P., Documenti cit., pp. 99-101, 102-103, 123-130.
[cccxxvi] De Leo P., Documenti cit., pp. 226-227; Ughelli IX, coll. 197.
[cccxxvii] De Leo P., Documenti cit., pp. 18-19.
[cccxxviii] De Leo P., Documenti cit., pp. 9-10, 11-13, 29-31, 88-89, 99-101 e 102-103, 123-130.
[cccxxix] “Privilegium Federici [II] regis Siciliae quod monasterium libere possit cavare et percipere meneras ferri, per omnes meneras Calabriae et in suo tenimento nova invenire perpetuo possidenda et molendinum edificare in tenimento Acherentiae, anno 1210.” De Leo P., Documenti cit., p. XXXV.
Nel maggio del 1210, in Messina, Federico II, concedeva a “Matheae venerabilis abbas et conventus Floris”, di poter “cavare et percipere meneram ferri per omnes meneras Calabriae. Si vero infra tenimenta eiusdem monasterii Floris menera ferri poterit inveniri, ipsam meneram ferri” concedeva e donava liberamente in perpetuo senza alcuna esazione. De Leo P., Documenti cit., pp. 42-43.
“Privileg. eiusdem Rom. Imp. super confirmatione omnium granciar. et concessione cavandi mineras etiam in tenimento Abbatiae, ac aedificandi molendinem in tenimento Acherentiae. In Anno 1219.” Siberene, p. 219.
“Privilegium Federici Romanorum regis super confirmatione omnium granciarum et concessione cavandi mineras etiam in tenimento abbatiae ac aedificandum molendinum in tenimento Acherentiae et loco de Bordò, anno 1219.” De Leo P., Documenti cit., p. XXVIII.
Nell’aprile del 1219, in Basilea, Federico II confermava i possedimenti del monastero, con la possibilità di “cavare et percipere meneram ferri per omnes meneras Calabriae” e di possedere in perpetuo le miniere che fossero state rinvenute nei suoi tenimenti. De Leo P., Documenti cit., pp. 80-82.
[cccxxx] De Leo P., Documenti cit., pp. 221-225; Ughelli IX, coll. 198-200.
[cccxxxi] In questo periodo, la distinzione tra Calabria e Valle Crati, continua a ricorrere sia implicitamente (“per totam Calabriam”, De Leo P., Documenti cit., p. 86), che in maniera esplicita (“Universis Calabriae et Vallis Gratis archiepiscopis, episcopis, comitibus”, Ibidem, p. 87.).
[cccxxxii] De Leo P., Documenti cit., pp. 92-93.
[cccxxxiii] De Leo P., Documenti cit., pp. 104-105.
[cccxxxiv] De Leo P., Documenti cit., pp. 109-112.
[cccxxxv] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 256-257.
[cccxxxvi] “Alexander comitatus prefati iusticiarius”. Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 309-312.
[cccxxxvii] “Alexander de Policastro, imperialis Calabrie et terre Jordane justitiarius”, Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1852, Tomo II pars I, pp. 519-522. “… e fu a suo tempo e proprio nel gennaio del 1226 che trovandosi in Mileto Alessandro di Policastro Giustiziere imperiale della Calabria, e della Terra Giordana …”, Capialbi V., Memorie per servire alla Storia della Santa Chiesa Militense compilate da …, p. 20. “Judicatum Alexandri de Policastri Imperialis Justitiarii Calabrie et Terre Joardani …”, Capialbi V., Opuscoli Vari, p. 189.
[cccxxxviii] “domine Alexander de Policastro imperialis iusticiarie Calabrie et Vallis Gratis”. Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 364-366.
[cccxxxix] Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, pp. 689-691, 789-790, 794. Costitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae Mandante Friderico II Imperatore … et Fragmentum Quod Superest Regesti Eiusdem Imperatoris Ann. 1239 et 1240, Neapoli ex Regia Typographia 1786, p. 404. Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II p. 929.
[cccxl] Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1854, Tomo IV pars I.
[cccxli] “… per loca Apulie, Calabrie et Principatus, …”, Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1854, Tomo IV pars I, p. 310. “… in cathedralis ecclesiis Sicilie et Calabrie …”, Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1855, Tomo IV pars II, p. 907. “… partes Calabrie et Sicilie …”, Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, p. 691. “Item in Sicilia, Calabria, Apulia et Principatu …”, Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, p. 1223.
[cccxlii] “statutum provisorem castrorum Sicilie citra flumen Salsum et totius Calabrie usque ad portam Roseti.” Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, p. 413.
[cccxliii] Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1854, Tomo IV pars I, pp. 460-462.
[cccxliv] “ad justitiarios, secretos, magistros camerarios, portulanos et universos officiales per totatm Siciliam, Calabriam, terram Jordanem, valle Gratis, Principatus et Terram Loboris statutos.”. Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1857, Tomo V pars I, p. 637.
[cccxlv] Winkelman E., Acta Imperii Inedita Seculi XIII, Innsbruck 1880 pp. 629 n. 810.
[cccxlvi] Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1857, Tomo V pars I, pp. 606-623.
[cccxlvii] Costitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae Mandante Friderico II Imperatore … et Fragmentum Quod Superest Regesti Eiusdem Imperatoris Ann. 1239 et 1240, Neapoli ex Regia Typographia 1786, p. 404. Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II p. 929.
[cccxlviii] Ughelli F., Italia Sacra, t. IX, coll. 476-478.
[cccxlix] Il documento conservato all’Archivio Arcivescovile di Santa Severina, ma non archiviato, risulta attualmente tra quelli in attesa di restauro.
[cccl] De Leo P., Documenti cit., pp. XX, XXIV, XXXIII, 146-147, 152-154, 155-157, 158-160.
[cccli] De Leo P., Documenti cit., pp. 138-140.
[ccclii] Reg. Ang. XX, p. 249.
[cccliii] Per l’elenco delle terre appartenenti ai due giustizierati fino a questo periodo: Reg. Ang. XIII, p. 267; XVII, pp. 57-58. Minieri Riccio C., Notizie Storiche tratte da 62 Registri Angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, 1877.
[cccliv] “Catensarium, Taberna, Scilla, Symerus, Barbarum, Genico castrum, Mausurica cum casalibus ipsarum terrarum, Policastrum, Tracina, Castella, Rocca Bernarda, Sancta Severina cum casalibus suis, Sanctus Iohannes de Monacho, Cotronum cum casalibus suis.” Reg. Ang., XXII, p. 89 e XXXVI, p. 81.
[ccclv] Reg. Ang. XXIII, pp. 269-270.
[ccclvi] De Leo P., Documenti cit., p. XXVI e nota n. 152.
[ccclvii] In un atto del 25 settembre 1346 stipulato in San Giovanni in Fiore, troviamo “Petromarius iudicis Guiscardi de Petrafitta, publicus per totam provinciam Vallisgratis et Terrae Iordaniae (sic) authoritate regia notarius”. De Leo P., Documenti cit., pp. 180-182.
[ccclviii] “Instrumentum super possessione tenimenti 1319, de Fiuca 1315”. “Pel territorio denominato Fluce sito tra i fiumi Neto e Vitrabo già conceduto al munistero di Fiore dall’imperatore Federigo II, ebbe il munistero suddetto una controversia con Andrea de Mesuraca de Strongolo, la quale dedotta dinanzi al giustiziero della Valle di Grate e della Terra Giordana Nicola di Plumbarola milite, fu dal medesimo e dai suoi giudici nel dì primo febbraio 1315 nella terra di Ypsigrò, dopo veduti ed osservati i privileggi del munistero ed altre scritture delle parti, ed intese le medesime, decisa in pro del munistero ed imposto ad Andrea perpetuo silenzio, presenti Guglielmo vescovo di Umbrjatico e moltissimi testimoni. Della qual decisione e di quanto occorse per la medesima se ne rogò pubblico instromento da notar Simeone de Spetiano della Terra di Ypsigro”. De Leo P., Documenti cit., p. XVI.
[ccclix] De Leo P., Documenti cit., pp. 166-169.
[ccclx] De Leo P., Documenti cit., pp. 174-176.
[ccclxi] De Leo P., Documenti cit., pp. 183-184, 185-189, 254-256, 257-262.
[ccclxii] De Leo P., Documenti cit., pp. 177-179.
[ccclxiii] De Leo P., Documenti cit., pp. 170-172.
[ccclxiv] “Magnifico Nicolao Ruffo Comiti Catanzarii Consiliario privilegium concessionis tituli Marchionis super eius civitate Cutroni attenta eius claritate generis et servitiis prestitis Regi Carolo tertio patri nostro et nobis, qui debeat investiri per vexillum ut moris est per Magnificos Henricum de Sancto Severino militem Bellicastri et Carolum Ruffum Montis Alti et Coriliani Comites consanguineos, Iordanum de Arenis baronie Arenarum utiliter dominum et Benedictum de Aczarolis militem Consiliarios, seu duos vel unum ex ipsis prout eis aptitudo dabit. Sub datum Gayete die 18 octobris 14 Indict. An. 1390. Reg. 1390 B. n. 362 fol. 21t.”. Minieri Riccio C., Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell’archivio di stato di Napoli, Napoli 1877, p. 99.
[ccclxv] “… Cotroni cum marchionatus ac Catanzarii civitatis, cum comitatus dignitate / titulo et honore huiusmodi quae marchionatus et comitatus dignitatis titulos et honores, necnon Cotroni marchionatum et catanzarii comitatum / intregros ipsiusque et cotroni Civitatem predictarum Casalia districtus jura / jurisditiones et pertinentias universa ac ypsigro cum pertinentiis Aligii melixe / feudi s(an)cti stephani et policastri Rochebernardi mesurace castellorum / maris Tacine et s(an)cti mauri de Caraba Roche s(an)cti Juliani Gimiliani / Tirioli et Rosauni terras (cum Cutri s(an)cti Johannis de monacho papanichifori Cromiti Apriliani mabrocoli misicelli lachani Crepa / coris massanove et turisinsula Casalibus) necnon castri maynardi / Barbari cum Cropano ac sancti niceti Baronias cum pertinentiis / et fortellitiis earumdem. Item quoque Castrivetus cum membro / tenimento placanice Et cultura s(an)cti fili ac favato et pellacano Ad / terram roccelle s(an)cti victoris de provincia calabria citra et ultra nec / non Cabellam sete predicte civitatis Catanzarii et aliorum locorum / eidem marchioni iam dudum per Carolum iij Bonamemorie concessas et / Concessa Ac ladizlaum eiusdem regine germanum sucessive Jherusalem et / sicilie dive memorie reges confirmatas et confirmata, … necnon / eadem marchioni terram que dicitur taberna Catacen(sis) dioc(esis) …”. ASV, Reg. Vat. Vol. 355, ff. 287-288.
[ccclxvi] “Polissena, nel 1417, otteneva dalla Regina Giovanna il «mero e misto imperio» su numerosissime terre di Calabria, tra cui Cariati, Scala, Verzino, Rocca di Neto, Campana, Bocchigliero, Cerenzia, Caccuri. Esse formavano già o formarono in seguito, unitamente ad Umbriatico, «lo Stato» di Cariati.” Maone P., La contea di Cariati, in ASCL. 1963, fasc. III-IV, p. 318.
[ccclxvii] Pesavento A., Metamorfosi in un territorio, in La Provincia di Crotone, 1999, p. 18.
Creato il 7 Febbraio 2017. Ultima modifica: 15 Dicembre 2017.